V13: l’orrore del Bataclan e la sconfitta di tutti!
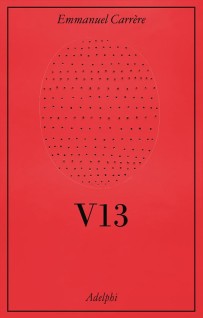
Propongo di seguito un articolo che ho scritto per il numero di aprile del mensile La Luce.
Il numero del mensile si intitola: Liberi tutti; la guerra ridisegna gli equilibri mondiali.
L’articolo è una recensione del testo, di Emmanuel Carrère V13, sullo storico processo agli attentatori del Bataclan.
Clicca qui per visitare il sito de La Luce, qui per abbonarti al mensile.
Buona lettura!
Manuel Olivares
Scandito in tre parti — “Le vittime”, “Gli imputati”, “La corte” —, V13 raccoglie, rielaborati e accresciuti, gli articoli (apparsi a cadenza settimanale sui principali quotidiani europei) in cui Emmanuel Carrère ha riferito le udienze del processo ai complici e all’unico sopravvissuto fra gli autori degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015 — attentati che, tra il Bataclan, lo Stade de France e i bistrot presi di mira, hanno causato centotrenta morti e oltre trecentocinquanta feriti. Ogni mattina, per quasi dieci mesi, Carrère si è seduto nell’enorme “scatola di legno bianca” fatta costruire appositamente e ha ascoltato il resoconto di quelle “esperienze estreme di morte e di vita” — le testimonianze atroci di chi ha perduto una persona cara o è scampato alla carneficina strisciando tra i cadaveri, i silenzi e i balbettii degli imputati, le parole dei magistrati e degli avvocati —, e lo ha raccontato, come solo lui sa fare, senza mai scivolare nell’enfasi o nel patetismo, e riuscendo a cogliere non solo l’umanità degli uni e degli altri (sconvolgente, ammirevole o abietta che fosse), ma anche, talvolta, la quasi insostenibile ironia dei discorsi e delle situazioni.
Emmanuel Carrère, V13, Adelphi, 2023, sec. di copertina
Per come sto conoscendo Emmanuel Carrère, lo definirei un autore alquanto “psicoanalitico”. Mette spesso la sua vita privata al centro delle sue narrazioni, sminuzzandola e analizzandola “in piazza”. In questo suo “viaggio al termine dell’orrore e della pietà”, per citare nuovamente la seconda di copertina di V13, è come se psicoanalizzasse un evento — o una serie di eventi — in cui possiamo ritrovare tante sfumature del lato oscuro dell’essere umano.
A partire dal titolo stesso del libro: V (che sta per venerdì) 13, nel nostro inconscio è facile suoni un campanellino d’allarme, eventualmente associato all’odore di carne umana bruciata, lo stesso dei celebri ghat crematori indiani dove si “inala letteralmente la morte” mentre frammenti impalpabili di corpi carbonizzati finiscono sui vestiti di chi vi transita o permane. Per assonanza mi vengono in mente i membri della setta hindu degli Aghori che trascorrono la maggior parte del loro tempo, in meditazione, nei campi crematori, per famigliarizzarsi con i lati più oscuri e terrifici del nostro essere; la lettura di V13 può essere quasi considerata una “moderata pratica Aghori”. Del resto, meditazioni sui cadaveri erano prescritte dallo stesso Buddha, il cui insegnamento indugiava non di rado — sostanzialmente per le stesse ragioni ovvero per lo sviluppo dell’equanimità — sul memento mori.
Un suo “tardo” discepolo, Shanti Deva, monaco buddhista dell’ottavo secolo e autore del poema Bodhicaryavatara scriveva:
«Vorrei andare a casa mia, nel cimitero e confrontare con gli altri scheletri il mio fragile corpo! Perché questo corpo diventerà così puzzolente che neppure gli sciacalli lo avvicineranno […]».
In: Ananda K. Coomaraswamy, Buddha e la dottrina del Buddhismo, p. 320.
Torniamo, tuttavia, ad un immaginario di fuoco, di roghi: chi non sa che venerdì 13 (ottobre 1307) è la data in cui ebbe luogo il famigerato arresto di tutti (o almeno della maggior parte de) i cavalieri templari presenti in territorio francese? All’arresto seguirono anni di interrogatori, torture, confessioni che vennero talora ritrattate e roghi, tanti roghi (ecco l’odore di carne umana bruciata), fino a quello del Gran Maestro Jacques de Molay (accusato, tra l’altro, di avere intrecciato rapporti con i musulmani in Terrasanta), l’11 o 18 marzo 1314. Questi, prima di morire tra le fiamme, maledì gli artefici dell’enorme epurazione: il re Filippo il bello e Papa Clemente V che lasciarono il mondo terreno pochi mesi dopo.
L’eliminazione fisica dei templari rimase un marchio impresso a fuoco nella storia di Francia (e non solo) e venerdì 13 sarebbe divenuto, dal giorno dell’arresto in massa dei membri del facoltosissimo ordine, sinonimo di sciagura e cattivo auspicio cui avrebbe addirittura fatto da corollario, a partire dagli anni ’80, una saga di film horror di dubbia qualità.
Immagino che alcuni siano scampati, in Francia, ai massacri di cui ci parla Emmanuel Carrère perché superstiziosi e abbiano dunque evitato di andare al concerto del Bataclan o alla partita dello Stade de France per evitare di muoversi un venerdì 13!
Eppure venerdì 13 novembre 2015 ha probabilmente marchiato, a sua volta, a fuoco la storia — recente — di Francia, al pari del suo omologo medievale. Otto anni dopo avrebbe avuto luogo il processo ai protagonisti degli attentati multipli di quel brutto giorno e siamo, dunque, nel vivo del testo di Carrère!
Il processo
«Si è detto e ripetuto che questo sarebbe stato il processo del secolo, un processo per la Storia, un processo esemplare».
(V13, p. 15)
Ha inizio l’8 settembre 2021 a l’Île de la Cité (Parigi), in una scatola di tamburato bianco costruita, per l’occasione, nell’atrio di un palazzo storico: quarantacinque metri di lunghezza, quindici di larghezza, senza finestre e in grado di contenere seicento persone. Sette milioni di euro la spesa dello stato francese per realizzarla. Le vittime sono, complessivamente, milleottocento. Oltre a chi, nel corso di quel famigerato venerdì 13, ha perso la vita, ci sono persone rimaste invalide, sfigurate, famiglie devastate, moltissimi casi di persone con sintomi da stress post-traumatico che devono essere indennizzate.
Unico sopravvissuto del commando, affiliato all’ISIS, protagonista dell’articolata azione terroristica in analisi: Salah Abdeslam, originario di Molenbeek (pur essendo di famiglia marocchina), famigerato “quartiere etnico” di Bruxeless, fratello di Brahim Abdeslam che, lo stesso venerdì 13, si è fatto esplodere nel caffè Comptoir Voltaire dopo una serie di attacchi presso due ristoranti, una pizzeria e un caffè tra il decimo e l’undicesimo arrondissement di Parigi. Attacchi che uccisero trentanove persone ferendone, gravemente, trentadue.
Al contrario di Brahim, Salah non si farà saltare in aria e diverrà dunque la “star” del processo.
Già il secondo giorno si agita nel box e gli viene concesso, pur brevemente, di parlare. Chiede “se sarebbe stata data la parola anche a quelli che vengono bombardati in Iraq e in Siria” (Ivi, p. 29). Interessante il commento di Emmanuel Carrère al riguardo:
«Quasi tutti abbiamo considerato questa uscita un atto provocatorio. L’argomentazione comunque mi ha fatto riflettere. È quella della difesa cosiddetta “di rottura”, teorizzata nel 1987 dal famoso e sulfureo avvocato Jacques Vergès in occasione del processo all’ufficiale nazista Klaus Barbie. D’accordo, diceva Vergès, Barbie ha torturato a Lione, ma l’esercito francese ha fatto altrettanto in Algeria. Perciò, ogni volta che voi direte tortura a Lione, la difesa risponderà tortura in Algeria».
(Ibidem)
Stessa tecnica, riflette Carrère, potrebbe essere utilizzata dalla giovanissima avvocatessa dell’unico attentatore sopravvissuto: Olivia Ronen anche se non crede questo accadrà. La corresponsabilità della Francia nei bombardamenti di Siria e Iraq che hanno provocato innumerevoli vittime civili è, del resto — riflette ancora Carrère — un fatto incontestabile, nella stessa misura in cui i “bombardamenti chirurgici” restino un mito. Studiando l’ordinanza di rinvio a giudizio, Carrère si sofferma su un riferimento ai “presunti massacri di civili che gli occidentali avrebbero compiuto nel corso dei loro bombardamenti” (p. 30).
Di seguito un nuovo commento dell’autore che credo meriti menzionare:
«Non sono un esperto, e tralascio la questione se la morte di mezzo milione di bambini iracheni, conseguenza diretta delle sanzioni americane, “valesse la pena”, come ha detto in una memorabile intervista la segretaria di Stato Madeleine Albright (“the price is worth it”), ma definire “presunti massacri di civili” quelli che sono indiscutibili massacri di civili non rende un buon servizio alla verità, né alla giustizia».
(Ibidem)
Io credo che un elemento fondamentale di tutta la tragica vicenda di V13 sia esattamente in queste scarne riflessioni! Ne emerge l’annosa questione dei due pesi e delle due misure: le vittime innocenti di un fronte di guerra “pesano” infinitamente di più di quelle del fronte avverso. A suo tempo mi piacque molto l’onestà intellettuale dello storico inglese Peter Frankopan che nel suo testo The Silkh Roads si soffermò sulla strage dei bambini iracheni a seguito delle sanzioni americane (un rapporto della FAO, presentato nel 1995, parlava di 567000 bambini iracheni sotto i cinque anni), sottolineando si tratti di una mole di vittime innocenti più che doppia di quella provocata dagli storici bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki che, sostanzialmente, chiusero la seconda guerra mondiale. In Iraq non arrivavano medicinali, nemmeno gli anestetici, quali risentimenti, soprattutto nel mondo arabo, può provocare una mostruosità del genere? Quale copertura mediatica ha avuto? Ed è solo la punta dell’iceberg, quanti articoli dovremmo scrivere sui crimini dei paesi occidentali in Medio Oriente?
Tutto questo, naturalmente, non può minimamente giustificare quanto è avvenuto nel corso dell’apocalittico venerdì 13, le cui conseguenze si è fatto carico di raccontare — a posteriori — Emmanuel Carrère. Le stesse descrizioni dei colpevoli (se Abdeslam è l’unico sopravvissuto tra chi ha compiuto materialmente gli attentati, alla sbarra con lui ci sono altri tredici “ragazzi” con diversi gradi di responsabilità) sono piuttosto impietose: figli di un ghetto metropolitano (a parte nel caso di tre dei complici giunti, direttamente, dalla Siria), vengono presentati, prima che si infilassero nel tunnel terroristico, come “smodatamente dediti all’hashish”, clienti abituali delle strutture carcerarie da cui entravano e uscivano “al ritmo rassicurante della microcriminalità” (p. 84). Il loro capo, Abaaoud, figlio di un commerciante relativamente facoltoso, “punta forte al casinò” e coinvolge anche Salah Abdeslam e di volta in volta qualcuno degli altri imputati in week end scioperati.
La fidanzata di Adbeslam, Yasmina, è preoccupata: «non le piacciono quei weekend a cui ovviamente non è invitata, e nei quali il fidanzato beve, gioca, rimorchia zoccole per kuffar» (p. 88).
Non mi sembra proprio qui si stia parlando di musulmani “modello”; quanto la causa islamica possa essere considerata una “foglia di fico” per coprire comportamenti semplicemente devianti giunti a degenerazione finale lo lascio giudicare a chi legge.
Certo, ad essere salomonici la stessa politica estera degli stati occidentali, alla luce di quanto ci siamo limitati ad accennare in precedenza, avrebbe dovuto essere, a sua volta, sul banco degli imputati per aver creato e continuare a creare (considerando, banalmente, la legge di causa-effetto) presupposti efferati che non possono non comportare il rischio di reazioni folli da parte di soggetti a dir poco borderline.
Io, del resto, non credo assolutamente alla “risposta armata” alle tante, mostruose ingiustizie quotidiane. Credo piuttosto, con John Lennon (tanto per citarne uno famoso), che il più grande rivoluzionario del Novecento sia stato il Mahatma Gandhi, capace di portare all’indipendenza il suo paese senza sparare neanche un colpo ma, mi rendo conto, è una questione di punti di vista!
Termino il libro di Carrère riflettendo su una delle tante interviste allo scrittore rumeno Émil Cioran che hanno composto un altro testo dell’Adelphi, Un apolide metafisico, in cui affermò — purtroppo a mio parere a ragione — che la storia (antica, recente; il concatenarsi di azioni umane nella cornice di fenomeni naturali, sempre più negletti) rappresenta l’antidoto all’utopia. Cioran era notoriamente nichilista e considerava gli utopisti degli ingenui. È tuttavia vero che frugando nella storia — “uno scandalo”, scriveva Elsa Morante, “che dura da diecimila anni” — di antidoti all’utopia se ne trovano a non finire perché gli uomini, che ne sono protagonisti, come scriveva un altro grande nichilista americano: Charles Buckowski, “non sono mai grandi come le loro idee” e la storia finisce dunque per essere, il più delle volte, la cartina di tornasole dell’abiezione, più che della nobiltà, umana. Preferisco tuttavia ostinarmi a ricordare la frase dell’anarchico Camillo Berneri, morto in Spagna nel corso della guerra civile degli anni Trenta (“ennesimo martire”, possiamo dire, “della storia”): L’utopista accende delle stelle nel cielo della dignità umana ma naviga in un mare senza porti!
Credo possa essere una boccata d’aria fresca dopo la lettura di un libro profondamente amaro che credo abbia evidenziato — pur in presenza di qualche “recupero” umano — solo tremende sconfitte, per tutti noi!
Manuel Olivares

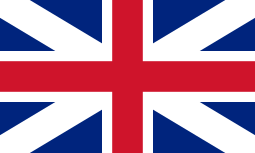 English
English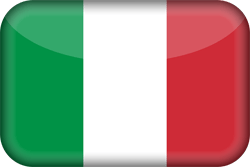 Italian
Italian