Prefazione a La storia vera e la vera storia
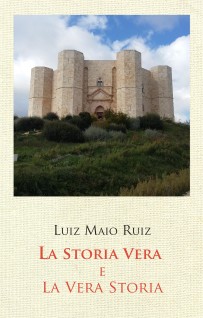
Non è facile scrivere una prefazione al testo La storia vera e la vera storia dell’amico Luiz Maio Ruiz, per l’intrinseca complessità dell’argomento ma in questi giorni — purtroppo dolorosamente insanguinati da una guerra infame — mi è capitato di leggere un articolo di Evelyne Pieiller: scrittrice, giornalista e sceneggiatrice francese oltre che membro della redazione de Le Monde diplomatique.
Il titolo viene a proposito: L’eterna fabbrica della storia. L’articolo inizia citando Emmanuel Macron il quale avrebbe scritto sulla sua pagina Facebook, riprendendo un estratto della sua intervista per il giornale tedesco Der Spiegel: Abbiamo urgentemente bisogno di una grande narrazione!
In effetti, oramai siamo un po’ a corto di narrazioni che siano “grandi”. Viviamo piuttosto nella dimensione di un, quotidiano, “minimalismo narrativo”. Sorprende che René Guénon abbia scritto La crisi del mondo moderno quasi un secolo fa e che, leggendolo oggi, sembra descriva perfettamente la decadenza di questi anni, spaventosamente critici anche e soprattutto perché svuotati di narrazioni degne di questo nome.
Non a caso, riporta ancora Evelyne Pieiller, Klaus Schwab — fondatore del Forum economico mondiale (il famoso Forum di Davos) — ha organizzato a Dubai, nel novembre 2021, un grande incontro finalizzato alla realizzazione di una Great Narrative.
Ma torniamo al titolo dell’articolo: L’eterna fabbrica della storia. Cos’è la storia (intanto non possiamo non chiederci, apprestandoci a leggere questo libro: quale storia?) se non una grande narrazione o, meglio, allargando un minimo lo sguardo: un groviglio di narrazioni, spesso incoerenti?
La storia è, difatti, una prospettiva sui fatti di un passato tanto remoto quanto recentissimo e, al pari di tutte le prospettive, cambia al cambiare delle coordinate spazio-temporali.
Prendiamo, ad esempio, la storia di un personaggio esemplare, fondatore di quella che sarebbe poi diventata la civiltà cristiana (a sua volta ricchissima di diversi angoli prospettici): Gesù di Nazareth.
Sappiamo tutti quale sia la “storia ufficiale” di Gesù…ma ne siamo proprio sicuri? Non mi addentro troppo in una tematica che verrà trattata dall’autore in questo testo (naturalmente dal suo angolo prospettico), mi limito a dire che mi è bastato spendere del tempo in India per constatare che, se per l’occidentale medio è assodato e inconfutabile che Gesù abbia sempre vissuto nel Vicino Oriente, in India è altrettanto assodato che il fondatore del cristianesimo abbia speso un congruo numero di anni in quella terra, dove si sarebbe formato in importanti centri sapienziali e avrebbe acquisito le cosiddette siddhi, forte delle quali avrebbe successivamente stupito i suoi conterranei con i miracoli riportati nei Vangeli.
Cambiando il nostro angolo prospettico, in Inghilterra è molto popolare (pur con tutta la discrezione di cui sanno essere capaci gli inglesi quando si impegnano) la tesi secondo cui Gesù avrebbe vissuto un periodo di ascesi a Glastonbury, non molto distante dall’attuale città di Bristol, nel Somerset.
Sarebbe, in principio, approdato in Cornovaglia con Giuseppe d’Arimatea (che poteva essere possibilmente un suo zio). Questi doveva almeno parte della sua ricchezza alla sua scaltrezza di mercante e frequentava periodicamente la costa sud-occidentale dell’attuale Inghilterra, seguendo rotte inaugurate dai fenici, per approvvigionarsi di stagno di cui era ricchissima quella terra.
In seguito Gesù, nel corso dei suoi lunghi “anni perduti”, stanco delle vicissitudini logoranti in Palestina (che, purtroppo, leggiamo ogni giorno non prende ancora pace), avrebbe deciso di ritirarsi, per un periodo di tempo, tra i silenzi brumosi dell’allora Albione, volendo anche approfondire le conoscenze dei druidi.
Ora, se l’ipotesi degli “anni indiani” di Gesù è fondamentalmente popolare tra gli hindu, dunque tra persone di confessione non cristiana, l’ipotesi del periodo di ritiro a Glastonbury non è solo popolare tra gli eccentrici seguaci della new age, viene sostenuta, pur — come si diceva — con discrezione, da molti devoti anglicani ed il celebre poeta inglese William Blake compose, nel 1804, la prefazione al proprio poema epico Milton facendo un esplicito riferimento alla possibile visita di Gesù alla sua terra.
Ne cito di seguito i primi versi, in inglese e in italiano:
«And did those feet in ancient time walk upon England’s mountains green? And was the Holy Lamb of God on England’s pleasant pastures seen? And did the Countenance Divine shine forth upon our clouded hills? And was Jerusalem builded here among these dark Satanic mills?».
«E quei piedi, nei tempi antichi, camminarono sulle verdi montagne d’Inghilterra? E fu visto il Santo Agnello di Dio tra i piacevoli pascoli d’Inghilterra? E il Divino Volto risplendette sulle nostre colline nebbiose? E fu costruita qui Gerusalemme tra questi oscuri mulini satanici?».
Oltre un secolo dopo, il 10 marzo 1916, Sir Hubert Parry mise in musica i versi di And did those feet in ancient time che — con il titolo più conosciuto di Jerusalem — avrebbero composto quello che Paul Ashdown definisce nel suo testo The Lord was at Glastonbury “the unofficial anthem of England” (l’inno non ufficiale d’Inghilterra). Dunque le vicende dell’approdo di Gesù, ancora poco più che bambino, in Cornovaglia con lo zio Giuseppe d’Arimatea e poi del suo ritiro a Glastonbury (dove avrebbe costruito una capanna di canniccio nel luogo in cui oggi sorgono i resti della celebre abbazia e dove avrebbe trovato sepoltura lo stesso Re Artù), lungi dall’essere considerate eretiche, in Inghilterra, sono confluite nel main stream, per usare ancora un termine inglese.
Senza voler essere assolutamente prosaico posso dire che quel che mi piace di più del testo di William Blake siano i punti interrogativi. Credo li dovremmo utilizzare molto di più nei titoli dei nostri libri e dei nostri articoli. Questo perché concordo con l’autore di questo testo sul fatto che “non si potrà mai elaborare una Storia «Oggettiva»”, tantomeno su personaggi-cardine come Gesù di Nazareth, di cui diversi nazionalismi vorrebbero, in qualche modo, appropriarsi. Come siano andate veramente le sue vicende umane e, direi, la generalità delle altre vicende dei tanti passati del mondo, non ci è dato, veramente, di sapere (ma non per questo non dobbiamo porci il problema, al contrario!). Ci restano le tante, piccole storie alla nostra portata, sottratte alle narrazioni di volta in volta strumentali al potere di turno, su cui possiamo avere, a Dio piacendo, maggiore potestà.
Credo non si debba dimenticare che la storia è, di volta in volta, una “storia di comodo” nella misura in cui la fabbrica della storia lavora in stretta sinergia con quella che Noam Chomsky definisce “la fabbrica del consenso”. Ci potrà essere mai una storia oggettiva?!
Il grande storico delle religioni Mircea Eliade vedeva nella storia “la grande corruttrice” e ammirava della cultura indiana (che aveva conosciuto da vicino — studiando tra il 1928 ed il 1931 presso l’Università di Calcutta e soggiornando per sei mesi, nel 1931, nell’ashram di Rishikesh — e raccontato in maniera magistrale) quello che potremmo definire “un profondo disincanto” nei confronti della stessa storiografia.
Parlando del concetto di maya [“illusione, illusione cosmica, miraggio, magia, divenire, irrealtà, eccetera”[1]] nella Bhagavad-Gita, nella premessa al suo Lo yoga, immortalità e libertà scrive quanto segue:
«La maya non è solamente illusione cosmica, ma anche e soprattutto storicità; non solo esistenza nell’eterno divenire cosmico, ma soprattutto esistenza nel Tempo e nella Storia. Per la Bhagavad-Gita, il problema si presentava, in parte come per il cristianesimo, in questi termini: come risolvere la situazione paradossale creata dal duplice fatto che l’uomo, da una parte, si trova nel Tempo ed è votato alla Storia, e d’altra parte sa che sarà “dannato” se si lascia esaurire dalla temporalità e dalla storicità — sa, di conseguenza, che deve ad ogni costo trovare, nel mondo, una via che sbocchi su un piano metastorico e atemporale»[2].
In attesa che voi, cari lettori, la troviate questa “stretta via”, vi lascio alla lettura delle diverse storie di cui è pregno questo libro. Potrete trovarle forse improbabili o forse vi potrete scorgere il filo rosso di quanto viene, provocatoriamente, indicato nel titolo come “la storia vera e la vera storia”.
Credo che, in fondo, abbia un’importanza del tutto relativa perché, seguendo Eliade, non credo che nella storia — espressione di tutti i limiti dello spazio-tempo — possa esservi salvezza.
In fondo, la storia — ovvero le narrazioni di comodo, indispensabili al lavoro della fabbrica del consenso — può essere vista come un grande gioco di specchi sul palcoscenico di dunya (termine arabo che designa il mondo temporale, con annesse tutte le possibili preoccupazioni terrene). Appunto: un miraggio, qualcosa che si presta alla scaltrezza di abili prestigiatori, un ingannevole velo della citata maya. Per citare ancora Eliade, forse più che al tempo storico dovremmo guardare al tempo ierofanico che sia, cioè, espressione del sacro.
Ma restiamo, per ora e con il presente libro, pur con sano disincanto, ancora nella storia.
Una e — fin troppo — molteplice.
Buona lettura!
Manuel Olivares
(Li 18/3/2022)
[1] Mircea Eliade, Yoga, immortalità e libertà, BUR, Milano, 1973, p. 13.
[2] Ivi, p. 14.

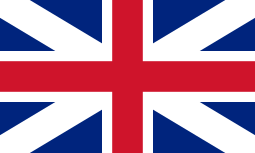 English
English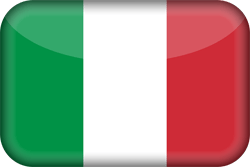 Italian
Italian