L’odore del viaggio

Lasciamo oggi il dovuto spazio ad un po’ di creatività letteraria. Di seguito un pezzo commissionato dalla scrittrice e poetessa Anna Manna per l’antologia L’Olfatto tra storia, scienza ed arte. Anna Manna ha curato un articolo/intervista sulla mia esperienza di “vivere altrimenti” per il numero di Ottobre/Novembre del LA, La Rivista del Lazio oltre ad aver firmato un bell’articolo critico sul testo della nostra editrice: Barboni si ma in casa propria.
Buona lettura!.
È luogo comune fastidiosamente abusato che il viaggio aiuti a conoscere se stessi.
Posso tuttavia confermare che attraverso diversi viaggi, in circa 39 anni di vita e soprattutto nel momento in cui il viaggio ha iniziato a coincidere con la mia quotidianità, sono giunto ad una visione/conoscenza addirittura “radicale” di me stesso, come “uomo molto orientale”!
Nato a Roma, città definita talora “levantina”, ho iniziato ad amare la dimensione del viaggio sul finire delle scuole superiori, vivendo i primi interrail, viaggiando ― zaino in spalla e sacco a pelo — con un economico biglietto ferroviario, valido per un mese, nell’Europa intera.
Sin da allora compresi, in tutte le mie cellule, le enormi potenzialità del viaggio per innestare un processo espansivo della coscienza. Dunque non solo, banalmente, le potenzialità formative ma quelle psichiche, antropologiche e di “crescita integrale”.
Nel periodo universitario l’attrazione per il viaggio ha iniziato a magnetizzarmi dall’Oriente, per un’esperienza più psichica, più antropologica e di più profonda crescita integrale.
Cito da un mio libro di prossima pubblicazione in cui, tra le altre cose, riporto alcune mie esperienze avute nel mio primo viaggio in India: «It is very hard Bombay, mi diceva [il tassista], iniziandomi all’inconfondibile aroma del betel che promanava dalla sua bocca». Era il 1998.
Ero appena giunto all’aereoporto di Bombay (oramai, da tempo, Mumbai) per dirigermi prontamente a Poona, nell’ashram di Osho Rajneesh e scrivere la mia tesi di laurea di sociologia delle religioni.
L’impatto con il paese fu molto “olfattivo”. Oggi gli aeroporti indiani (almeno i principali) sono degni di un paese che sta acquisendo, malgrado il persistere di molte sue contraddizioni ed inadeguatezze, un’indiscutibile centralità politico-economica nel mondo. Allora erano ancora delle “baracche” ed il primo odore che si sentiva, uscendo dall’aereo era, piuttosto, un “cocktail di odori”.
Potremmo quasi dire che c’era, innanzitutto, “odore di caldo”. Il caldo-umido era difatti talmente omnipervasivo che raggiungeva anche l’interno delle narici, vi aderiva e le intrideva e loro, in qualche modo, lo decodificavano mentre venivano investite, al contempo, dall’odore di frutta tropicale marcia e di fogna.
Ricordo distintamente questo cocktail olfattivo, appena giunto a Bombay e, appena incontrato il tassista che mi era stato spedito dall’ashram (allora era abbastanza sconsigliabile affidarsi ai tassisti locali per un viaggio di circa 3 ore nelle strade del Maharastra), l’iniziazione all’odore di betel: gradevole, fresco, intenso, speziato. Concedendomi un’iperbole un po’ spericolata, credo possa essere anche considerato una sorta di equivalente olfattivo del colore rosso. Ne ha la stessa, forte, vibrazione che riconduce subito al pensiero del sangue. E sembrava, difatti, sangue quello che vedevo sputare dalle moto, dai tuk tuk (piccoli taxi a tre ruote, derivati curiosamente dal modello Ape Calessino, creato nel 1948 dalla Piaggio) o dai pedoni nel traffico frastornante e congestionato di Bombay mentre era, ancora, alla noce di Areca avvolta nella foglia di Betel che gli indiani masticano con frequenza quasi ossessiva, stimola la salivazione e dà allo sputo conseguente un colore rosso-vivo che, in principio, può anche fare impressione. Più di una persona (incluso il sottoscritto), appena arrivata in India, ha avuto la sensazione di essere giunta in un paese di tisici.
Ne dà testimonianza anche un personaggio del mio romanzo Un Giardino dell’Eden, ambientato per metà in India: Daddy, veterano del paese e della ricerca interiore. Una sera, frugando nelle sue memorie, dice al protagonista (Siddharta): «la prima volta che venni in India, trent’anni fa, arrivai alla stazione di Delhi che era una cosa…100 volte peggio di oggi. In terra c’erano sputi rossi ovunque, da non poter camminare, non c’era un centimetro libero. Io allora non sapevo che gli indiani masticano il betel tutto il tempo […] e dunque sputano ovunque rigagnoli che sembrano sanguinolenti. Pensavo fossero tutti tisici e ho avuto paura, poi ho deciso di affidarmi e pensare: sia di me quello che deve essere e, poco dopo, ho scoperto che mi ero preoccupato inutilmente. […]» .
Quel viaggio da Bombay a Poona, nel marzo 1998, fu memorabile. L’impatto sonoro ed olfattivo della città era sovrastante e si è mantenuto fino all’uscita dall’ipertrofico agglomerato urbano. Ancora odore di frutta tropicale marcia, ancora odore di fogna cui si aggiungeva l’odore “spesso” dello smog che avvolgeva la città in un alone grigio-marrone.
Le grandi rivelazioni del mio primo viaggio in India, durato oltre due mesi, furono la grazia, la femminilità e la sensualità delle donne indiane. Ricordo ne cercavo gli sguardi, teneri ed elusivi, ardenti e malinconici, ammiccanti e sensuali. Le cercavo con gli occhi ed anche con il naso, quando mi passavano vicino. Non mi sembra di aver mai colto profumi nelle loro scie. Piuttosto “odore di sari”, di pulizia sobria, con sfumature di afrore di sudore. Il sudore di una pelle scura e di un’alimentazione speziata. Un odore poco invadente, poco deciso e, tuttavia, ispirante. Sollecitava la curiosità a percorrere quei corpi con il naso per scoprirne i picchi di intensità.
Spostandomi di alcuni chilometri più a sud, più definita è stata la recente esperienza olfattiva in Sri Lanka. Gli autobus srilankesi, con i quali mi sono trovato spesso a percorrere Colombo, sono una discreta fucina di odore. L’uso del singolare non è casuale. Le donne (in genere molto femminili, indossano sari o larghe, comode e pudiche gonne di cotone) che salgono e scendono — spesso quando l’autobus è in lento movimento ― dai portelli sempre aperti, recano quasi tutte l’odore di un sapone a fragranza decisa. La loro pelle, irrobustita dal sole, non chiede saponi delicati. Il profumo fresco e deciso di quel sapone è abbastanza uniforme sull’isola folle (per usare una definizione di Tiziano Terzani). Si ripropone con costanza gradevole ma prevedibile, pur non perdendo, a sua volta, di sensualità.
Un altro odore ricorrente, in Sri Lanka, è quello di cocco. Nei daba (trattorie) ma anche nei negozi di prodotti da forno è inesorabilmente di casa in quanto il frutto, reperibilissimo sull’isola, viene usato in quasi tutti i piatti della cucina locale. Nel mio primo soggiorno, di tre mesi, ebbi il privilegio di scoprirne la principale modalità di utilizzo.
Avevo iniziato a collaborare con un’importante ONG srilankese, Sarvodaya, fondata negli anni ’50 per portare servizi basici come acqua, energia elettrica, ambulatori di pronto soccorso e piccole scuole nelle aree interne, completamente abbandonate a se stesse, nella foresta tropicale. Vivevo nel quartier generale dell’organizzazione, a Moratuwa, una cittadina che, in realtà, sembra più un sobborgo di Colombo. Il week-end sentivo il bisogno di lasciare la dimensione urbana e raggiungevo Gampaha, ad appena 45 minuti dalla capitale, un tempo da trascorrere, spesso in piedi, su di un treno che ricordava facilmente le nostre linee metropolitane, con la differenza che correva, regolarmente, con i portelli aperti. Correva lungo paesaggi riccoverdi in cui risaie o fiumi placidamente animati spezzavano l’intensità lussureggiante dei coccheti e dei banani. Correva e si fermava in stazioni secondarie, preservate dal freddo anonimato delle nostre stazioncine europee, colorate, sobriamente vitali.
Gampaha è una cittadina come tante nel turgore della foresta srilankese. Con i suoi templi buddisti e le sue chiese, i suoi mercati, i daba “moscheolenti”, i suoi tuk tuk, i vestiti sobri e pudichi delle donne, le loro lunghe capigliature nere, qualche cane malandato, qualche insegna di compagnia telefonica, poca ressa, poche smanie, poco clamore. Il distretto di Sarvodaya rimane un po’ fuori città. È costituito da un paio di edifici a piano unico su un francobollo di terreno preso in prestito alla foresta.
Un terreno con un vecchio pozzo, un paio di tettoie per poche bufale e qualche vitello, dove si aggirano visibili, nel verde, un grosso gallo bianco e più discrete galline. Nel distretto vive Nimal-Aya con la moglie e due figli maschi, di 7 e 14 anni. Persone semplici, in simbiosi con il loro ambiente naturale. Il francobollo di terreno dà loro l’indispensabile per vivere: le banane (da mangiare crude o cotte), i jack fruits (da mangiare crudi o cotti), il latte delle bufale e le immancabili noci di cocco. Scoprii presto, nella primitiva cucina della moglie di Nimal-Aya (dove si utilizza solo legna), un utensile quasi altrettanto primitivo, a manovella, per raschiare scaglie di frutto dall’interno delle noci aperte. Le scaglie vengono mescolate con dell’acqua che ne acquisisce il sapore. Questa, mischiata con altra acqua spremuta dall’impasto delle scaglie, viene usata nella cottura di quasi ogni pietanza. Ecco l’odore così ricorrente, identificativo nelle mie memorie, assieme a quello di sapone, del paese. Odori che ritrovo con amore ma che non riesco a dissociare dalla sensazione di una certa “prevedibilità”.
In India, invece, qualunque dimensione, finanche olfattiva, è più contrastata, come testimonia questo breve passaggio da un brano in cui descrivo il mio primo impatto con Varanasi, città indiana in cui sono arrivato nel 2005 e dove ho messo alcune solide radici:
«L’impatto con Varanasi coinvolge tutti i sensi […]. All’uscita dal piccolo aereoporto
la luce del sole è quasi accecante ed il calore sulla pelle (più o meno intenso a seconda del periodo) può essere confortante o insopportabile.
Nel momento in cui si sale su un taxi per raggiungere la città ha inizio un’avventura che nessuno potrebbe definire banale.
Protagonisti […] gli odori: di letame, date le tante mucche, di spazzatura e di combustibili di bassa qualità ma anche di incenso, che fuoriesce furtivo da qualche bottega — o, più facilmente, da piccoli o grandi templi ― e di fiori per le offerte religiose.
Protagonisti anche i suoni, primi tra tutti i clacson — usati senza risparmio per segnalare sorpassi al di là di ogni norma del codice della strada ― i campanelli delle tante biciclette e dei rickshaw a pedali ma anche le campane delle puje, ancora all’uscita dei templi che punteggiano la città ed il vociare di un popolo che vive per buona parte della giornata in strada.
Altri protagonisti i colori, da quelli della frutta esposta sui carretti, ai tanti che vivacizzano i cumuli di spazzatura o a quelli delle montagnole di polveri sacre — rosse, gialle o arancione ― usate per segnare il tilaka sulla fronte (all’altezza del terzo occhio), fino ai colori sommessi dei sari delle donne o allo stesso colore della strada — con le sfumature gialle e rossastre di una terra che non risparmia la città ―, acceso dai forti raggi del sole».
Vivere in India, come sto facendo io da oltre cinque anni, ha senz’altro i suoi inconvenienti. Mi sono cimentato con una poesia semiseria sul paese, per esprimerne alcuni tratti peculiari: Problems, tomorrow,
Posso tuttavia confermare che attraverso diversi viaggi, in circa 39 anni di vita e soprattutto nel momento in cui il viaggio ha iniziato a coincidere con la mia quotidianità, sono giunto ad una visione/conoscenza addirittura “radicale” di me stesso, come “uomo molto orientale”!
Nato a Roma, città definita talora “levantina”, ho iniziato ad amare la dimensione del viaggio sul finire delle scuole superiori, vivendo i primi interrail, viaggiando ― zaino in spalla e sacco a pelo — con un economico biglietto ferroviario, valido per un mese, nell’Europa intera.
Sin da allora compresi, in tutte le mie cellule, le enormi potenzialità del viaggio per innestare un processo espansivo della coscienza. Dunque non solo, banalmente, le potenzialità formative ma quelle psichiche, antropologiche e di “crescita integrale”.
Nel periodo universitario l’attrazione per il viaggio ha iniziato a magnetizzarmi dall’Oriente, per un’esperienza più psichica, più antropologica e di più profonda crescita integrale.
Cito da un mio libro di prossima pubblicazione in cui, tra le altre cose, riporto alcune mie esperienze avute nel mio primo viaggio in India: «It is very hard Bombay, mi diceva [il tassista], iniziandomi all’inconfondibile aroma del betel che promanava dalla sua bocca». Era il 1998.
Ero appena giunto all’aereoporto di Bombay (oramai, da tempo, Mumbai) per dirigermi prontamente a Poona, nell’ashram di Osho Rajneesh e scrivere la mia tesi di laurea di sociologia delle religioni.
L’impatto con il paese fu molto “olfattivo”. Oggi gli aeroporti indiani (almeno i principali) sono degni di un paese che sta acquisendo, malgrado il persistere di molte sue contraddizioni ed inadeguatezze, un’indiscutibile centralità politico-economica nel mondo. Allora erano ancora delle “baracche” ed il primo odore che si sentiva, uscendo dall’aereo era, piuttosto, un “cocktail di odori”.
Potremmo quasi dire che c’era, innanzitutto, “odore di caldo”. Il caldo-umido era difatti talmente omnipervasivo che raggiungeva anche l’interno delle narici, vi aderiva e le intrideva e loro, in qualche modo, lo decodificavano mentre venivano investite, al contempo, dall’odore di frutta tropicale marcia e di fogna.
Ricordo distintamente questo cocktail olfattivo, appena giunto a Bombay e, appena incontrato il tassista che mi era stato spedito dall’ashram (allora era abbastanza sconsigliabile affidarsi ai tassisti locali per un viaggio di circa 3 ore nelle strade del Maharastra), l’iniziazione all’odore di betel: gradevole, fresco, intenso, speziato. Concedendomi un’iperbole un po’ spericolata, credo possa essere anche considerato una sorta di equivalente olfattivo del colore rosso. Ne ha la stessa, forte, vibrazione che riconduce subito al pensiero del sangue. E sembrava, difatti, sangue quello che vedevo sputare dalle moto, dai tuk tuk (piccoli taxi a tre ruote, derivati curiosamente dal modello Ape Calessino, creato nel 1948 dalla Piaggio) o dai pedoni nel traffico frastornante e congestionato di Bombay mentre era, ancora, alla noce di Areca avvolta nella foglia di Betel che gli indiani masticano con frequenza quasi ossessiva, stimola la salivazione e dà allo sputo conseguente un colore rosso-vivo che, in principio, può anche fare impressione. Più di una persona (incluso il sottoscritto), appena arrivata in India, ha avuto la sensazione di essere giunta in un paese di tisici.
Ne dà testimonianza anche un personaggio del mio romanzo Un Giardino dell’Eden, ambientato per metà in India: Daddy, veterano del paese e della ricerca interiore. Una sera, frugando nelle sue memorie, dice al protagonista (Siddharta): «la prima volta che venni in India, trent’anni fa, arrivai alla stazione di Delhi che era una cosa…100 volte peggio di oggi. In terra c’erano sputi rossi ovunque, da non poter camminare, non c’era un centimetro libero. Io allora non sapevo che gli indiani masticano il betel tutto il tempo […] e dunque sputano ovunque rigagnoli che sembrano sanguinolenti. Pensavo fossero tutti tisici e ho avuto paura, poi ho deciso di affidarmi e pensare: sia di me quello che deve essere e, poco dopo, ho scoperto che mi ero preoccupato inutilmente. […]» .
Quel viaggio da Bombay a Poona, nel marzo 1998, fu memorabile. L’impatto sonoro ed olfattivo della città era sovrastante e si è mantenuto fino all’uscita dall’ipertrofico agglomerato urbano. Ancora odore di frutta tropicale marcia, ancora odore di fogna cui si aggiungeva l’odore “spesso” dello smog che avvolgeva la città in un alone grigio-marrone.
Le grandi rivelazioni del mio primo viaggio in India, durato oltre due mesi, furono la grazia, la femminilità e la sensualità delle donne indiane. Ricordo ne cercavo gli sguardi, teneri ed elusivi, ardenti e malinconici, ammiccanti e sensuali. Le cercavo con gli occhi ed anche con il naso, quando mi passavano vicino. Non mi sembra di aver mai colto profumi nelle loro scie. Piuttosto “odore di sari”, di pulizia sobria, con sfumature di afrore di sudore. Il sudore di una pelle scura e di un’alimentazione speziata. Un odore poco invadente, poco deciso e, tuttavia, ispirante. Sollecitava la curiosità a percorrere quei corpi con il naso per scoprirne i picchi di intensità.
Spostandomi di alcuni chilometri più a sud, più definita è stata la recente esperienza olfattiva in Sri Lanka. Gli autobus srilankesi, con i quali mi sono trovato spesso a percorrere Colombo, sono una discreta fucina di odore. L’uso del singolare non è casuale. Le donne (in genere molto femminili, indossano sari o larghe, comode e pudiche gonne di cotone) che salgono e scendono — spesso quando l’autobus è in lento movimento ― dai portelli sempre aperti, recano quasi tutte l’odore di un sapone a fragranza decisa. La loro pelle, irrobustita dal sole, non chiede saponi delicati. Il profumo fresco e deciso di quel sapone è abbastanza uniforme sull’isola folle (per usare una definizione di Tiziano Terzani). Si ripropone con costanza gradevole ma prevedibile, pur non perdendo, a sua volta, di sensualità.
Un altro odore ricorrente, in Sri Lanka, è quello di cocco. Nei daba (trattorie) ma anche nei negozi di prodotti da forno è inesorabilmente di casa in quanto il frutto, reperibilissimo sull’isola, viene usato in quasi tutti i piatti della cucina locale. Nel mio primo soggiorno, di tre mesi, ebbi il privilegio di scoprirne la principale modalità di utilizzo.
Avevo iniziato a collaborare con un’importante ONG srilankese, Sarvodaya, fondata negli anni ’50 per portare servizi basici come acqua, energia elettrica, ambulatori di pronto soccorso e piccole scuole nelle aree interne, completamente abbandonate a se stesse, nella foresta tropicale. Vivevo nel quartier generale dell’organizzazione, a Moratuwa, una cittadina che, in realtà, sembra più un sobborgo di Colombo. Il week-end sentivo il bisogno di lasciare la dimensione urbana e raggiungevo Gampaha, ad appena 45 minuti dalla capitale, un tempo da trascorrere, spesso in piedi, su di un treno che ricordava facilmente le nostre linee metropolitane, con la differenza che correva, regolarmente, con i portelli aperti. Correva lungo paesaggi riccoverdi in cui risaie o fiumi placidamente animati spezzavano l’intensità lussureggiante dei coccheti e dei banani. Correva e si fermava in stazioni secondarie, preservate dal freddo anonimato delle nostre stazioncine europee, colorate, sobriamente vitali.
Gampaha è una cittadina come tante nel turgore della foresta srilankese. Con i suoi templi buddisti e le sue chiese, i suoi mercati, i daba “moscheolenti”, i suoi tuk tuk, i vestiti sobri e pudichi delle donne, le loro lunghe capigliature nere, qualche cane malandato, qualche insegna di compagnia telefonica, poca ressa, poche smanie, poco clamore. Il distretto di Sarvodaya rimane un po’ fuori città. È costituito da un paio di edifici a piano unico su un francobollo di terreno preso in prestito alla foresta.
Un terreno con un vecchio pozzo, un paio di tettoie per poche bufale e qualche vitello, dove si aggirano visibili, nel verde, un grosso gallo bianco e più discrete galline. Nel distretto vive Nimal-Aya con la moglie e due figli maschi, di 7 e 14 anni. Persone semplici, in simbiosi con il loro ambiente naturale. Il francobollo di terreno dà loro l’indispensabile per vivere: le banane (da mangiare crude o cotte), i jack fruits (da mangiare crudi o cotti), il latte delle bufale e le immancabili noci di cocco. Scoprii presto, nella primitiva cucina della moglie di Nimal-Aya (dove si utilizza solo legna), un utensile quasi altrettanto primitivo, a manovella, per raschiare scaglie di frutto dall’interno delle noci aperte. Le scaglie vengono mescolate con dell’acqua che ne acquisisce il sapore. Questa, mischiata con altra acqua spremuta dall’impasto delle scaglie, viene usata nella cottura di quasi ogni pietanza. Ecco l’odore così ricorrente, identificativo nelle mie memorie, assieme a quello di sapone, del paese. Odori che ritrovo con amore ma che non riesco a dissociare dalla sensazione di una certa “prevedibilità”.
In India, invece, qualunque dimensione, finanche olfattiva, è più contrastata, come testimonia questo breve passaggio da un brano in cui descrivo il mio primo impatto con Varanasi, città indiana in cui sono arrivato nel 2005 e dove ho messo alcune solide radici:
«L’impatto con Varanasi coinvolge tutti i sensi […]. All’uscita dal piccolo aereoporto
la luce del sole è quasi accecante ed il calore sulla pelle (più o meno intenso a seconda del periodo) può essere confortante o insopportabile.
Nel momento in cui si sale su un taxi per raggiungere la città ha inizio un’avventura che nessuno potrebbe definire banale.
Protagonisti […] gli odori: di letame, date le tante mucche, di spazzatura e di combustibili di bassa qualità ma anche di incenso, che fuoriesce furtivo da qualche bottega — o, più facilmente, da piccoli o grandi templi ― e di fiori per le offerte religiose.
Protagonisti anche i suoni, primi tra tutti i clacson — usati senza risparmio per segnalare sorpassi al di là di ogni norma del codice della strada ― i campanelli delle tante biciclette e dei rickshaw a pedali ma anche le campane delle puje, ancora all’uscita dei templi che punteggiano la città ed il vociare di un popolo che vive per buona parte della giornata in strada.
Altri protagonisti i colori, da quelli della frutta esposta sui carretti, ai tanti che vivacizzano i cumuli di spazzatura o a quelli delle montagnole di polveri sacre — rosse, gialle o arancione ― usate per segnare il tilaka sulla fronte (all’altezza del terzo occhio), fino ai colori sommessi dei sari delle donne o allo stesso colore della strada — con le sfumature gialle e rossastre di una terra che non risparmia la città ―, acceso dai forti raggi del sole».
Vivere in India, come sto facendo io da oltre cinque anni, ha senz’altro i suoi inconvenienti. Mi sono cimentato con una poesia semiseria sul paese, per esprimerne alcuni tratti peculiari: Problems, tomorrow,
Tomorrow, problems,
Problems, tomorrow,
Tomorrow, problems!
Problems, tomorrow,
Tomorrow, problems!
Credo possa rendere, pur lontanamente, l’idea.
Uno dei problems principali per vivere a lungo in India è quello di ottenere un visto adeguato. Negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio leitmotiv ossessivo tra gli indofili, senior e junior. Se ne parla nei ristoranti, in spiaggia a Goa, nei chai-shops (baracchini con poche panche o sedie di plastica dove si formano capannelli di persone che si concedono quello che gli inglesi chiamano, con immancabile aplomb, un tea-break), sulle pendici dell’Himalaya ed altrove.Mi sono trovato anche io a dover affrontare seriamente questo problem ed è stata l’occasione per approfondire la conoscenza di un paese dove ero già stato un paio di volte ma dove non mi ero soffermato a sufficienza.
Parliamo del Nepal. Poverissimo e disastrato (già a partire dai quartieri periferici di Kathmandu, i nepalesi, a fronte di una carenza disperata di strutture sanitarie, si rivolgono spesso ancora agli sciamani e questo ha mantenuto viva una conoscenza ancestrale), torbido e tantrico, multietnico, sincretico e con alcune oasi sorprendentemente curate.
Una di queste, probabilmente la più famosa, è il quartiere Thamel, nel centro di Kathmandu che, tra le altre cose, pullula di negozi di artigianato, souvenirs, anticaglie, validi prodotti locali come il tè, eccetera.
In uno di questi, piccolo e per nulla chiassoso, ho conosciuto un ragazzo amabile, Suman, specializzato nella vendita di oggetti di arte tribale, in particolare di matrice sciamanica e buddhista vajrayana.
Ho comprato da Suman due belle raffigurazioni della dea Tara e di Milarepa su ossa di Yak, un antico bicchiere in legno, odoroso ancora di tè burrato, una pietra con inciso il mantra tibetano Om Mani Padme Hum ed un antico manoscritto tradizionale, in tibetano, su diverse paginette di carta di riso raccolte tra due tavolette di legno, strette e lunghe, su cui è intagliato lo stesso mantra.
Suman non ha oggetti di grandissimo valore commerciale, è un po’ l’equivalente di un nostro rigattiere ma nel suo negozio, se non si hanno grandi pretese antiquarie, si possono trovare prodotti insoliti, di buon valore antropologico e culturale. Mi sembra di aver capito che Suman sia un valido riferimento per persone che vivono nelle campagne nepalesi e sono in possesso di un vecchio tamburo o cappello sciamanico, di un vecchio kukri (tipico coltello nepalese) o di quanto si è salvato dall’incendio o dal decadimento di un monastero. Spinti dalla miseria, se ne disfano per una manciata di rupie, per la gioia di qualche viaggiatore, appassionato di antropologia, di passaggio a Kathmandu che trova in Suman un venditore poco esoso.
«Di dove sei, francese?» mi chiede Suman, dopo che, effettuati gli acquisti, siamo entrati un minimo in confidenza. «No, sono italiano», gli rispondo.
Il suo negozio è poco più di uno sgabuzzino, stipato di ogni “anticaglia” nepalese, indiana, bhutanese e tibetana. Infila la mano in un varco tra le merci ammucchiate su vecchi scaffali. Tira fuori un libro e me lo porge: Himalaya le porte del cielo; verso gli sciamani, di Massimo Andreuzza ed Andrea Bocconi, pubblicato dalla Casa Editrice Irradiazioni.
«Io non capisco l’italiano», mi dice Suman, «ma sono felice di avere questo libro, è un regalo». Me lo dà da sfogliare e sembra davvero interessante, penso di aver sottovalutato, fino a questo momento, il patrimonio culturale sciamanico nepalese. Decido di essere sfacciato: «devo rimanere a Kathmandu diversi giorni», dico a Suman, «sono all’Hotel Encounter, a due passi da qui. Ti fidi a prestarmi questo libro? Lo leggo in fretta e te lo riporto domani». Sorride Suman, scoprendo un molare distrutto e mal ricostruito ed incastonato in poco oro: «certo!».
Mi congedo salutandolo cordialmente. Lui, stringendomi la mano, si inchina con cerimoniosa naturalezza, è evidentemente contento di aver destato la mia curiosità.
Per concludere con l’odore del viaggio, non posso dimenticare di quel libro, letto in fretta e riconsegnato prontamente, come avevo promesso, l’odore di incenso legnoso, gradevole e vissuto, una sorta di misura olfattiva del dipanarsi dei mesi e degli anni, in pochi metri quadri, poco illuminati, di interno stipato. Un odore non riproducibile e non recuperabile se non con un’altra visita a Suman, nel suo piccolo sgabuzzino, dove mi viene da pensare ed un po’ sperare che quell’ “odore di tempo” sia rimasto quasi intatto.
Parliamo del Nepal. Poverissimo e disastrato (già a partire dai quartieri periferici di Kathmandu, i nepalesi, a fronte di una carenza disperata di strutture sanitarie, si rivolgono spesso ancora agli sciamani e questo ha mantenuto viva una conoscenza ancestrale), torbido e tantrico, multietnico, sincretico e con alcune oasi sorprendentemente curate.
Una di queste, probabilmente la più famosa, è il quartiere Thamel, nel centro di Kathmandu che, tra le altre cose, pullula di negozi di artigianato, souvenirs, anticaglie, validi prodotti locali come il tè, eccetera.
In uno di questi, piccolo e per nulla chiassoso, ho conosciuto un ragazzo amabile, Suman, specializzato nella vendita di oggetti di arte tribale, in particolare di matrice sciamanica e buddhista vajrayana.
Ho comprato da Suman due belle raffigurazioni della dea Tara e di Milarepa su ossa di Yak, un antico bicchiere in legno, odoroso ancora di tè burrato, una pietra con inciso il mantra tibetano Om Mani Padme Hum ed un antico manoscritto tradizionale, in tibetano, su diverse paginette di carta di riso raccolte tra due tavolette di legno, strette e lunghe, su cui è intagliato lo stesso mantra.
Suman non ha oggetti di grandissimo valore commerciale, è un po’ l’equivalente di un nostro rigattiere ma nel suo negozio, se non si hanno grandi pretese antiquarie, si possono trovare prodotti insoliti, di buon valore antropologico e culturale. Mi sembra di aver capito che Suman sia un valido riferimento per persone che vivono nelle campagne nepalesi e sono in possesso di un vecchio tamburo o cappello sciamanico, di un vecchio kukri (tipico coltello nepalese) o di quanto si è salvato dall’incendio o dal decadimento di un monastero. Spinti dalla miseria, se ne disfano per una manciata di rupie, per la gioia di qualche viaggiatore, appassionato di antropologia, di passaggio a Kathmandu che trova in Suman un venditore poco esoso.
«Di dove sei, francese?» mi chiede Suman, dopo che, effettuati gli acquisti, siamo entrati un minimo in confidenza. «No, sono italiano», gli rispondo.
Il suo negozio è poco più di uno sgabuzzino, stipato di ogni “anticaglia” nepalese, indiana, bhutanese e tibetana. Infila la mano in un varco tra le merci ammucchiate su vecchi scaffali. Tira fuori un libro e me lo porge: Himalaya le porte del cielo; verso gli sciamani, di Massimo Andreuzza ed Andrea Bocconi, pubblicato dalla Casa Editrice Irradiazioni.
«Io non capisco l’italiano», mi dice Suman, «ma sono felice di avere questo libro, è un regalo». Me lo dà da sfogliare e sembra davvero interessante, penso di aver sottovalutato, fino a questo momento, il patrimonio culturale sciamanico nepalese. Decido di essere sfacciato: «devo rimanere a Kathmandu diversi giorni», dico a Suman, «sono all’Hotel Encounter, a due passi da qui. Ti fidi a prestarmi questo libro? Lo leggo in fretta e te lo riporto domani». Sorride Suman, scoprendo un molare distrutto e mal ricostruito ed incastonato in poco oro: «certo!».
Mi congedo salutandolo cordialmente. Lui, stringendomi la mano, si inchina con cerimoniosa naturalezza, è evidentemente contento di aver destato la mia curiosità.
Per concludere con l’odore del viaggio, non posso dimenticare di quel libro, letto in fretta e riconsegnato prontamente, come avevo promesso, l’odore di incenso legnoso, gradevole e vissuto, una sorta di misura olfattiva del dipanarsi dei mesi e degli anni, in pochi metri quadri, poco illuminati, di interno stipato. Un odore non riproducibile e non recuperabile se non con un’altra visita a Suman, nel suo piccolo sgabuzzino, dove mi viene da pensare ed un po’ sperare che quell’ “odore di tempo” sia rimasto quasi intatto.
Manuel Olivares

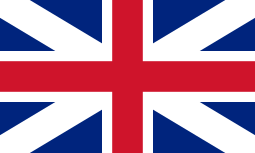 English
English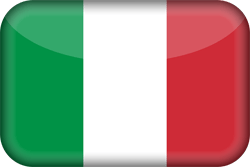 Italian
Italian