Ladakh (agosto 2014)

Di seguito un brano tratto dal libro Gesù in India? Ho deciso di condividerlo con i lettori di Viverealtrimenti avendo come pretesto un viaggio del nostro collaboratore Mattia Confalonieri in India. Avendo Viverealtrimenti un buon radicamento in India mi ha chiesto alcuni consigli però, si sa, l’India è grande e Mattia si muoverà soprattutto sulla rotta nord occidentale, saltando Varanasi, “la base indiana” del nostro progetto.
Andando in Ladakh, non può non visitare il monastero di Hemis, dove alla fine dell’Ottocento vennero trovati, dal viaggiatore russo Nicholas Notovitch, i famosi manoscritti (da cui si sarebbe successivamente ricavato il libro La vita sconosciuta di Gesù) in cui si dettagliavano i famosi “anni indiani di Gesù”. La scoperta non destò poco clamore, venne da molti considerata una frode, poi nello stesso monastero andò, negli anni Venti del Novecento il celebre monaco hindu Swami Abhednanda che trovò, a sua volta, i manoscritti, ne tradusse una parte confermando, sostanzialmente, l’autenticità della scoperta.
Quasi un secolo dopo nello stesso monastero sono andato anche io, disperando di trovare i manoscritti (ormai definitivamente occultati, per quanto non si perdano mai le speranze possano venir fuori in altri contesti, un giorno). E’ stata una gran bella esperienza che consiglio, pubblicamente, anche al nostro Mattia, raccomandandomi di prestare attenzione al mal di montagna…ma di questo, eventualmente, parleremo in privato.
Buona lettura!
Manuel Olivares
 Era un viaggio in programma da diversi anni. Rinuncio alla tentazione di raggiungere Leh (la capitale di quello che potrebbe definirsi “uno stato nello stato”; pur godendo di una certa autonomia, il Ladakh è formalmente parte di Jammmu e Kashmir) via terra. Compro un volo da Delhi. Appena arrivato, risento subito dell’AMD (Acute Mountain Disease; un, più o meno serio, mal di montagna). Ho prenotato una stanza in una pensioncina di Changspa, l’aerea più turistica della città, piena di franceserie: localini pretenziosi, cari per gli standards locali e, cosa di gran lunga più antipatica, dove viene implicitamente richiesto il cul serré.
Era un viaggio in programma da diversi anni. Rinuncio alla tentazione di raggiungere Leh (la capitale di quello che potrebbe definirsi “uno stato nello stato”; pur godendo di una certa autonomia, il Ladakh è formalmente parte di Jammmu e Kashmir) via terra. Compro un volo da Delhi. Appena arrivato, risento subito dell’AMD (Acute Mountain Disease; un, più o meno serio, mal di montagna). Ho prenotato una stanza in una pensioncina di Changspa, l’aerea più turistica della città, piena di franceserie: localini pretenziosi, cari per gli standards locali e, cosa di gran lunga più antipatica, dove viene implicitamente richiesto il cul serré.
La guesthouse, tuttavia, è deliziosa e si rivela perfetta per trascorrere i primi due o tre giorni soprattutto in camera, per superare il mal di montagna (che è bene non venga sottovalutato).
I giorni successivi ho modo di visitare “la città vecchia”, luogo di tutt’altro interesse e, difatti, mi trasferisco prontamente. Ha anche il vantaggio di essere più vicina alla stazione delle corriere che ho intenzione di utilizzare senza risparmio per raggiungere le diverse località che intendo visitare.
La nuova guesthouse è da viaggiatori consumati. Ha un cortile discretamente ampio e, in un angolo, un lungo tavolo male in arnese (come un po’ tutto il resto) con “sedie mobili”, perfetto, tuttavia, per la socialità. La sera ci si intrattiene tra ospiti a bere birra o liquori locali, fumare, chiacchierare, a proporre e ascoltare soprattutto racconti di viaggio. Sembra quasi di essere ritornati agli anni Settanta, all’Asia viaggiata e vissuta in economia, a stili di vita nomadici e pacatamente avventurosi. È insomma la base ideale per partire e ritornare, liberi dal peso di bagagli impegnativi.
Inoltre, l’Adhan dagli altoparlanti della vicina moschea, a orari determinati, la mantiene in quella calda suggestione per cui un occidentale non può proprio dimenticarsi, pur volendolo, di essere altrove.
Parto dunque, più volte, con appena l’essenziale, lasciando valigia, soldi e computer a Leh, senza sapere esattamente il momento del rientro, lasciando al caso, agli incontri, ai segni di buon auspicio la determinazione a pernottare o meno “fuori sede”.
Il Ladakh si rivela subito una dimensione arcaica, remota: si fa fatica, a volte molta fatica, a utilizzare internet, le comuni schede telefoniche indiane non sono utilizzabili in loco e nessuno sembra avere la pazienza di procurarsi schede locali.
Si incontrano molte persone interessanti, soprattutto viaggiando in corriera, viaggiatori d’altri tempi forse perché il posto e il modo di viaggiare sono, giocoforza, pre-moderni.
Si fraternizza con personaggi disparati cui si danno appuntamenti vaghi ― non potendo disporre degli attuali, efficienti, mezzi di comunicazione ― che spesso cadono nel vuoto, solo per lasciare spazio a nuovi incontri, nuove testimonianze, nuovi scambi fugaci. Il tutto in una cornice aspra e tuttavia accogliente di quasi-deserto e pietraia di alta montagna, in un contesto culturale tibetano con forte minoranza musulmana (soprattutto kashmira).
I monasteri sovrastano piccoli e dimessi villaggi, il fiume Indo e i suoi affluenti scorrono magri nei loro letti, la vegetazione chiazza sparutamente il paesaggio di altitudini irregolari e pinnacolari, vagamente lunare.
L’aria è spietatamente asciutta, l’ossigeno contingentato rende faticosi i movimenti e le frequenti salite.
La prima visita, francamente fuori programma (avevo progettato di andare altrove ma non avevo fatto i conti con il caos della stazione delle corriere), è a Thiksey dov’è possibile visitare uno dei più bei monasteri ladakhi. Il monastero è quasi tutt’uno con il villaggio che sale, un po’ a spirale, sulla montagna di cui è chiara, filiale direi, emanazione.
 Il blocco di pietra monastero-villaggio è, a tratti, labirintico, con brevi sottopassaggi e gallerie. In una di queste trovo un’insegna di una scuola monastica, il cui ingresso è appena a latere e si sviluppa subito in un corridoio che si farebbe quasi fatica a pensare dove finisca perché dopo il muro della galleria, oltre l’ingresso della scuola, c’è solo l’orrido. Ma si immagina facilmente che un sistema di scale di legno dia accesso a piani alti, sopra la stessa galleria, dove si trasmettono da secoli segmenti e bandoli di conoscenze ancestrali a giovanissimi monaci.
Il blocco di pietra monastero-villaggio è, a tratti, labirintico, con brevi sottopassaggi e gallerie. In una di queste trovo un’insegna di una scuola monastica, il cui ingresso è appena a latere e si sviluppa subito in un corridoio che si farebbe quasi fatica a pensare dove finisca perché dopo il muro della galleria, oltre l’ingresso della scuola, c’è solo l’orrido. Ma si immagina facilmente che un sistema di scale di legno dia accesso a piani alti, sopra la stessa galleria, dove si trasmettono da secoli segmenti e bandoli di conoscenze ancestrali a giovanissimi monaci.
Io, nel frattempo, mi sono grossomodo perso, si potrebbe dire “in tutti i sensi”. Il mio corpo risente una certa oppressione per l’affanno da penuria di ossigeno, la mia mente non può non accogliere la suggestione del posto e non ho nessuna fretta di arrivare né di sapere come arrivare. Essere lì, pur nella galleria, di fianco alla scuola monastica, è già sufficiente e dunque non mi nego una sosta per rifiatare.
Esce un monaco dalla scuola. È un bambino, avrà non più di undici-dodici anni. Mi si rivolge con inaspettata autorità: «Dove devi andare?».
«Al monastero», rispondo quasi comicamente in soggezione.
Io, grande e grosso, intimidito da un bambino ma avreste dovuto vederne lo sguardo, il contegno.
Era chiaramente un adulto saggio in un corpo di bambino.
 Seguo le sue indicazioni e raggiungo il monastero, famoso per una bella statua del Buddha Maitreya.
Seguo le sue indicazioni e raggiungo il monastero, famoso per una bella statua del Buddha Maitreya.
Il monastero di Thiksey è di scuola Gelupa (o Gelug), nell’ambito della quale si è formato l’attuale Dalai Lama. Ha un’intima biblioteca dove sono conservati molti manoscritti in carta di riso, ciascuno meticolosamente raccolto tra due tavolette di legno e in panni ricamati con motivi mitici e dottrinari.
Dalla terrazza del monastero si domina la valle, sparutamente chiazzata di verde e dove scorre, non senza stanchezza e penuria di acque, il fiume Indo. Gli interni sono caldi, legnosi, ieratici, i monaci particolarmente affabili.
La sera sarò nuovamente a Leh, non si creano i presupposti perché pernotti fuori.
Sulla via del ritorno, tuttavia, mi fermo a Shey in una nunnery, un monastero per monache (Naropa Pothang). È di scuola Drukpa, la stessa, come abbiamo visto, del monastero di Hemis.
Nei giorni trascorsi a Leh ho avuto modo di comprarmi il testo Ladakh land of magical monasteries dove si parla diffusamente dei manoscritti ritrovati a Hemis, collegando il luogo alla nunnery di Shey.
Sul testo c’è anche scritto che per avere accesso ai manoscritti bisognerebbe avere il permesso dall’Head Lama (che non si capisce se sia l’abate del monastero o il Gyalwang Drukpa).
Mi rivolgo dunque alla persona dell’accoglienza, dicendole che è mia intenzione, il giorno dopo, andare a Hemis e che mi sarebbe utile sapere se c’è modo di farsi ricevere dall’Head Lama (ho fatto delle ricerche on line ma il monastero non ha praticamente un sito internet o un indirizzo mail…per fortuna!).
La persona interpellata mi dice che l’Head Lama è in Nepal (sulla Druk Amithaba Mountain ― parliamo dunque del Gyalwang Drukpa anche se non mancherà di emergere, più avanti, il ruolo cruciale dell’abate di Hemis ― ma i dettagli li avrei approfonditi in seguito) e che posso rivolgermi al suo segretario di cui mi dà il nominativo.
 Hemis
Hemis
Il giorno dopo, dunque, parto per Hemis. Anche in questo caso, alla stazione delle corriere non manco di avere problemi, la meta si direbbe remota e difatti sul testo/guida Ladakh land of magical monasteries si consiglia di “puntare” alla cittadina più vicina: Karu. Non ci sono, tuttavia, corriere nemmeno per Karu e allora decido, divertito, di fare l’autostop. Funziona in Ladakh, l’ho fatto il giorno prima, di ritorno da Shey, stanco di aspettare l’autobus o minivan collettivi.
Non è difficile trovare un passaggio, è sufficiente essere disposti a pagare qualcosa o un po’ di più. Capita di trovare persone distaccate, altre più esose. Trovo un ragazzo con una bella macchina della Toyota. Non è dei più distaccati ma è gentile, mi sta simpatico e decido di farmi accompagnare direttamente a Hemis.
Il monastero occupa una nicchia tra le montagne. Appartato e difficilmente espugnabile viene utilizzato, da secoli, per conservare gli oggeti antichi e preziosi del Ladakh. In principio, tuttavia, ignoro il monastero e punto, forse un po’ masochisticamente, all’eremo di Gotsangpa, uno dei primi santi della tradizione Drukpa (vissuto tra il 1189 ed il 1258) e iniziatore di To Druk: “L’alta Drukpa”. Got significa avvoltoio e tsang nido. In Tibet e in Ladakh gli avvoltoi hanno i loro nidi sulle zone più alte delle montagne. In uno di questi, una grotta in Ladakh, poco distante dal futuro monastero di Hemis, Gotsangpa avrebbe passato anni in meditazione con questo assunto: «un uccello, una roccia e io: un uomo. Fino a quando non avrò realizzato l’unità dei tre non lascerò questo posto!».
 Sulla grotta di Gotsangpa, secoli dopo, è stato costruito l’omonimo eremo, superato il quale (probabilmente oltre i quattromila metri) restano solo le cime brulle e pietrose delle montagne. Qualche altra cima, contenuta nel campo visuale, presenta spruzzi, quasi “pandorosi”, di neve ma quel che più ammalia è la qualità del silenzio.
Sulla grotta di Gotsangpa, secoli dopo, è stato costruito l’omonimo eremo, superato il quale (probabilmente oltre i quattromila metri) restano solo le cime brulle e pietrose delle montagne. Qualche altra cima, contenuta nel campo visuale, presenta spruzzi, quasi “pandorosi”, di neve ma quel che più ammalia è la qualità del silenzio.
Affiorano alla memoria alcuni versi di Shanti Deva[1], riportati meticolosamente da Ananda Coomaraswamy:
«Vorrei abitare in un santuario deserto sotto un albero o in caverne, per poter passeggiare senza nascondermi, senza dovermi mai guardare le spalle! Vorrei stare negli spazi naturali e in terre senza padrone, come pellegrino errante, libero di volontà, con la sola ricchezza di una ciotola d’argilla e del mantello senza valore per i ladri, senza temere e preoccuparmi per il mio corpo»[2].
Raggiungo, una volta nell’eremo, la grotta di Gotsangpa. Difficile rendere come la rarefazione e il silenzio del luogo impregnino tutto: l’aprirsi di una porta, lo scricchiolare delle assi di legno sotto i piedi, il sorriso del monaco giovane che mi fa strada.
 Nella parte posteriore della grotta ci sono alcune statue di Buddha e Padmasambhava[3] (nella foto), in una teca. In terra siede un ragazzo, in meditazione. Il monaco mi fa toccare il soffitto basso della grotta. Trasuda umidità. In inverno, a meno trentacinque gradi, deve essere come stare in un surgelatore. Mi siedo anche io, vicino al ragazzo che medita con i palmi delle mani aperti e accoglienti, appoggiati sulle ginocchia. Un monaco siede di fronte a noi, dietro un armamentario di campanelle, un grande tamburo circolare, in verticale, su sostegno in legno, un tavolino con sopra un manoscritto, con i peculiari, lunghi e stretti fogli rettangolari, ciascuno sle-gato dagli altri. Dopo poco inizia la puja: celebrazione. Il monaco inizia a battere ripetutamente il tamburo con una verga di legno, ripiegata nella parte terminale. Legge a ritmo con il tamburo il contenuto del manoscritto. Ogni tanto fa una pausa e suona una delle tipiche trombette tibetane, poi riprende: percuote a ritmo serrato il tamburo, a ritmo serrato legge il manoscritto. Ancora Shanti Deva, in continuità con quanto riportato prima:
Nella parte posteriore della grotta ci sono alcune statue di Buddha e Padmasambhava[3] (nella foto), in una teca. In terra siede un ragazzo, in meditazione. Il monaco mi fa toccare il soffitto basso della grotta. Trasuda umidità. In inverno, a meno trentacinque gradi, deve essere come stare in un surgelatore. Mi siedo anche io, vicino al ragazzo che medita con i palmi delle mani aperti e accoglienti, appoggiati sulle ginocchia. Un monaco siede di fronte a noi, dietro un armamentario di campanelle, un grande tamburo circolare, in verticale, su sostegno in legno, un tavolino con sopra un manoscritto, con i peculiari, lunghi e stretti fogli rettangolari, ciascuno sle-gato dagli altri. Dopo poco inizia la puja: celebrazione. Il monaco inizia a battere ripetutamente il tamburo con una verga di legno, ripiegata nella parte terminale. Legge a ritmo con il tamburo il contenuto del manoscritto. Ogni tanto fa una pausa e suona una delle tipiche trombette tibetane, poi riprende: percuote a ritmo serrato il tamburo, a ritmo serrato legge il manoscritto. Ancora Shanti Deva, in continuità con quanto riportato prima:
«Vorrei andare a casa mia, nel cimitero e confrontare con gli altri scheletri il mio fragile corpo! Perché questo corpo diventerà così puzzolente che neppure gli sciacalli lo avvicineranno […]. Le parti ossose nate con la struttura corporea cadranno a pezzi e ancora di più i miei amici. L’uomo nasce solo e solo muore; nessun’altro partecipa dei suoi dolori. A cosa servono gli amici, se non a ostacolare la propria via? Come un viandante si ferma per breve tempo in un luogo, così chi viaggia nella via dell’esistenza non trova in ogni nascita che un riposo temporaneo…»[4].
Ancora un suono di trombetta tibetana, ancora qualche passaggio da leggere, il tamburo da finire di percuotere e poi la grotta piomba nel silenzio. Apro gli occhi e sorprendo un topolino muoversi tra l’armamentario sacro. Lascio la grotta, uscendo sulla terrazza dell’eremo. Il mio vicino di meditazione mi ha preceduto. Mi guarda con un’espressione aperta e cordiale e mi sorride: «ti ho visto venire su», mi dice.
«Ti ho visto anche io», gli rispondo, «un bel pezzo avanti a me, sulle scale della montagna, la salita è stata massacrante!».
«Anche per me», mi dice, «mi sei stato di stimolo, non volevo che tu mi raggiungessi trovandomi sfiatato e incapace di proseguire».
«Anche tu; non volevo che, una volta raggiunto l’eremo, tu potessi pensare: quel debosciato invece non ce l’ha fatta!».
Si chiama Miro, è slovacco, si è concesso un lungo viaggio in India e Nepal per riflettere sul suo futuro. Ha lasciato il lavoro, non è fidanzato, non sa se quella che vuole è una vita normale. Raggiungiamo un altro vano dell’eremo dov’è in corso un’altra puja. Qualunque suono è enfatizzato da un lieve rimbombo nel silenzio “lunare” del luogo. Ci servono più volte del té burrato.
Ho desiderio di rimanere a dormire, di perdere il senso del tempo, dei programmi, voler semplicemente restare, assorbire, non avere il condizionamento di dover ritornare da qualunque parte, poter perdere l’idea stessa di un ritorno. Chiederò a un monaco se sia possibile restare la notte, senza fare ulteriori programmi. Miro, a puja finita, mi incoraggia, mi dice: «ci sono già venuto ieri, qui. Un giovane monaco mi aveva chiesto se avevo voglia di rimanere per la notte» ma lui si pone, ragionevolmente direi, soprattutto il problema del mangiare.
I monaci fanno poche cerimonie, alcuni di loro sono anziani, vivono nell’eremo da non si sa quanto, probabilmente non si muovono mai, come potrebbero? La salita da fare per arrivarci ha sfiancato un giovane come Miro (ha trentadue anni) ed un quasi giovane come me…e non esiste altra strada. Finiamo per fare poche cerimonie anche noi, chiediamo qualcosa da mangiare.
«Il pranzo è pronto», ci dice uno dei monaci.
Lo seguiamo per altre scale, sul costone della montagna, arriviamo ancora più in alto, a farci tagliuzzare la faccia dal vento arido. Una piccola struttura di pietra funge da refettorio. Appena fuori, su di un muretto, stanno tre pentoloni.
Si è formato un piccolo capannello di monaci ma nessuno si serve sino a che si sente il suono della campana. I monaci iniziano a servirsi, io e Miro, per la mia conoscenza delle regole monastiche, ci potremo servire per ultimi, dopo i monaci. Quando l’ultimo di loro si serve, quello che ci sta facendo burberamente da guida ci indica una tanichetta di acqua e ci dice: «lavatevi le mani!». Noi ubbidiamo, io avrei voglia di buttare uno sguardo nel refettorio ma mi limito a dire: «mangiamo qui?», indicando l’interno.
«No!», risponde seccamente il monaco, «aspettate!» (nel frattempo, difatti, sono sparite anche le pentole).
Il vento oltre che arido inizia ad essere lievemente gelido, soffiando dalle cime “pandorose”. Il monaco esce dal refettorio con due piatti. Contengono un po’ di riso e verdure bollite. Ci da i piatti e torna nel refettorio. Io e Miro ci guardiamo un po’ spaesati, non ci ha dato nemmeno una forchetta.
«Sediamoci lì», propongo indicando un muretto.
Mangiamo con le mani il riso e le verdure insipide, facciamo quasi uno sforzo a parlare, sarebbe solo da farsi assorbire da un contesto così meravigliosamente aspro.
Due parole sull’Italia, due sulla Slovacchia, qualcosa delle nostre vite, sul Ladakh, sul perché ci ritroviamo su quella montagna, un po’ al freddo, quasi indesiderati da monaci-eremiti imburberiti.
Finito di mangiare laviamo i nostri due piatti, esce il monaco che ci ha seguito fino a quel momento, non mi sembra ci siano i presupposti ma provo lo stesso: «è possibile rimanere a dormire qui questa notte?».
«No!», fine della conversazione.
Guardo Miro: «io a Leh, comunque, oggi non ritorno, inizio a scendere e prendo una stanza nella guesthouse del monastero».
«Io sto presso una famiglia, nel villaggio, mi hanno fatto montare la tenda nel loro terreno», mi dice Miro.
«Ah sì?», rispondo, «l’home stay sarebbe l’ideale!».
Scendiamo verso il monastero e il villaggio.
Diversamente da Thiksey, il villaggio di Hemis non fa blocco unico con il monastero, si sviluppa in maniera autonoma in una piega della valle sottostante. È, a sua volta, piuttosto appartato, saranno una ventina di case in pietra raccolte a lato di un minuscolo torrente. Solo case, nessun negozio, una fontana con leva di ferro per farla funzionare a pressione e qualche cane che si aggira sparuto.
Miro mi porta dalla famiglia di cui è ospite, fuori il nucleo principale del villaggio. Non sono in casa. Torniamo dinanzi al torrente. Parliamo con qualche residente. Ci guardano in maniera sostanzialmente neutra, senza grande curiosità, senza ostilità.
«Sto cercando una stanza», proclamo semiserio, «qualcuno ha una stanza da affittare per questa notte?».
I ladakhi per fortuna hanno una discreta conoscenza dell’inglese.
Una ragazza mi chiede di seguirla, la sua casa è a venti metri dal torrente, isolata dalle altre. Mi offre una stanza dignitosa ma il prezzo non mi convince. Mi chiedono relativamente tanto e pur comprendendo la necessità di questa gente di “approfittarsi” dello straniero di passaggio, preferisco essere ospitato da persone più semplici e pure, dunque ringrazio e prendo la porta. Torno dinanzi al torrente, Miro mi guarda interrogativo. Gli faccio un segno di complicità: «lascia fare a me!».
Supero il torrentello e mi addentro tra i vicoli del villaggio. Un uomo sta camminando nella direzione opposta alla mia, in un vicolo stretto al punto che a fatica potremo incrociarci senza venire, in qualche modo, a contatto.
Lo saluto e gli chiedo diretto: «ho bisogno di una stanza, mi può aiutare?».
Ha due occhi vagamente celesti sul volto rinsecchito dal vento himalayano e spaccato in più punti dalle rughe, i tempi di reazione lenti e placidi del luogo.
«Posso farti vedere una stanza che abbiamo per quando ci vengono a trovare i nostri parenti, se ti adatti…».
«Va bene», rispondo, «vediamola!».
La stanza è molto bella, meglio dell’altra. In realtà è una sorta di monolocale con uno spazio cucina e diversi materassi e cuscini, ai lati dei muri, ne marcano quasi tutto il perimetro. Su ogni materasso poggiano, piegate, lenzuola e coperte e ciascuno è fiancheggiato da un tavolinetto intarsiato, decorato con immagini di draghi (drukpa).
«Quanto vuoi che ti dia per dormire qui una notte?», gli chiedo.
Lui non sa, non risponde, è la persona che cercavo: semplicemente un nativo del luogo che non si è mai posto il problema di approfittare dello straniero di passaggio.
Ha bisogno di un suggerimento: «quanto posso darti per ricambiare la tua gentilezza?».
«Quello che vuoi», mi dice.
«Duecento rupie?», faccio io.
«Cento?», mi risponde.
«No, ti do duecento rupie, c’è fuori un mio amico, forse è interessato anche lui. Puoi darci eventualmente anche da mangiare?».
«Certamente», risponde.
Raggiungo Miro, gli dico di aver trovato una buona sistemazione, lui si incuriosisce.
«Vieni a vedere», gli faccio.
La stanza bella, semplice, pulita, funzionale lo conquista. La casa in generale è veramente struggente, con un piccolo giardino adattato a orto, qualche panno appeso ad asciugare, una bambina infagottata in braccio alla nonna sdentata e poi gli occhi celesti del nostro ospite, pacati e vitali, vigili, carichi di tanti momenti di vita dura e, tuttavia, benevoli.
«Vengo anche io», mi dice Miro, «smonto la tenda e arrivo!».
«Va bene», rispondo, «ci danno anche la cena, naturalmente proponiamo di pagarla a parte».
«Certo!», mi dice Miro.
 Poco dopo siamo tutti nella cucina di casa, seduti su materassi che ne marcano buona parte del perimetro. Si accende e si spenge, presto, la televisione. La moglie del nostro ospite si dà pacatamente da fare ai fornelli. Ci servono cibo semplice in abbondanza. Non ci sono i presupposti per una reale conversazione, se non per brevi momenti ma la compagnia è piacevole, la luce soffusa, lo spazio intimo. L’indomani, imbiancandoci i panataloni sul muretto di casa, con vista sul piccolo giardino adattato a orto e bevendo i nostri té, Miro inizia la giornata lasciando spazio alle proprie, contenute, inquietudini esistenziali: «credo mi piacerebbe vivere così, come loro».
Poco dopo siamo tutti nella cucina di casa, seduti su materassi che ne marcano buona parte del perimetro. Si accende e si spenge, presto, la televisione. La moglie del nostro ospite si dà pacatamente da fare ai fornelli. Ci servono cibo semplice in abbondanza. Non ci sono i presupposti per una reale conversazione, se non per brevi momenti ma la compagnia è piacevole, la luce soffusa, lo spazio intimo. L’indomani, imbiancandoci i panataloni sul muretto di casa, con vista sul piccolo giardino adattato a orto e bevendo i nostri té, Miro inizia la giornata lasciando spazio alle proprie, contenute, inquietudini esistenziali: «credo mi piacerebbe vivere così, come loro».
In effetti, in quella semplicità manca tutto…eccetto l’essenziale. Da tempo si profila in me lo stesso pensiero. Idealizzandola o vivendone, pavidamente, qualche spezzone, anche io confesso di essere sempre più attratto da un’uscita dal mondo. Dopo qualche giorno, difatti, sono di nuovo lì, questa volta da solo. Miro aveva comprato una moto Enfield del 1988 a Manali[5], contando di rivenderla al momento di lasciare l’India. Quella mattina di pantaloni imbiancati, sorseggiate di té nel piccolo giardino riadattato a orto di sussistenza e di esplicitate/condivise inquietudini, siamo ritornati a Leh sulla sua Enfield, lasciandoci disseccare i volti dal vento, reincontrando scenari di alture irregolari e di antropizzazioni discrete. Avremmo dovuto andare insieme, in serata, a un incontro ma l’impossibilità di comunicare ci ha fatto propendere, una volta a Leh, per un saluto “definitivo”. Salutare Miro è stato salutare un universale compagno di ricerca e ancora una volta parole del libro di Coomaraswamy possono essere di aiuto, per esprimere quella che è probabilmente la natura illusoria di ogni distacco:
«Tu vai per la tua, e io vado per la mia:
molteplici vie seguiamo;
per molti giorni, per molte strade,
che finiscono tutte in una.
Molti gli errori, e molte le composizioni per sanarli;
molte parole, e molte locande:
molti spazi da percorrere, ma solo una dimora
che in tutto il mondo valga la pena di raggiungere».[6]
Nuovamente a Hemis
Il ritorno a Leh, dopo l’esperienza nell’eremo e la notte nel villaggio, è stato relativamente frustrante. Dopo una serata di chiacchiere bevendo whiskey indiano scadente e fumando la mia pipa, avvolto nei racconti del mio compagno di guesthouse Derek che mi ha portato in volo narrativo nell’Eelam[7] ― i cui palmizi erano stati in buona parte capitozzati da una guerra interminabile e spietata e dove tutto concorreva a tessere le fila di un lungo racconto di morte ― non posso non progettare una nuova visita alla famiglia ladakha. E poi, se è vero che non bisogna lasciare che la meta diventi più importante del viaggio, bisogna evitare, al contempo, di disperdersi eccessivamente, mancando l’opportunità di giungere alla meta agognata, per quanto improbabile possa essere. Il mio primo sopralluogo a Hemis ha portato qualche risultato. Ho avuto modo di visitare il famoso museo, di parlare con Jigme che ne è il responsabile, oltre a essere l’uomo di fiducia dell’Head Lama. Gli ho potuto chiedere informazioni in merito ai manoscritti e alla possibilità di ottenere un incontro con la sola persona che ne può autorizzare la visione.
Jigme mi conferma quanto trovo scritto nel libricino The monasteries of Hemis, Chedme and Dagthag[8], in vendita nel negozio del museo: i manoscritti dovrebbero essere in una stanza segreta chiamata dzodnag dai locali. Solo l’Abate di Hemis, Sua Eminenza Taktsang Rinpoche può romperne i sigilli, consentendo l’accesso alla stanza e, eventualmente, ai manoscritti. Taktsang Rinpoche, tuttavia, vive a Lhasa e, nello stesso libricino sta scritto non avrebbe obiezioni a incoraggiare ricercatori sinceri tanto che ha ufficialmente richiesto che questi vengano aiutati nel reperimento degli antichi documenti. Non è mancato chi ha raggiunto il monastero con una lettera dell’Abate ma non ha avuto modo, stando almeno a quanto si sappia, di visionarli. Ancora sul libricino viene riportato che la sola entrata allo dzodnag si ha dalla camera privata dell’Abate. Dopo aver letto quanto riportato mi rivolgo a Jigme, sperando di ottenere qualche elemento in più. Lui come altri monaci che interpello mi dice che nessuno sa dove siano i manoscritti e che anche l’ubicazione dello dzodnag è, in realtà, un mistero.
Raggiungo la casa della famiglia ladakha dove siamo stati ospiti con Miro, trattenendomi un paio di notti, constatando ancora come la condizione naturale di questa gente sia il silenzio, lo stesso di cui sono circondati a livello naturale. Parliamo difatti di un contesto che può, lontanamente, ricordare quello artico. I pochi alberi, come accennavo, sono a valle, salendo lungo i dorsali montani la vegetazione si limita a radi cespugli per poi lasciare spazio alla nuda terra, coperta da un manto minimale, in certa misura assimilabile ai muschi e ai licheni. Gli stessi animali sono silenziosi. Solo saltuariamente il silenzio è rotto dal gracidare di un volatile. Lo stesso silenzio pervade gli interni spartani e del tutto essenziali. Ho modo di intavolare qualche scarna conversazione, agevolato dal fatto che i miei ospiti conoscono un minimo l’inglese e io ho rudimenti di hindi. La loro madrelingua, tuttavia, è il ladakhi, simile al tibetano. Ma non è la lingua a rendere sporadici e asciutti i nostri scambi verbali bensì la loro attitudine, la loro condizione naturale fatta di poche, scarne parole. Sono sempre io a dover stimolare la conversazione.
Loro rispondono in modo gentile, finanche dolce ma nel momento in cui esauriscono il loro breve discorso o la risposta secca a una domanda, ritornano silenziosi. Nel corso della mia permanenza, condividiamo dunque un silenzio che non ha nulla di imbarazzante, che non svela vuoti da colmare, tutt’uno con la pienezza silenziosa, asciutta al punto di spaccare le labbra e crepare la pelle con piccoli fiotti di sangue coagulato, del contesto naturale. Le parole, inutili, rocambolano lungo i dorsali della coscienza, come pietre a inabissarsi in un fiume e rimane solo la pienezza del silenzio d’oro, più antico delle più antiche espressioni del creato. Subentra la netta sensazione che qualunque cosa si dica sia di troppo. Si lascia sia la realtà di quei momenti a raccontarsi, divenendone semplici testimoni. E dopo essere cadute le parole, iniziano a cadere i pensieri, lungo il cigolare di una vecchia-scassata porta di legno e si rovescia, finalmente, il capzioso assunto cartesiano: penso dunque sono, lasciando il posto a uno più attendibile: sono dunque sono. Questo potrebbe davvero neutralizzare l’arroganza dell’Occidente che lastrica la strada del suo profetizzato tramonto[9].
Nel corso del mio breve soggiorno nel villaggio di Hemis ho modo di conoscere il nipote del proprietario di casa. Ha circa sedici anni ed è entrato in monastero quando ne aveva nove. Studia in una scuola monastica. Gli spiego il motivo principale della mia visita, la meta del viaggio. Anche lui non sa dirmi nulla dello dzodnag e mi conferma che l’abate è in Tibet. Mi regala un cartoncino con l’immagine di Taktsang Rinpoche accanto al Gyalwang Drukpa. Indicandomi quest’ultimo mi dice che vive in Nepal. Penso tra me che dovrò comunque visitare il paese per ottenere un nuovo visto per rimanere altri tre mesi in India, che al momento una visita in Tibet potrebbe presentare alcune complicazioni e che dunque posso concentrarmi su una, più semplice, presso il centro di residenza del capo-lignaggio e tentare lì di fare qualche passo ulteriore. Prima di lasciare Hemis chiedo cautamente al giovane monaco se è contento (come sembra) della sua condizione e se ha ogni tanto un pur vago desiderio di vita mondana. La sua risposta è lapidaria:
«Noi (monaci) siamo persone diverse!».
Subito dopo, torna alla sua condizione, naturale, di silenzio.
Restiamo silenziosi per qualche minuto poi lui si alza e, congedandosi in maniera altrettanto asciutta e, tuttavia, affabile, mi lascia solo nella stanza degli ospiti, a osservare il dileguarsi dei miei pensieri in quel silenzio d’oro.
Per approfondire
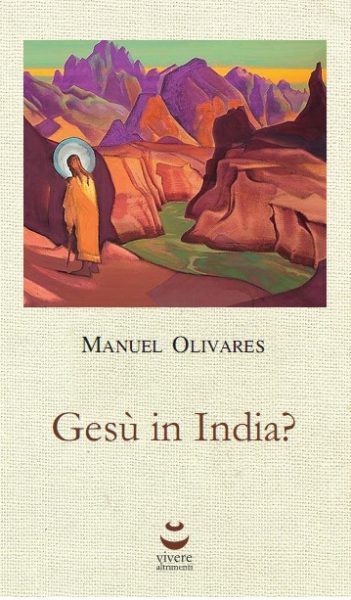 Gesù in India? Il punto interrogativo è, probabilmente, doveroso.
Gesù in India? Il punto interrogativo è, probabilmente, doveroso.
L’ipotesi che Gesù abbia vissuto buona parte della sua vita in India, negli anni di cui non parlano i vangeli (che lo presentano, bambino, nel tempio di Gerusalemme e poi, dopo circa sedici anni di vuoto, ne raccontano l’inizio della predicazione) e negli anni successivi alla crocifissione ― cui, secondo alcuni, sarebbe sopravvissuto ― viene dibattuta da lungo tempo. Naturalmente, considerata nella sua integrità o accettandone solo alcune versioni, ha sempre riscosso e continua a riscuotere particolare successo nella stessa India, tanto nell’ambito dei suoi diversi filoni sapienziali quanto tra le persone comuni.
In Europa la controversa questione degli anni indiani di Gesù ha iniziato a prendere corpo alla fine dell’Ottocento.
Nel corso di oltre un secolo testi cruciali hanno visto la luce, alimentando diverse scuole di pensiero: nicchie culturali, più o meno rilevanti, nell’ambito dell’Induismo, del Buddhismo, dell’Islam, del mondo New Age, dei nuovi movimenti religiosi e di quello, genericamente, laico/secolare.
Verranno considerate in maniera il più possibile esauriente, lasciando naturalmente che i lettori ― in base alla propria fede o attitudine laica ― traggano le conclusioni a loro più congeniali.
Avanzare sul sentiero di un Gesù transculturale, non più sola prerogativa dell’Occidente cristiano, può essere di grande beneficio all’uomo nuovo/globalizzato. Un Gesù transculturale può aiutare a ridurre le distanze tra mondi che si considerano, forse erroneamente, ancora molto diversi e, allo stesso tempo, infondere nuova energia a una cristianità inesorabilmente in crisi.
Manuel Olivares, sociologo di formazione, vive e lavora tra Londra e l’Asia.
Esordisce nel mondo editoriale, nel 2002, con il saggio Vegetariani come, dove, perché (Malatempora Ed). Negli anni successivi, ancora con Malatempora, pubblicherà: Comuni, comunità ed ecovillaggi in Italia (2003) e Comuni, comunità, ecovillaggi in Italia, in Europa, nel mondo (2007). Nel 2009 fonda l’editrice Viverealtrimenti, per esordire con Un giardino dell’Eden, il suo primo testo di fiction e Comuni, comunità, ecovillaggi, il suo terzo su un antico e moderno movimento di comunità sperimentali ed ecosostenibili.
Nel 2011 pubblica Yoga based on authentic Indian traditions, il suo primo libro in inglese (tradotto, nel 2013, con il titolo Yoga dall’autentica tradizione indiana) e Barboni sì ma in casa propria, una raccolta di racconti e poesie. Nel 2012 pubblica Con Jasmuheen al Kumbha Mela, dipanando un interessante accostamento tra new age e tradizione.
Gesù in India? ha preso corpo in circa dieci anni di studi e ricerche sul campo (prevalentemente in Kashmir, Punjab e Ladakh) avendo costantemente come base la città santa di Varanasi dove l’autore ha speso, nel periodo suddetto, la maggiorparte del suo tempo.
Leggi un’intervista all’autore
Leggi un articolo sull’argomento
Prezzo di copertina: 14 euro Prezzo effettivo: 12 euro
[1] Monaco indiano, buddhista, dell’ottavo secolo, autore del celebre poema Bodhicaryavatara.
[2] Ananda K. Coomaraswamy, Buddha e la dottrina del Buddhismo, op. cit., p. 320.
[3] Nella seconda metà dell’ottavo secolo, il re tibetano Khri Srong-Ide-btsan invita l’abate della celebre università di Nalanda ― nell’attuale stato indiano del Bihar ― in Tibet. Il nome dell’abate è Śāntaraksita (725-783) e lo stesso viene considerato «un illustre esponente delle principali dottrine analitiche e razionalistiche degli indirizzi del Hīnayāna [Piccolo veicolo] e Mahāyāna» (R.N. Prats, Le religioni del Tibet, in: Giovanni Filoramo ― a cura di ― Buddhismo, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 150).
Scopo della missione di Śāntaraksita in Tibet è la fondazione di un primo monastero buddhista e l’ordinazione di monaci tibetani. L’ostilità dei seguaci della religione tradizionale locale, il Bon-po, tuttavia, lo costringe ad abbandonare il paese.
«Fu allora che, su suo consiglio, si decise di invitare un guru che era preceduto da una particolare aureola di taumaturgo: Padmasambhava, originario di Uddiyāna [Antica contrada dell’Asia centrale. La si è identificata spesso con la vallata pakistana dello Swāt, ma potrebbe trattarsi anche della Sogdiana, vasta regione dell’antico impero persiano localizzata in una gran parte delle odierne repubbliche di Uzbekistan e Turkmenistan, che cadde sotto gli arabi all’inizio dell’ottavo secolo]. Con lui arrivarono le dottrine e le pratiche del buddhismo iniziatico, che si dimostrarono l’arma adeguata per favorire l’insediamento di quella confessione straniera. Il successo di Padmasambhava fu totale, riuscendo egli a debellare persino i numina del luogo che si opponevano al Dharma.
L’edificazione del complesso monastico di bSam-yas [Sam yé], condotta sul modello di un tempio indiano a struttura di mandala (quasi certamente quello di Odantapuri), poté essere condotta a termine. Il santuario, fondato nel 775, fu consacrato quattro anni dopo. L’evento fu rinsaldato da un editto reale in favore del Buddhismo. Lo stesso anno, sette tibetani, scelti tra i membri della nobiltà, furono ordinati monaci da Śāntaraksita ― il primo abate di bSam-yas ― che fu coadiuvato nella cerimonia da una dozzina di monaci provenienti dal monastero indiano di Vikramaśīla […]».
(Ibidem)
[4] Ananda K. Coomaraswamy, Buddha e la dottrina del Buddhismo, op. cit., p. 320.
[5] Celebre località montana nello stato indiano dell’Himachal Pradesh.
[6] Ananda Coomaraswamy, Il Buddha e la dottrina del Buddhismo, op. cit., p. 197.
[7] Territorio a maggioranza Tamil nello Sri Lanka del nord che ha tentato invano, nel corso di una guerra durata, tra alterne vicende, alcuni decen-ni, di ottenere l’indipendenza.
[8] Citato in bibliografia ma credo sia quasi impossibile trovarlo fuori dal Ladakh.
[9] Un libro dal titolo profetico, in questo senso, uscì nel 1918. Parliamo de Il tramonto dell’Occidente, di Oswald Spengler.

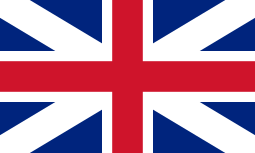 English
English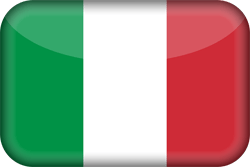 Italian
Italian