Passeggiata a Kowthaung

Un bel report di viaggio del nostro nuovo, prossimo autore Filippo Gregoretti. Abbiamo in cantiere la pubblicazione della sua raccolta Cronache psicogeografiche; storie di ordinaria schizzofrenia di cui abbiamo deciso di darvi, qui, un assaggio. Buona lettura!
“Non c’è niente da vedere lì”, così diceva un americano, con i denti da coniglio, incontrato sulla visa-run boat.
Partiti da Surat-Thani alle otto di mattina, dopo un fugace riso fritto col pollo, ci svegliamo improvvisamente all’arrivo a Ranong, sulla costa ovest della penisola del Siam, appena in tempo per scendere dallo sgangherato autobus, evitando di risvegliarci in luoghi ignoti.
In un tailandese stentato riesco a contrattare con due motociclisti un passaggio prima all’ufficio immigrazione e poi al molo da cui partono le barche per la Birmania, ormai ribattezzata “Myanmar” dai militari che stringono il paese in uno dei peggiori regimi dittatoriali.
Mi sembra di essere riuscito ad accordarmi per cento baht, circa tre euro, una cifra di tutto rispetto da queste parti, per il trasporto mio, di Ema, la mia ragazza e compagna di viaggio, e dei nostri bagagli. Ema non parla il tailandese e mi osserva frastornata, ancora in preda al sonno, mentre fingo di capire ciò che dicono i due improbabili autisti locali. Sull’onda di quello strano, contraddittorio miscuglio asiatico di lentezza e velocità, in un lampo siamo in sella alle moto, i bagagli incastonati precariamente tra i nostri corpi, e partiamo traballanti alla volta dell’ufficio immigrazione.
Durante il tragitto, partecipando con scarso entusiasmo alla conversazione con l’autista, osservo Ranong. Sembra molto diversa dalla tipica città tailandese a capo di un distretto provinciale. Eccettuata Bangkok, sorta di Babilonia a sè stante, le città Thai hanno una struttura molto semplice: ruotano intorno a pochi “Thanon”, grandi viali a più corsie intitolati ai regnanti, su cui sfrecciano motorini, tuk tuk (taxi a tre ruote), songtiaew (pick-up riadattati a trasporto persone) insieme a veicoli dei tipi più improbabili che spaziano dalle Mercedes ultimo modello a elefanti con fanalino lampeggiante agganciato alla coda. Ranong appare differente. Non ha un vero e proprio centro ma si snoda lungo il mare, sui vari moli dove si mercanteggia pesce e merce contrabbandata dalla vicina Birmania.
Tailandia e Birmania condividono la stretta penisola indocinese per circa mille chilometri. Ne occupano due strisce contigue, molto sottili, divise dal fiume Kraburi fino a formare l’estuario di Packchan, profondo un centinaio di chilometri. La Birmania termina qui, formando la Penisola Malese, con una piccola cittadina chiamata Kowthaung o Victoria Point, come la battezzarono i colonizzatori. Kowthaung è l’unico punto di accesso in Birmania, eccettuati i costosi voli diretti nella capitale, dove si può ottenere un visto di entrata che consenta di pernottare nel paese.
Il motociclista cui mi sono affidato imbocca un gigantesco viale, naturalmente contromano e, incurante dei miei improperi, raggiunge l’Immigration Office tailandese. Entriamo ostentando deferenza e rispetto, condotta che aiuta sempre quando si è alle prese con la burocrazia asiatica. Con grande sorpresa notiamo due italiani, visibilmente contrariati, seduti al di là del bancone. Ci dicono di essere in attesa da alcune ore che i burocrati di frontiera tailandesi finiscano di esaminare i loro passaporti. La cosa mi preoccupa: sono già le 14.30 e dobbiamo ancora trovare una barca che ci porti a Kowthaung. Consegno il mio passaporto all’impeccabile funzionario che lo mette insieme a quelli degli altri italiani in attesa. Avendo notato il movimento inizio seriamente a preoccuparmi, ma continuo a sorridere e a parlare a voce bassa in segno di rispetto. In fondo è facile, anche solo col linguaggio del corpo, esprimere rispetto e sottomissione nei confronti di chi è più in alto nella gerarchia. Con mia sorpresa, il passaporto viene esaminato per soli 10 minuti e mi viene restituito timbrato e firmato. Gli italiani continuano sbuffare e rimangono seduti lamentandosi. Inizio a pensare che sia proprio il loro atteggiamento la causa delle ulteriori ore di noia che passeranno nel buio ufficio Thai. Arrabbiarsi e spazientirsi, da queste parti, serve solo a rendersi ridicoli e, talvolta, ad attirare guai. Invece, quando a diecimila chilometri da casa un funzionario tiene stretto in mano il tuo passaporto, riconoscergli il potere che ha sulla tua vita attraverso un atteggiamento di deferenza, fa accedere al gioco delle gerarchie, e predispone il tuo superiore, vedendo riconosciuto il suo status, a svolgere correttamente il suo lavoro garantendo anche un certo grado di protezione.
Una volta approvato il mio passaporto, quello tedesco di Ema viene firmato e timbrato senza neanche uno sguardo. Salutiamo i due italiani, ancora più seccati per via della nostra performance e, di nuovo contromano, ci avviamo verso il molo sulle traballanti “motolbàic”. Piove e si è fatto tardi, e non amo andare in moto contromano mentre arrivano in direzione opposta camioncini carichi di ananas e pesce, soprattutto se non sono io a guidare.
Arrivati al molo, inspiegabilmente ancora vivi, per scoprire che i cento baht contrattati erano una mia illusione, frutto di un equivoco linguistico e i driver ne chiedono trecento: una follia! Contrattiamo nello stile di Zio Paperone-Rockerduck e, per arrivare a cento, io parto da quaranta e loro da duecentottanta così, a coppie di numeri discendenti (40-280, 50-260, 70-250, ecc.), arriviamo a centoquaranta. Lascio loro centoventi e scappiamo verso le barche.
Dobbiamo cercare una Long-Tail Boat (barchetta longilinea con una lunga coda usata per manovrare l’elica) disposta a portarci dall’altro lato per duecento baht – il costo corrente confermato dai funzionari dell’immigrazione – quando inaspettatamente appare ai nostri occhi un tailandese molto ben vestito. In perfetto inglese da Oxford, ci offre di portarci dall’altra parte del golfo per il doppio della cifra. Aspettandomi contrattazioni in Thai con un pescatore musulmano, rimango interdetto dall’apparizione del sobrio businessman ma rifiuto gentilmente offrendone duecento. Dopo una breve discussione con un altro uomo in dialetto del sud, il nostro englishman alla fine accetta con un laconico “questo è un prezzo molto speciale, solo per voi”, per non perdere la faccia davanti agli altri passeggeri. Felici per lo “special price” entriamo nella bagnarola consegnando i nostri passaporti, insieme ai dieci dollari necessari per il visto birmano, a un dolcissimo marinaio Thai, talmente timido da non riuscire a guardarci in faccia senza sorridere.
E’ strabiliante la facilità con cui si può consegnare quel fragile libretto di carta, così importante quando siamo in viaggio, nelle mani di perfetti sconosciuti. Eppure, in molte parti del mondo, l’istinto è la voce più importante per capire di chi ci si può fidare. Incredibilmente, dove la legge manca e l’autorità è solo un mezzo per arricchirsi, il contratto verbale e la parola data diventano garanzie quasi sempre sufficienti. Raggiunta la barca comprendiamo il motivo di un prezzo così alto: ci troviamo su una VISA-Run boat.
Il visto turistico gratuito per entrare in Tailandia è valido solo 30 giorni. Per restare nel Regno dopo la scadenza, in alternativa a multe salatissime o sgradevoli permanenze in cella, è possibile ricorrere a costose estensioni, investendo giorni a confrontarsi con code e burocrazia. Una comoda scorciatoia consiste nel fare un VISA-Run (corsa per il visto) mensile. E’ sufficiente lasciare il territorio tailandese anche per pochi minuti per ottenere, una volta rientrati, un nuovo visto gratuito di trenta giorni. Non è difficile in un paese in cui non si è mai a più di qualche ora da un confine.
La nostra VISA-Run boat è piena di stranieri residenti in Tailandia che, in cambio di pochi soldi e qualche ora di tempo, mettono piede sul suolo birmano il tempo necessario per ottenere, al ritorno, un nuovo visto tailandese.
Saliamo sulla barca, che ospita già una decina di persone tra asiatici e occidentali, e prendiamo posto accanto ad un signore con i capelli bianchi. E’ buffo il rapporto che si crea tra occidentali incontrandosi in luoghi remoti. Si prova un misto tra la gioia di trovare una persona culturalmente vicina e un profondo disappunto. Difatti, in fondo al cuore, vorremmo sempre essere l’unico, il solo Marco Polo, primo testimone dell’Ovest a spingersi nel regno degli Han. Invece la guida Lonely Planet, salvezza e tortura dei viaggiatori dell’era moderna, condanna ad incontrarsi nei posti più incredibili. Mentre faccio queste considerazioni e osservo i presenti, giuro a me stesso che dal prossimo viaggio rinuncerò alla guida.
“Non c’è niente da vedere lì, siete pazzi a rimanerci per più di 10 minuti”, continua a ripetere l’americano con i denti da coniglio seduto accanto a me. Probabilmente è un residente in Tailandia da parecchio tempo e avrei molto da imparare da lui ma non mi fido dei “farang” (straniero in tailandese) che parlano con l’aria di saperla lunga e senza ombra di dubbio o umiltà nella voce. Vorrei rispondergli che in qualsiasi angolo del mondo c’è qualcosa che vale la pena vedere, ma mi limito a ridere ripensando alla sua frase e continuando ad ascoltare le sue considerazioni, cercando di trarne qualche insegnamento.
Mentre ci allontaniamo dal molo osservo la costa, ammirando uno scenario tailandese ormai familiare. I colori solitamente forti e brillanti, sono ammantati da un cielo cupo e nuvoloso che li rende irreali. Avvolti in un vapore umido e caldo sono i segni della costa Thai: tante barche, case, panni stesi ad asciugare, bambini, cani, attività ma, soprattutto, risplendono nella foschia le moltissime riproduzioni dorate di Buddha, alte come case, sparpagliate sulla costa e sulle isolette.
All’improvviso sopraggiunge una pioggia a dirotto e il mare si è alzato parecchio. La barchetta sobbalza e il povero marinaio, seduto fuori dal telo di plastica che protegge noi passeggeri paganti, si inzuppa completamente. Penso ai nostri passaporti, chiedendomi se sono bagnati come lui, poi decido di smettere di torturarmi e lascio il nostro destino nelle mani di Buddha.
Sulla barca viaggia anche una signora thai di mezza età che, nonostante gli scossoni, rimane calma e composta mantenendo quell’atteggiamento femminile e aggraziato che le donne del Siam non abbandonano mai. Rimango sempre stupito da queste creature. Ne ho viste in situazioni che avrebbero fatto impallidire un motociclista nerboruto: ammassate su camioncini con tutta la famiglia, i mobili, una mucca e i maiali; su motorini sgangherati lanciati in corsa su ripide discese fangose; in cucine arroventate tra pentoloni gorgoglianti e interiora di animali…
Nonostante le scomodità, i rischi e gli scossoni, rimangono femminili, composte e aggraziate. Mamme o nonne fatate che mantengono una dignità angelica in ogni circostanza.
Si avvicina la costa birmana e, dopo un’oretta di pioggia e mare agitato arriviamo, insieme a un implacabile sole, sul molo di Kawthaung.
Kawthaung – Koh Song – Victoria Point
La mia avversione per le uniformi cresce al cospetto di regimi autoritari, ma il sorriso del funzionario della dogana mi conquista insieme alla canottiera macchiata, le ciabatte e i polli che scorrazzano sotto il tavolo. Forse quel sorriso è anche frutto dei dieci dollari necessari per il bel timbro birmano, o forse è l’ennesima conferma della contraddizione che più mi colpisce in Asia, dove l’estrema dolcezza riesce a convivere con la brutalità più spietata.
Ci informiamo sulle nostre possibilità di spostamento, e scopriamo che non ci si può muovere più di due chilometri a nord senza essere bloccati o arrestati dai militari. In alternativa, si rischia di essere rapiti o derubati dai ribelli Hmong, la cui guerriglia è ancora attiva nel sud del Myanmar. Mi chiedo se sia la verità, oppure un pretesto per evitare che occhi indiscreti testimonino l’assurda realtà della dittatura birmana. Mentre raccolgo le confortanti notizie, in attesa del passaporto timbrato, osservo il movimento del porto.
Siamo solo a un’ora di barca, eppure sembra di essere atterrati su un altro pianeta. Immagino che la Thailandia di sessanta anni fà sia stata simile allo spettacolo che abbiamo davanti agli occhi: un formicaio in frenetica attività dove uomini, animali, motorini, motrici diesel, barche di ogni forma e misura si accalcano in un risuonare di rumori e voci che si mischia col rombo impetuoso dei motori senza marmitta delle Long Tail Boat. L’odore è pungente come nei porti tailandesi – quel familiare misto di smog, merda e pesce marcio – ma molto più forte. Immediatamente ci accalappia il giovane Ali, che si offre di diventare la nostra guida e il nostro risolvi-problemi, ma non vogliamo filtri tra noi e lo spazio che ci circonda. Inoltre, non mi piace il suo atteggiamento occidentalizzato, pieno di “yeah”, “pollici in su” e pose varie che i giovani locali identificano con la “modernità”, ispirati da pessimi film di Hollywood. Scaricato Ali e ripresi i passaporti ci avviamo verso l’Honey Bear Hotel, il più economico tra gli unici due posti autorizzati ad ospitare stranieri. I primi passi in Birmania sono incerti, un po’ condizionati dalla frase dell’altro straniero a bordo della Visa Run Boat: “la gente qui ti guarda come una preda: vogliono solo i tuoi soldi”. Molti uomini in Longy, il tipico pareo birmano, si avvicinano per offrirci un trasporto in Tailandia ma sono molto simpatici e non insistono quando, in un thai smozzicato, gli spieghiamo che siamo appena arrivati ed abbiamo intenzione di rimanere. In molti ci salutano: “hello”, “where you go”. I loro sorrisi e la loro spontaneità smentiscono la frase dello straniero e ci accompagnano piacevolmente lungo il breve tragitto che separa il molo dall’albergo. L’Honey Bear Hotel è un edificio squadrato e decadente che affaccia direttamente sul porto. Alimentato da 2 giganteschi gruppi elettrogeni esposti ai lati della facciata principale. Entriamo e ci accolgono delle eleganti ragazze birmane che non parlano una parola d’inglese e, anche loro in thai smozzicato (per fortuna qui nessuno da per scontato che parliamo birmano), ci comunicano che la camera più economica costa settecento baht. Accipicchia! Penso io, abituato per lo stesso prezzo a fare tre giorni a pensione completa su un’isola. Ma non abbiamo scelta e, ancora una volta, consegnamo i passaporti nelle mani fidate di una simpatica sconosciuta. Una volta registrati veniamo affidati a due angelici camerieri che avranno massimo quattordici anni. Con piglio professionale e perfettamente pettinati, afferrano i nostri bagagli. Il più mingherlino dei due si carica il mio zaino che, essendo dotato di ruote, è stato riempito delle cose più pesanti. Noto la sua espressione eloquente, che traspare nonostante il desiderio di non deluderci e, dopo i primi scalini, stacco un’estremità dello zaino carica di libri alleggerendo non di poco il fardello, venendo ricompensato da un timido sorriso di gratitudine.
La camera è spaziosa, pulita e luminosa e, come tutti gli alberghi e le guesthouse da queste parti, risplende di una sorta di “effetto Flinstones”, in onore del celebre cartone animato ambientato nell’età della pietra: c’è tutto, tutto funziona ma sembra tutto scassato e un pò rozzo. E’ proprio quanto più amo di questi posti.
Dopo tanto viaggiare siamo felici di fare una doccia, ma resistiamo alla tentazione del pisolino per sfruttare le poche ore di luce rimaste prima dell’inesorabile, sempre troppo puntuale, notte tropicale. Ansioso di tuffarmi nelle strade birmane, metto fretta ad Ema che si sbriga lamentandosi e, finalmente, ci mettiamo in cammino, affrontando un pò timorosi la nostra prima passeggiata a Kowthaung.
“In Myanmar there is no democracy”
(non c’è democrazia in Birmania)
Finalmente, dopo le prevedibili greggi di nostri simili in Tailandia, ci sentiamo veramente stranieri. Non appena ci allontaniamo dal porto inoltrandoci tra le salite di Kowthaung, ci rendiamo conto di quanto siamo lontani da casa e di come, essendo veramente degli alieni, la sola nostra presenza susciti scompiglio e divertimento nei birmani, meravigliati nel vedere due occidentali scorrazzare nel mezzo della loro realtà. Non sappiamo bene dove andare e ci sentiamo un po’ intimoriti a causa del passaggio così brusco dalla rassicurante Tailandia alla povera, sconquassata Birmania. Ci avviamo verso l’interno, tra sguardi divertiti o attoniti, muovendoci verso nord su una stradina circondata da negozietti. La merce in vendita è un campionario ridotto di quella che si trova nei mercati thai; unica aggiunta sono i longy, parei tubolari a quadretti dai riflessi sgargianti che uomini e donne indossano con disinvoltura come fosse una lunga gonna. Mi piacciono i tanti, poverissimi ristorantini dove i birmani passano il tempo bevendo caffè. Dovunque andiamo è in corso un’attività apparentemente frenetica ma, in realtà, sorprendentemente calma. Centinaia di motorini Honda e Suzuki muovono in ogni direzione. Alcuni solo col conducente, altri stipati tra passeggeri, mercanzie e animali. Non si notano automobili salvo qualche assurda motrice diesel, di quelle che si accendono da dietro avviando il motore con una corda, o qualche fuoristrada o pickup: probabile proprietà di quei pochi che possiedono tutto quel che c’è da possedere qui.
Quasi tutti i passeggeri dei tanti motorini, stranamente, indossano il casco. Molti di più che in Tailandia o a Napoli. Presumo che il motivo di tanta prudenza sia più da ricondurre a qualche moda, o sfoggio di ricchezza, che alla paura delle multe. Anche perchè il casco più gettonato è un elmetto da soldato nazista con tanto di svastica da un lato e simbolo “SS” dall’altro!
Abbiamo incrociato l’orario di uscita dalle scuole e sul cammino incontriamo tantissimi bambini e adolescenti che tornano a casa, tutti fasciati da una divisa bianca e verde che rende i loro sorrisi increduli ancora più vivaci. Ci guardano divertitissimi e qualcuno azzarda dei timidi “hello” per poi coprirsi il viso imbarazzato quando gli rispondiamo. Uomini, donne, grandi o bambini, quasi tutti hanno il viso decorato da una tintura bianca. Alcuni portano semplicemente delle righe confuse o chiazze di colore, altri sfoggiano decorazioni più complesse, come cerchi concentrici o linee simmetriche. Scopriremo in seguito che quest’usanza ha qualcosa a che vedere con la devozione a Buddha e la cura del viso. In ogni caso l’effetto è molto bello e strano…
Naturalmente, nel mezzo di tutta l’attività umana e meccanica, tra le voci e i clackson, scorrazzano indisturbati cani, gatti, maialini e polli in quantità. Mentre passeggiamo si fermano due ragazzi in motorino che ci salutano con il “where you go?” (dove vai?) di prassi. A volte sentirsi chiedere “where you go?” all’improvviso può sembrare indiscreto e fastidioso, ma anche nella lingua birmana, come in tailandese, chiedere “dove vai?” è una formula di cortesia simile al “come stai?”. In effetti ci viene rivolta la stessa domanda decine di volte. Noi rispondiamo con un “pai tiao”, che in tailandese significa qualcosa tipo “vado in giro a vedere un po’ che succede, senza meta, a godermi la giornata”. Alcuni, i pochissimi che sanno qualche parola d’inglese, la sfoggiano rispondendo: “ahhh… sightseeing!”, gli altri semplicemente ridono, soddisfatti di avere interagito un po’ con noi.
I ragazzi in motorino parlano un po’ d’inglese poichè, come ci spiegano, lavorano all’Amara Hotel, unico altro albergo della zona, da noi accuratamente evitato per via dei quasi cento euro a notte per una camera. Pare che l’Amara, dotato di Casinò moderno e confinato su un’isola, quindi lontano da povertà e sporcizia, sia frequentato da ricchi thai e cinesi che vengono a godersi il gioco d’azzardo a poche ore da casa.
I due sono di Yangoon, la capitale. Ci dicono che si annoiano in provincia e che, se vogliamo, possono trovarci una moto e farci da guida. Visto lo spazio in cui siamo confinati la moto non ci serve, e decidiamo di vivere il tempo a piedi, per godere meglio dei vari vari “where you go?”. Li ringraziamo e chiediamo dove possiamo mangiare qualcosa di buono. Ci dicono che probabilmente il nostro albergo ha il miglior ristorante di Kowthaung. In effetti non mangiamo da parecchie ore e, vista la fame, come primo giorno ci accontenteremmo di un menu tradotto in inglese. Decidiamo allora di tornare verso il molo facendo il giro più lungo, per la cima della città. Continuiamo a salire e, poco più avanti, deviamo verso sud, inerpicandoci su una strada laterale e facendo attenzione alle innumerevoli voragini che rompono il pavimento mostrando segmenti di fogne e creando trabocchetti insidiosi. L’aria è piena di odori… il più presente è quello, naturale in ogni agglomerato umano, di fogna e decomposizione che, unito alla benzina, il pesce, il fritto, il caffè e l’incenso contribuisce alla magia, offrendoci al caldo abbraccio della convivenza umana, così come è sempre stato, e che dimentichiamo troppo facilmente nelle nostre asettiche città.
All’improvviso ci imbattiamo in un cancello colorato, decorato da semplici disegni e scritte in birmano, che con quei caratteri tondeggianti ed esotici evoca lingue fatate. Non riusciamo a capire di che si tratti, ma ci attira il lungo viale alberato e il silenzio oltre la soglia. Esitiamo indecisi davanti all’ingresso, quando dall’uscio di un basso edificio appare un ragazzino che, notata la nostra timidezza, con un sorriso disarmante ci invita a gesti ad entrare. Muoviamo alcuni passi verso il viale e ci rendiamo lentamente conto di essere entrati in un convento. Arriviamo in un grande giardino ombreggiato da palme, spoglio ma ordinato. Ci sono due grandi edifici di legno e, nel mezzo, vediamo un gruppo di monaci, bambini e ragazzi, che giocano a “sepak takraw”: sorta di calcio acrobatico con una palla di legno intrecciato. Rimango sempre esterrefatto, in questi angoli del mondo, dalla grazia con cui riescono a compiere difficilissime acrobazie calciando una palla di legno durissima, col collo del piede, ad altezze incredibili. Si accorgono di noi e ci indicano, con naturalezza, uno degli edifici, come fossimo attesi. Un bambino ci scorta su una scaletta esterna verso una piccola porta di legno. Lo seguiamo leggermente intontiti e, oltrepassata la soglia, ci troviamo nella sala di preghiera del convento. E’ una stanza grande e squadrata, occupata per un terzo da una pedana di legno rialzata di circa un metro. Sulla parete in fondo alla pedana, affrescata con immagini sacre, una piccola pagoda contiene una statua del Buddha, una pila di libri e altri oggetti. Il Bambino sale sulla pedana dai colori sgargianti e, dopo essersi inginocchiato e aver poggiato la fronte sul pavimento in segno di devozione, con le mani congiunte nel “whai” più deferente, sveglia un monaco appisolato in un angolo, su una stuoia, circondato dagli oggetti sacri. La sala è semplice e spoglia ma emana un senso di sacro, di antiche conoscenze non in grado di competere, sul piano materiale, con la scienza moderna ma che incutono un senso di rispetto infinitamente più profondo.
Il monaco si sveglia, leggermente intontito, e ci nota. Superata la sopresa iniziale sorride benevolo invitandoci ad avvicinarci. Comprendo che si tratta dell’Abate e, non sapendo come si saluta un monaco in Birmania, mi profferisco in un Whai alla tailandese, portando le mani fin sopra la fronte, come si fa con l’immagine del Buddha.
Il monaco scoppia in una gran risata, non aspettandosi il gesto forse esagerato e ci incoraggia a salire sulla pedana con lui.
L’Abate è giovane, avrà al massimo trent’anni. Si percepisce che è perfettamente a suo agio nell’importante ruolo che ricopre con evidente modestia e semplicità.
Da una porta laterale arriva un altro monaco, più anziano e con gli occhiali, sorridendo senza risparmio. Parla un pochino di inglese. Ci saluta e ci da il benvenuto presentandoci all’abate.
Siamo storditi. Neanche un minuto prima vagavamo senza meta in una città sconosciuta e ora eccoci accolti dall’Abate del convento come attesi emissari di un paese lontano.
Il monaco sorridente dice due parole in birmano al bambino che ci ha accompagnato, il quale sparisce per tornare con dei bicchieri e una bottiglia d’acqua per dissetarci.
Siamo seduti in cerchio sulla pedana della sala di preghiera e, lentamente, arrivano altri monaci che si siedono intorno a noi. L’abate sembra felice della nostra presenza ma non parla inglese e la conversazione passa attraverso l’altro monaco. Ci chiedono da dove veniamo, dell’Europa, dell’Italia, del nostro viaggio, del nostro lavoro, e sembrano desiderare una sola cosa: conoscere.
Siamo sconvolti da quest’accoglienza così calda e naturale e siamo leggermente a disagio poichè, da menti occidentali, attendiamo il momento in cui la conversazione arrivi al punto cruciale, ossia il “motivo” della nostra visita al convento. L’implicita domanda “perchè sei qui?” che ovunque andiamo aspettiamo ci venga posta e alla quale vogliamo sempre avere una risposta pronta. Una giustificazione, una motivazione delle nostre azioni e della nostra stessa esistenza, necessaria a colmare quella distanza dallo spirito che ci rende così difficile accettare la semplicità dell’essere.
Ma con nostra sorpresa, la domanda non arriva mai. Neanche un accenno o un’allusione; invece, all’improvviso, per rinfrescarci ulteriormente, ci vengono portate delle noci di cocco fredde, aperte su un lato per berne il succo fresco.
Il giovane Abate ci sorride dolcemente mentre il monaco che parla inglese gli traduce le poche cose che riusciamo a dire sopraffatti dall’emozione.
Il clima è sacro e solenne ma anche allegro e leggero, con frequenti esplosioni di risa a una battuta nostra o di uno dei monaci. Cresciuto tra i religiosi cristiani, che spesso esprimono la sacralità con atteggiamento serio e misterioso, rimango sempre colpito dai monaci buddisti Theravada. Essi riescono, pur rivestendo un ruolo così importante nella società, e costretti da regole monastiche durissime, a rimanere uomini semplici e allegri, amanti della compagnia e dell’umorismo.
Conversa con noi anche un monaco piu’ anziano, forse sui sessant’anni, che sembra conoscere l’inglese piuttosto bene. Ci scambiamo informazioni e aneddoti sui cibi dei nostri paesi. Contento della nostra curiosità del cibo birmano, l’Abate estrae da un mobiletto un barattolo di vetro e un cucchiaio di ferro, e ci invita ad assaggiare il “la-phed”, una specie di pesto alla genovese fatto con foglie di the. E’ buono e loro sono molto soddisfatti che ci piaccia.
Lentamente arrivano altri monaci, anche bambini novizi, meravigliosi nella loro piccola tunica arancione. Ci regalano sguardi e sorrisi pieni di intelligenza e dolcezza.
Parliamo della Birmania, di quanto ci piacerebbe poterla visitare, invece di dover rimanere nel recinto di sicurezza. Della valle dei templi di Pagan, trecento chilometri a nord di Rangoon. Senonchè il monaco più anziano mi dice, con gli occhi pieni di tristezza, che lui non è mai potuto andare a Pagan. Gli chiedo il perchè e lui, lentamente, diventa più serio mentre mi racconta, con determinazione, che in Birmania nessuno è libero di muoversi come vuole. Mi dice che se lui volesse andare a nord, dovrebbe chiedere un permesso speciale all’autorità di controllo dei monaci e che qualora il suo spostamento non fosse in qualche modo funzionale al regime, il permesso sarebbe certamente negato.
Stessa sorte tocca a tutti gli altri cittadini birmani che non hanno legami col regime militare.
“In Myanmar, there is no democracy”, mi dice serio, col massimo della rabbia che ad un monaco è consentito esprimere e con un tono di rassegnazione che mi spezza il cuore. Non dimenticherò mai questa frase. E non dimenticherò mai lo sguardo del monaco. La profonda intelligenza e consapevolezza espressa dai suoi occhi e dal suo semplice inglese, grazie al quale riesce a condividere con noi le sue emozioni.
Soprattutto non dimenticherò mai come mi sono sentito fortunato. Nessuna frase di circostanza sarebbe stata adatta a quel momento. Nessun “capisco”, nessun “mi rendo conto”. Come potrei mai capire? Come potrei sapere cosa significa vivere in una gabbia? Come potrei immaginarmi sotto un potere così palesemente indifferente alle libertà più elementari? Come posso partecipare al dolore di una persona che mi conferma, sì, che in Birmania ancora esistono i lavori forzati a vita per gli oppositori? Io che da piccolo mi sentivo rivoluzionario disegnando “A cerchiate” sui muri del centro di Roma, punito al massimo con qualche scapaccione? Il silenzio era l’unica risposta possibile. Un silenzio colpevole.
Vorrei fargli mille domande. Vorrei sapere tutto. Vorrei vivere il privilegio di quel momento così straordinario spremendone ogni goccia. Ma l’emozione mi sopraffà e riesco solo a mantenere un rispettoso silenzio, lasciando che le sue parole echeggino nella mia anima e ad ascoltarlo, mentre in sottofondo la voce di uno speaker tailandese commenta la partita di calcio tra Real Madrid e Manchester United che un televisore, acceso pochi minuti prima, trasmette con stridente assurdità.
Si è fatto tardi e i nostri stomaci lamentano una colazione troppo leggera consumata dodici ore prima. Decidiamo di accomiatarci dai nostri meravigliosi monaci per avventurarci alla ricerca di un po’ di cibo e di riposo.
Salutiamo l’Abate, i piccoli monaci e il monaco con gli occhiali con la promessa, sincera nel fondo del cuore, di tornare a trovarli e ci avviamo verso l’uscita in un’allegra processione.
Ammutoliti da un incontro così emozionante, continuiamo in silenzio la nostra passeggiata e, schivando i motorini, ci ritroviamo quasi sulla sommità del colle su cui poggia Kowthaung. Sulla cima si intravede una grande costruzione, sembra un altro tempio ma molto più grande e colorato. Sulla strada, bambine bellissime ci offrono incensi, candele e fiori di loto; oggetti che, solitamente, si danno in offerta al Buddha. Con piacere cediamo i pochi spiccioli necessari in cambio del sacro armamentario e, ripagati dai sorrisi delle piccole venditrici, ci avviamo verso la Grande Pagoda.
Saliamo in silenzio le scale dopo esserci tolti le scarpe, per ritrovarci su un grande terrapieno, completamente piastrellato, nel cui centro troneggia uno Stupa enorme in perfette condizioni. La visuale è ostruita ad ovest dagli alloggi dei monaci ma nelle altre direzioni è completamente libera. Si vedono i tetti della città, di colori vivaci e diversi, in stile stranamente liberty; il porto, con l’onnipresente groviglio umano e di long tail boat; il Mare Andamano che, al riparo del golfo di Khra, ricorda un placido lago; alcune isole disabitate e verdissime e infine, sul fondo, la costa della Tailandia, con le prime luci elettriche che iniziano a illuminare un giorno ormai tendente alla sera.
Ringrazio il Buddha, per avermi ancora una volta regalato grandi fortune inaspettate e per avere arricchito il mio cuore di nuovi incontri e offro timidamente alla sua immagine il loto fresco, la candela e i bastoncini d’incenso.
Electro-Burma
Sta calando velocemente la sera e, con calma, riprendiamo la nostra discesa verso il mare. Camminiamo lentamente, respirando l’umanità che ci circonda e oramai certi che, almeno per noi, a Kawtaung c’è moltissimo da scoprire.
Il molo ferve delle attività serali e c’è aria di mobilitazione. Entriamo in albergo con una fame da leoni e ci avviamo verso il “lussuoso” ristorante. Ci sediamo in un frastuono assordante: al calare della sera è stata accesa l’enorme motrice sul lato sinistro, davanti all’ingresso del ristorante, che dà elettricità all’edificio. Si riesce a comunicare solo urlando. La cosa ci diverte molto e urliamo ai due camerieri adolescenti la nostra scelta per la cena. Mangiamo del mediocre riso con gamberi e pollo e, in cuor mio, ho la conferma che non avrei dovuto dare retta ai due ragazzi in motorino per seguire invece l’istinto ed entrare in una delle bettolacce sulla strada. Ma ormai siamo qui e ci godiamo una cena urlata con il potente BRRRRR del generatore come romantico sottofondo.
Abituato alla Tailandia, dove in materia di elettronica di consumo sono molto più avanti di noi europei, quasi non noto lo sguardo pieno di curiosità dei due camerieri alla vista del mio telefono cellulare, tutt’altro che ultimo modello. Li invito ad avvicinarsi per prenderlo in mano, ma sono troppo timidi per accettare e si accontentano di osservarlo con curiosità. Poi, ripensando a me alla loro età, avvio un semplicissimo giochino di automobili da corsa al quale finalmente non resistono. Cedendo alla tentazione, accettano il telefono per farsi qualche partita, divertendosi molto.
Torniamo in camera per riposarci un po’ e, dopo una breve dormita, partiamo alla volta della “Kowthaung by night”.
Saranno le nove di sera ed è buio già da un paio d’ore. Il porto sembra più tranquillo, illuminato solo dalle luci dei caffè, dove i birmani si riposano e chiacchierano e, soprattutto, guardano pessimi film di Hollywood o di Hong Kong, messi gentilmente a diposizione dai proprietari dei locali.
In quasi tutte le costruzioni si vedono i resti della dominazione inglese. Veniamo attratti dal caffè sul molo principale: una costruzione quadrata, aperta su tre lati, con un grande orologio sul tetto, fermo forse dal giorno in cui l’ultimo suddito della corona inglese ha lasciato la città. Entriamo e ci sediamo a un tavolino, tra gli sguardi incuriositi degli avventori che però si accontentano di una semplice occhiata, ipnotizzati da un film cinese ultraviolento di poliziotti cattivi. In tailandese ordino del caffè caldo, che ci viene servito insieme a una teiera di tè cinese. Il caffè scende: è il solito solubile della Nestlè che con acqua, latte in polvere e caffè ha colonizzato l’intero sud-est asiatico. Beviamo lentamente guardandoci intorno.
La sala è grande, probabile eredità di qualche imprenditore occidentale approdato nel Siam il secolo scorso e i clienti, quasi tutti uomini e bambini, stanno seduti a sorseggiare caffè e mangiucchiare dolci dall’aria un pò stantia. La “cucina” è in un angolo, dove una precaria bombola del gas scalda tegami e teiere resi neri dall’uso. Alcuni clienti parlano tra loro a bassa voce ma la maggior parte è assorta dal film. Osservo lo schermo: lotte di kung-fu, donne bellissime e misteriose, macchine di lusso e poliziotti spietati. Poi osservo le persone intorno a noi, i cui sguardi rapiti tradiscono l’incompatibilità tra un passato profondamente buddista e sempre uguale a se stesso e l’avanzata inesorabile del materialismo, e in cuor mio spero ardentemente che, almeno qui, lo spirito riesca a sopravvivere.
Cerco di chiacchierare in tailandese con un ragazzo seduto vicino a noi dall’aria molto intelligente ma tra noi due non so chi lo parli peggio e ci salutiamo rassegnati, con lo sguardo che tradisce una possibile amicizia.
Finito il caffè, continuiamo a gironzolare finchè capitiamo davanti alla porta di un buffo noleggiatore di film, che propone videocassette e VCD (un formato di video su CD molto popolare in Asia), naturalmente contraffatti.
Entriamo a curiosare e, improvvisamente, mi ricordo che il lettore di CD comprato a Bangkok per il viaggio è in grado di leggere anche i video e che nella nostra stanza d’albergo c’è un piccolo televisore. Più che il desiderio di vedere un film, è l’idea di affittarne uno in questo posto a stimolarmi. Entriamo e il venditore sembra desideroso di servirci. In tailandese stentato riesco a capire che se gli lascio 200 baht, il giorno seguente quando gli riporteremo il film ce ne restituirà 180. Sono però tutti film tailandesi o cinesi, con l’eccezione di… Terminator 2! Prendiamo il VCD con divertimento, ma certo non impazienti di guardarlo, e continuiamo la nostra esplorazione.
Arriviamo in una piazza che sembra il luogo d’incontro del villaggio. Ci sono dei tavolini bassi, con sgabelli più bassi ancora, a una ventina di centimetri da terra. Un chiosco serve bibite e tè caldo e diverse famiglie di birmani sono sedute ai tavolini. Ci sediamo anche noi, salutati con sorrisi e i soliti “hello” praticamente dall’intera piazza. Il clima è molto allegro, non ci sono televisioni accese e finalmente ci godiamo un pò di convivenza umana senza l’intrusione violenta dell’immaginario occidentale.
Probabilmente, grazie alla vicinanza con la Tailandia, Kowthaung gode di una certa agiatezza e i segni della dittatura e della povertà estrema sono meno evidenti. Veniamo avvicinati da uno dei molti “scugnizzi” che popolano la città. Sembra un bambino senza casa ma conosciuto e benvoluto da tutti. Riesce solo a dirci come si chiama: Kochi. E’ così incuriosito da noi che non resiste e fa di tutto per essere invitato a sedersi. Ci piace molto la sua educazione innata, istintiva, e lo accogliamo con gioia, offrendogli un dolcetto stantio che osservava con gran desiderio. Non parliamo ma lui siede, alternativamente, da solo, in braccio a me e in braccio ad Ema. Ci scambiamo affetto e vicinanza, pur senza capirci, grazie al solo legame dell’umanità condivisa. Dopo l’ennesimo caffè, continuiamo il nostro giro di osservazione e, insieme a Kochi, ci avventuriamo verso il mare salutando i vicini di tavolo.
Passiamo davanti a una specie di bar, decorato da luci che in Occidente usiamo per l’albero di Natale e ci rendiamo conto che si tratta di un karaoke sconquassato. Il proprietario, molto bello e dall’aria fiera nel suo longy sgargiante, con dei grandi baffi, ci saluta e ci invita a entrare. Senza un attimo di esitazione approfittiamo dell’invito. Il proprietario ci propone dei menu di canzoni, indicandoci le poche in inglese disponibili. Accende due casse audio gigantesche, sovradimensionate per il posto, grande grossomodo come un garage. Appronta il macchinario e ci passa due microfoni. Ci esibiamo in una sequenza di canzoni vintage, accompagnati dal proprietario e da Kochi. In sequenza cantiamo successi dei Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra e altri di tempi andati. Durante la nostra esibizione, lo spazio davanti al bar è gremito di persone. Fanno a gara per vedere i due buffi occidentali che cantano nel loro karaoke, mentre il gestore si lascia fotografare in pose molto “maschie”, fiero e sicuro di sé.
Esausti dalla performance ritorniamo verso l’albergo accomiatandoci dai nostri fan, e accompagnati da Kochi riprendiamo la discesa verso il molo.
Il suo sguardo ci riempie di sgomento. E’ un bambino intelligentissimo e di un’educazione di altri tempi. Con lineamenti perfetti e una bellezza esteriore e interiore che poco ha a che vedere con la sua condizione di orfano. Lo conoscono tutti e lo trattano con gentilezza estrema. Forse, in una tale situazione, non avere i genitori consente di essere accuditi da un’intero villaggio e Kochi non fa pena.
Ci salutiamo facendogli capire che il giorno dopo, in mattinata, dovremo partire e, non senza tristezza, ci accomiatiamo dopo avergli comprato cibo, giocattoli e qualsiasi cosa pensiamo possa fargli piacere. Regali che lui accetta con riluttanza e contegno ma anche con gratitudine.
Siamo esausti ma con tutto il caffè bevuto sarà difficle addormentarsi quindi, una volta tornati in camera, armeggiamo non poco per riuscire a collegare il lettore CD al vecchio televisore e dopo una lunga doccia ci mettiamo a letto. Partono i titoli di testa di Terminator 2, sui quali ci addormentiamo entrambi, regalandoci alcune ore di sonno con sottofondo di spari, esplosioni e grida.
Arrivederci Myanmar
Ci svegliamo all’alba con il porto che ha ripreso la sua lentissima ma frenetica attività. I rumori delle long tail boat non si sposano con una lunga mattina di sonno. Interrogo il mio inconscio alla ricerca di sogni e vi trovo Buddha meccanici che difendono la terra dall’invasione di malefici robot corporativi, e monaci guerrieri che grazie a mantra spaziali respingono orde di colonizzatori psichici armati di beni di consumo e specchi riflettenti. Dormire con l’audio di Terminator 2 dopo una giornata così profonda ha generato un’attività inconscia preoccupante, e posso lasciare svanire il sogno senza rimpianti.
Ema sta male: il riso coi gamberi non doveva essere troppo sano. Rimane a letto mentre io decido di esplorare il mercato che affaccia proprio sul molo, e di procedere alla ricerca di una barca per il ritorno in Tailandia.
 Recupero il VCD da restitutire e mi avventuro da solo per le strade di Victoria Point. A gesti riesco a farmi fare un succo di canna da zucchero da un ragazzo completamente sdentato per l’uso di noce di betel. Le tante chiazze rosse che si vedono per le strade non sono pozze di sangue residuo di macellazioni o sacrifici efferati, bensì abbondanti sputi dei masticatori di betel, un prodotto dagli effetti lievemente euforici, con ricadute terrificanti sulla dentatura. Il ragazzo è molto simpatico. Socializziamo un po’, a gesti, mentre sorseggio il succo. Usa un macchinario che potrebbe avere trecento anni. Una grande leva fa girare dei meccanismi in ghisa che spremono la canna da zucchero costringendola a liberare il succo saporito. Mi offre una noce di betel, ma la dolcezza del suo sorriso non riesce ad offuscare lo stato dei suoi denti e con gentilezza rifiuto il dono.
Recupero il VCD da restitutire e mi avventuro da solo per le strade di Victoria Point. A gesti riesco a farmi fare un succo di canna da zucchero da un ragazzo completamente sdentato per l’uso di noce di betel. Le tante chiazze rosse che si vedono per le strade non sono pozze di sangue residuo di macellazioni o sacrifici efferati, bensì abbondanti sputi dei masticatori di betel, un prodotto dagli effetti lievemente euforici, con ricadute terrificanti sulla dentatura. Il ragazzo è molto simpatico. Socializziamo un po’, a gesti, mentre sorseggio il succo. Usa un macchinario che potrebbe avere trecento anni. Una grande leva fa girare dei meccanismi in ghisa che spremono la canna da zucchero costringendola a liberare il succo saporito. Mi offre una noce di betel, ma la dolcezza del suo sorriso non riesce ad offuscare lo stato dei suoi denti e con gentilezza rifiuto il dono.
Mi avventuro in un mercato coperto per comprare delle banane da una vecchia sdentata che fuma una sigaretta rudimentale dietro l’altra. Evidentemente nessuno è mai stato interessato a questi posti. La mia presenza non si limita ad incuriosire: i coloratissimi birmani fanno a gomitate chiedendomi di fotografarli nelle pose più assurde, senza mai perdere la peculiare fierezza. La vecchietta naturalmente si fa immortalare mentre accende l’ennesima sigaretta con il mozzicone della precedente. Sono felici di rivedersi nello schermo della macchina fotografica digitale. Facciamo amicizia anche senza capirci. Esco dal mercato dopo aver assaggiato praticamente tutta la maercanzia che i poveri venditori sono felici di condividere con me senza chiedere nulla in cambio.
Vado a restituire il film e incontro nuovamente Kochi, pulito e con le decorazione bianche sul viso fatte di fresco. E’ veramente molto bello e il contegno col quale mi abbraccia e mi saluta è commovente. Al mattino, le decorazioni sul viso sono fresche e sembra davvero di essere in un sogno, dove spiriti buoni dal viso decorato, con la sola forza della verità e della compassione, respingono orde di robot malefici portatori di consumo e solitudine.
Sul molo mi accordo con un pescatore molto serio e dignitoso per riportarci con la sua long tail in Tailandia. Il sole splende e non c’è pericolo di pioggia o tempesta come all’andata quindi una barchetta scoperta farà al caso nostro. Torno in albergo ed Ema si sente meglio. Rifatti i bagagli scendiamo nella hall, salutando i bellissimi camerieri e le ragazze alla reception che ci restituiscono i passaporti in perfette condizioni. Andiamo verso il molo in silenzio. Ognuno perso nelle sue considerazioni e interiorizando le ultime ventiquattro ore. Il pescatore ci aspetta puntualissimo e raggiungiamo la sua barca dovendone attraversare almeno una decina. Mentre passiamo i bagagli di barca in barca, dentro di me saluto Kowteung e la bellissima Birmania, con la promessa, in futuro mantenuta, di un ritorno più approfondito. Arrivederci Kowteung, arrivederci Kochi, arrivederci nostri monaci. Tornerò presto a trovarvi.

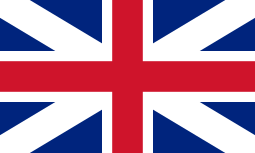 English
English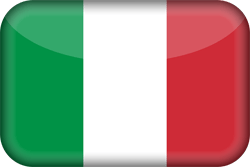 Italian
Italian