Henri Le Saux: da Rennes all’Himalaya sulle ali di una mistica transculturale.

(Taittirìya Upanishad II,9)
(Katha Upanishad VI,12)
La mistica dell’advaita è una mistica della conoscenza e una mistica dell’essere, che la pura consapevolezza persegue; è la realizzazione di sé o del vero io, che per Abhishiktananda deve precedere ogni esperienza di Dio. Secondo Ramana Maharshi il cammino verso di essa consiste nell’indagine su di sé, nella questione interiore «Chi sono io?», connessa con una tacita meditazione. Ma non ci si può abbandonare ad alcuna illusione: questo cammino esige uno spogliamento totale, una nudità interiore e spesso anche esteriore, che non permette più all’uomo di sistemarsi in qualche modo.
L’esperienza dell’advaita è, nella storia dell’umanità, una testimonianza unica dell’assolutezza dell’essere, del mistero di Dio, al quale non ci si può sottrarre. È un fuoco divorante, se appena si osa accostarsi ad esso14.
L’esperienza dell’advaita conduce, per Abhishiktananda, a una purificazione e un approfondimento radicali della propria esperienza cristiana.
3. TRINITÀ
Per Abhishiktananda, al centro dell’esperienza cristiana c’è il mistero trinitario.
Nella Trinità egli trova non solo l’esperienza di Dio, ma anche l’interiore esperienza di sé, nonché il rapporto con gli altri e il mondo.
Punto di partenza è l’esperienza di Gesù stesso, la sua prima illuminazione al battesimo nel Giordano, dove la sua divina figliolanza viene rivelata, nonché la luminosa conferma di questa figliolanza al Tabor.
Credere in Cristo significa credere nel mistero, della propria figliolanza divina, nella sua origine dal Padre. E’ la dedizione totale al mistero interiore.
Il mantra cristiano – nel senso della parola di rivelazione che toccava nel più profondo Abhishiktananda e poteva mandarlo in estasi, era il versetto del Salmo che costituisce l’introito della messa natalizia: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato»15. In esso egli trovava il suo vero essere, nel seno della Trinità. La «risposta» è la preghiera di Gesù: «Abbà, Padre». Non senza motivo, nel suo libretto sulla preghiera ha raccomandato ai cristiani questa espressione come mantra 16, poiché in essa l’orante partecipa alla vita trinitaria: come figlio invoca il Padre nello Spirito.
Nel suo libro Sapienza indù e mistica cristiana, Henri Le Saux descrive l’esperienza trinitaria, che cerca di mettere in sintonia con l’esperienza dell’advaita. Nell’intuizione del saccidànanda. vale a dire nella caratterizzazione dell’assoluto (brahman) come essere (sat), come coscienza (cit) e come beatitudine (ànanda) egli trova la prefigurazione della Trinità.
Se l’esperienza cristiana della Trinità ha aperto all’uomo nuovi sguardi nel significato dell’intuizione del saccidànanda, è vero anche che i concetti di sat, cit e ànanda dal canto loro sono di grande aiuto per il cristiano nella sua meditazione del mistero centrale della sua fede … L’esperienza del saccidãnanda trasporta l’anima al di là di ogni conoscenza intellettuale, fino al suo centro intimo, all’origine del suo essere. Solo là essa è in grado di udire la parola che, all’interno dell’Unità indivisa e dell’advaita del saccidãnanda, rivela il mistero delle tre Persone divine: in sat il Padre, il principio assoluto e la fonte dell’essere; in cit il Figlio, la parola divina, l’autoconoscenza del Padre; In ãnanda lo Spirito dell’amore, la pienezza e la beatitudine senza fine 17.
Che la Trinità abbia costituito fino alla fine il punto focale della sua esperienza interiore risulta dall’ultimo appunto del suo diario spirituale, dopo la grande esperienza di illuminazione:
C’è in me la fonte e la non fonte, ed esse sono non due. Il mistero trinitario è la rivelazione della mia propria profondità che noi chiamiamo umano-divina, vissuta in un grado intenso…
4. L’INCONTRO DI DUE ESPERIENZE NELLA «CAVITÀ DEL CUORE»
Swami Abhishìktananda era convinto che diverse tradizioni devono incontrarsi nella loro forma più pura ed elevata, senza volere con questo ribadire l’opinione indiana secondo la quale «tutte le religioni a livello di esperienza mistica sono una cosa sola», poiché quest’affermazione presuppone un a priori intellettuale che, se mai, solo il mistico stesso può acquisire. Piuttosto, egli partiva dal presupposto che tutte le manifestazioni esterne delle religioni – incluso il cristianesimo – sono fortemente condizionate da fattori storici e culturali, che alla luce di un’altra cultura possono essere fraintesi. Alla fin fine, ogni espressione dell’esperienza religiosa costituisce già un suo tradimento, poiché è essenzialmente «nome e forma» (nãma-rũpa), che nascondono l’essere più di quanto lo rivelino. Dio non è né un concetto né una proiezione. Egli piuttosto è al di là di ogni «nome e forma», Per cui non si tratta tanto di un confronto tra diversi sistemi concettuali ma dell’incontro vivo di esperienze, «nella cavità del cuore», anche se non c’è dubbio che tale «dialogo interiore» non è privo di pericoli e conflitti.
Per quanto fosse sconvolgente per Abhishiktananda l’esperienza mistica del veggente indiano, essa suscitava in lui anche profondi timori; soprattutto la paura di diventare infedele a Cristo e alla chiesa. Così la gioia e la pienezza di cui fece esperienza continua erano messe in questione dal dubbio. Nel 1953 scrive nel suo Diario:
Ho già degustato troppo dell’advaita, per ritrovare la pace “gregoriana” di un monaco cristiano. Avevo già degustato troppo di questa pace “gregoriana” per non sentirmi inquieto in questa mia esperienza dell’advaita (27.9.1953).
Cercare la pace in un aldilà dell’io, in un io interiore, sovraessenziale? Ma come cristiano non ho alcun diritto a questa pace….Proprio qui sta il timore. poiché come può permettermi l’abisso dell’advaita, che mi attira, di riposarmi in sicurezza nella pace cristiana? (26.12.1954).
Questo conflitto di coscienza testimonia sia un problema autentico, sia l’assoluta onestà con la quale il monaco cristiano affrontò la mistica indiana. Gli era chiaro che solo una visione superiore avrebbe potuto portare la soluzione, non una fuga in una direzione o nell’altra. Questo superamento, a un più alto livello di coscienza, gli fu concesso più tardi. Nella luce di esso può dire:
Tutti i nomi e tutte le forme, induiste o cristiane, sono soltanto candele, che l’uomo accende nel chiaro meriggio, quando il sole si trova allo zenit. Scoprire quest’uomo interiore (purusha) dal fuoco: chi gli si avvicina brucia (10.5.1972).
Come si risolve per lui il problema dell’esperienza cristiana e induista? Nel suo Diario (24.7.1971) scrive:
Lo voglia o meno, io sono legato nel più profondo a Gesù Cristo e quindi con la comunità della chiesa. In lui mi si è manifestato il mistero dal mio risveglio a me stesso e al mondo. Nella sua immagine, nel suo simbolo conosco Dio, me stesso e il mondo degli uomini. Al mio risveglio a nuove profondità di me stesso, del mio io (ãtman), qui (in India), questo simbolo si è meravigliosamente dilatato. Già la teologia cristiana mi aveva mostrato l’eternità del mistero di Gesù: in sinu Patris. Più tardi l’India mi ha manifestato il tutto cosmico di questo mistero, questa rivelazione totale, in cui s’inserisce la rivelazione giudaica. Io riconosco questo mistero, che ho sempre adorato nel simbolo di Cristo, anche nei miti di Nãrãyarya, Prajãpati, Shiva, Purusha, Krishna, Rãma e altri. Ma per me Gesù è il mio sadguru. La gente vorrebbe che insegnassi una gnosi indù mirabile e scintillante; io ho un solo messaggio, il messaggio dell’Assoluto. E’ questo messaggio che Gesù e tutti i veggenti hanno vissuto: l’incontro con la morte, con Dio, la nudità totale di questo incontro… Dio è questo assoluto, questa morte. Nessuno può vederlo e vivere, poiché questa visione strappa all’uomo tutti i suoi vestiti…
Per lui quindi advaita e Trinità non sono più contrapposti, ma le due esperienze si integrano e convivono:
L’esperienza cristiana è in realtà l’esperienza dell’advaita, come viene vissuta nella comunità umana. E questa è la Trinità. Ma l’uomo ha tentato di liberarsi di questo fuoco, divinizzando formule e istituzioni (3.8.1972).
Alla luce della penetrazione upanishadica nella pienezza della realtà divina, Abhishiktananda considera in maniera nuova il mistero dello Spirito, che interpreta come l’advaita del Padre e del Figlio.
5. TAPPE DEL CAMMINO
È giusto chiedersi come si può fare questa esperienza. L’attuale interesse per la spiritualità e la meditazione è per lo più caratterizzato da un entusiasmo esagerato per i metodi, quasi che ci fosse la garanzia di raggiungere lo scopo. Come discepolo di Ramana Maharshi, Abhishiktananda non può che mettere in questione tutti i metodi, poiché, come dicono le Upanishad, «non si arriva all’Increato con l’aiuto della realtà creata»18;che per altro non significa che non ci sia alcuna strada che porta a questa mèta.
La prima esigenza del cammino è l’interiorizzazione, l’immergersi nel proprio fondo19, nella «cavità del cuore», per dirla con le parole delle Upanishad.
Tutto, ogni preghiera, ogni adorazione, ogni gesto… consiste per me nell’entrare nel fondo… Penetrando dall’esterno verso l’interno, lo porto alla vita, lo faccio risorgere, lo conduco a Dio20.
Un mezzo concreto, collaudato da ambedue le tradizioni, è la preghiera del nome (nãmajapa), che raccoglie in Dio lo spirito distratto e lo conduce verso l’interno. Interiorizzazione significa un perdersi In sé:
La discesa nella profondità, dove non si vede più nulla, neanche se stesso… Poiché si deve discendere nel fondo dell’abisso, per risvegliarsi sull’altra sponda…21
Mezzi sia esteriori che interiori sono il silenzio e lo spogliamento: non un’ascesi artificiosa, ma la liberazione da tutto il superfluo, che cela il vero essere dell’uomo. La meditazione silenziosa è senz’altro il mezzo più adatto per permettere allo Spirito di Dio di lavorare.
Immergersi nel momento presente, ridurre al silenzio l’immaginazione, il pensiero, persino i pensieri sul presente. Solo allora il presente risplenderà.
I diversi metodi dello yoga, come il controllo del respiro, la posizione del corpo, la concentrazione, ecc., mirano in ultima analisi a questo scopo, ed egli li raccomanda soltanto in funzione di questo silenzio dello spirito, che presuppone l’acquietamento del corpo. Soltanto il silenzio è adeguato alla realtà di Dio e può costituire la sua lode unica. E tuttavia non lo si può assolutizzare, come non si può assolutizzare alcun altro metodo, poiché «anche il silenzio è un segno; e l’Unico è al di là del segno, è nella parola come nel silenzio, né dentro né fuori, da nessuna parte…» (Diario, 18.3.1970).
Benché il cammino mistico trascenda tutti i segni, c’è tuttavia per i cristiani un ultimo segno, che resta valido finché non si entra nella realtà piena: il segno-dell’eucaristia. Abhishiktananda visse nel più profondo la dimensione mistica dell’eucaristia, in cui offriva il sacrificio dei sacerdoti e dei fedeli di tutte le religioni. Il 12.6.1952 scrive:
Quando mangio l’eucaristia, creo i mondi. Quando mangio l’eucaristia, produco il Figlio del Padre e sono all’origine della processione dello Spirito, che compie la divinità. Poiché il mangiare l’eucaristia è per me il mezzo del tutto adatto alla mia natura per rispondere all’offerta d’amore del Padre per accettare di essere.. affinché la pienezza trinitaria sgorghi nel presente eterno del vuoto divino (sũnyatã).
L’interiorità s’unisce quindi all’ampiezza cosmica, l’umanità al mistero divino. In ultima analisi tutti i metodi e i mezzi, si tratti della preghiera, dell’esercizio dell’attenzione (sati nel buddismo), del ritmo del respiro, della meditazione silenziosa, dell’ascesi, servono a vincere l’io limitato con tutte le sue affezioni, i suoi desideri, i suoi pensieri e le Sue concezioni, per scoprire il vero io (ãtman) e permanere in questa condizione di coscienza, che è «innata» nell’uomo e naturale (sahaja della tradizione indiana). Il risultato non può essere una religione artificiosa, ma la pura spontaneità, la libertà interiore, che fluisce dalla convergenza con l’essenza più profonda del proprio io (svarũpa). In termini cristiani si tratta di una pura apertura all’azione dello Spirito:
La libertà cristiana consiste nel fatto che non c’è più nulla nell’uomo che pregiudichi in noi la spinta interiore dello Spirito (Diario. 15.3.1967).
Colui che incarna questa condizione di libertà interiore di disponibilità allo Spirito, di totale attenzione allo «sguardo interiore, e la vive senza compromessi, è il sannyãsi indiano, col quale Abhishiktananda s’era pienamente identificato. Il suo ultimo scritto è dedicato a questo ideale del sannyãsa, del monachesimo indiano. in cui egli trovò anche la realizzazione radicale delle esigenze del Vangelo. Più che un cercatore, ii sannyãsi è, nello spogliamento della sua vita, un segno della trascendenza di Dio. La profondità mistica del sannyãsa risulta chiara dall’inno che Swami Abhishiktananda consegnò al suo discepolo, all’atto dì iniziarlo, rifacendosi alle Upanìshad:
Va’, figlio mio, nella libertà dello Spirito,
attraverso gli spazi sconfinati del cuore.
Va’ alla fonte, va’ al Padre,
va’ all’ingenerato, tu che sei ingenerato.
«Al mondo del brahman, che hai trovato,
da cui nessuno fa ritorno».
In questo mondo, da questo mondo
«guardando l’Invisibile»,
cammina nel nascondimento, sconosciuto,
pazzo della pazzia del sapiente,
libero nella libertà dello Spirito,
felice nella gioia essenziale.
Stabile nel mistero non duplice,
libero da ogni sentimento di alterità,
il cuore pieno dell’esperienza dell’io,
perfettamente risvegliato per sempre.
6. IL RISVEGLIO ALL’ESSERE
Lo scopo del cammino, spesso faticoso ma non meno gioioso, consiste in ciò che Abhishiktananda nel linguaggio del buddismo chiama il «risveglio», l’illuminazione. Questa espressione è adeguata perché – come sottolinea di continuo l’advaita – non si tratta del raggiungimento di una nuova condizione o di nuove conoscenze. Ma del risveglio «dalla irrealtà alla realtà».
Lo Jñani(saggio) non realizza né compie alcunché di nuovo; vede semplicemente la realtà in tutto il suo splendore. Egli penetra fino all’essenza delle cose e vi scopre Jahvé, Brahman, Colui che è. (Diario, 12.11.1966).
Il risveglio «sull’altra sponda» è necessariamente preceduto dalla morte, non fisica, ma mistica, la «grande morte», in cui l’uomo viene spogliato di tutto. La realtà della risurrezione è presente già in questa vita:
…e si risvegliò all’essere il mattino di pasqua, nel seno del Padre, nella gloria, che aveva sin dall’inizio del mondo (Gv 17’s); «Mi sveglio e sono con te…» (Sal 139,5).
Abhishiktananda poté godere personalmente di questa esperienza, in un primo tempo con intuizioni momentanee, negli ultimi anni di vita nella pienezza della luce. Per questo può parlare con certezza di questa condizione, che in realtà è ineffabile:
Dio è troppo luce, perché si possa resistere di fronte a lui. Si scompare, si viene assorbiti dalla fonte, che non è altro che luce. Pregare? Adorare? Essere. So che sono… (3.8.1972).
Ho l’impressione che o non ho più nulla a che fare qui, oppure sono chiamato a testimoniare la luce da solo, io soltanto (10.6.1972).
Chi ha raggiunto questo stato, alla fin fine ha «eliminato la distinzione tra chi cerca e chi è cercato». Solo ora vive veramente nel puro presente, liberato dal peso del passato e dalle preoccupazioni per il futuro.
Ma questa degustazione del momento presente non significa una. forma superiore di egoismo. AI contrario, il contemplativo presta il più grande servizio al mondo e ai propri simili:
Si va nella solitudine per espletare un servizio, una specie di contrappeso alla dispersione umana. Testimoni dell’Assoluto, testimoni del fatto che la res, la realtà, è al di là del segno. (…)
Essere è la preghiera vista da Dio. Il risvegliarsi all’essere è l’opera più mirabile che l’uomo ha da compiere nel mondo e per il mondo. Egli allora è veramente uno yogi, che collega ed è collegato, che raccoglie il mondo disperso nell’essere, nell’unità (Diario,26.11.1956).
Lo yogi per tutte le creature ha soltanto ormai lo sguardo di Dio. E allo stesso modo egli ha per Dio soltanto più lo sguardo di Dio su se stesso (Diario, 5.4.1952).
Nella sua illuminazione, in concomitanza con l’infarto subito Abhishiktananda esperimenta una condizione che supera ogni dualità, come scrive in una lettera:
Veramente una porta si aprì in cielo. mentre giacevo sul ciglio della strada. Ma un Cielo che non è il contrario della terra, qualcosa che è vita o morte. ma semplicemente «essere», «risveglio» … al di là di tutti i miti e i simboli (Diario, 10.9.1973).
Era come una ripetizione della cosiddetta ascensione al cielo del profeta Elia, una trasfigurazione che il veggente della Chãndogya Upanishad aveva già esperimentato:
Il trasfigurato si solleva da questo corpo,
raggiunge la luce altissima
e appare nella sua forma propria.
Questo è l’uomo più elevato (purusha),
l’io, l’immortale, senza timore (8,3,4).
III. SIGNIFICATO
Abhishiktananda amava citare il proverbio indiano secondo cui «solo il saggio può riconoscere il saggio». Il significato di un mistico non può essere misurato con criteri esterni, poiché «egli opera all’interno». All’esterno spesso si vedono soltanto effetti secondari che risplendono a partire dall’esperienza fondamentale come i cerchi che si formano nell’acqua attorno al punto in cui il sasso è caduto nel profondo.
Come scrive R. Panikkar, l’aspetto caratteristico della testimonianza di Abhishiktananda non consiste semplicemente nel fatto che egli ha vissuto l’esperienza dell’advaita, un’esperienza che si ripete continuamente nel corso della tradizione spirituale dell’India. L’aspetto caratteristico di Abhishiktananda è costituito piuttosto dal fatto che questa esperienza si è verificata in un’anima cristiana, che in tal modo ha unito in sé i due mondi dell’Occidente e dell’Oriente. La sua doppia esperienza ha così un valore paradigmatico per l’irrinunciabile incontro odierno delle religioni, sia sul piano del dialogo sia su quello della spiritualità vissuta. Nell’ambito del dialogo, Abhishiktananda ha mostrato che ogni dibattito puramente intellettuale, ogni confronto soltanto dottrinale, non solo resta insoddisfacente, ma passa a fianco della realtà religiosa, che dev’essere fondata sempre nell’esperienza, il cristiano direbbe nella fede. Non si tratta di soluzioni teoriche, né di un giudizio unilaterale, da esprimere sull’«altro». Solo chi è disposto a partecipare dall’interno alle esperienze dell’altro, si mette in grado di comprenderne la prospettiva. Solo questa apertura reciproca può condurre a una comprensione più profonda e contribuire così, infine, ad un superamento della crisi spirituale del nostro tempo.
Per quanto riguarda l’esperienza religiosa in quanto tale, Abhishiktananda era consapevole del fatto che né una imitazione pedissequa della spiritualità tradizionale, né un adattamento superficiale possono corrispondere al profondo bisogno spirituale dell’uomo odierno.
In questo senso la ricerca da parte di giovani della sapienza orientale, nella misura in cui è autentica, si pone in una nuova luce. Quali che siano le loro motivazioni, essa è comunque un segno della necessità di approfondimento e di semplificazione, che l’odierno cristianesimo occidentale a quanto pare non è in grado di dare. Abhishiktananda mostra che è errato rinnegare le proprie radici cristiane nella sequela di guru orientali, come lo è per cristiani indiani sopprimere i propri profondi archetipi induistici. Così, il suo significato per il cristianesimo sta in una liberazione del nucleo dell’esperienza cristiana dalle strettoie di strutture occidentali e, al contempo, in un «approfondimento del mistero cristiano» attraverso l’accentuazione della dimensione contemplativa come «contrappeso».
È venuta l’ora dei contemplativi. Ma come devono essere vivi alla presenza del mondo, dal profondo del loro silenzio! Non una fuga dalla realtà, ma un penetrare nel cuore delle cose … (Diario, 20.10.1968).
IV. EFFETTI
È troppo presto parlare di effetti operati da una persona nella storia dieci anni dopo la sua morte. È possibile tuttavia menzionare gli ambiti entro i quali la vita e l’opera di Henri Le Saux hanno incominciato a produrre effetti. Il suo desiderio di contribuire al rinnovamento della chiesa indiana è in parte diventato realtà, poiché il suo influsso sull’indianizzazione della liturgia, sulla spiritualità degli ashram cristiani e in genere sulla riflessione circa le proprie radici è crescente. Certo, tutto questo non sempre accade a quella profondità che egli auspicava, per cui, ad esempio, l’utilizzazione di simboli, gesti e testi indiani nella liturgia spesso si risolve più in un adattamento esterno, invece di fluire spontaneamente dalla fonte, com’era nel suo caso. Tuttavia, egli ha dato ai cristiani indiani la consapevolezza della loro ricca eredità culturale e spirituale, che la chiesa deve integrare nella vita, perché anch’essi a loro volta possano dare un contributo a tutto il cristianesimo, così come, nel corso della storia, elementi filosofici e spirituali greci, latini, germanici e di molte altre culture,hanno arricchito la storia cristiana.
Ci si può chiedere anche quale sia stato l’effetto della sua vita sull’ambiente indù in cui è vissuto. Anche se esternamente poco visibile, l’effetto più grande resta il fatto che ,egli, da indù che spiritualmente sono in posizioni molto elevate, viene riconosciuto come un vero sannyãsi, e persino come un «realizzato», anche se non ha mai rinnegato il proprio legame con Cristo, il suo vero guru.
In Europa, dove divenne noto grazie ai suoi libri e ai suoi contatti personali: sembra che l’influsso di questo monaco cristiano-indù sia tuttora in crescita. Per molte persone in ricerca, che seguono metodi della meditazione orientale, è diventato un simbolo della possibilità di integrare la sapienza indiana con la mistica cristiana, senza cadere nel settarismo o nel sincretismo. Contemplativi cristiani trovano in lui un modello per il rinnovamento della vita contemplativa e anche eremitica.
Per quanto riguarda l’efficacia esercitata dalla vita e dal pensiero di Henri Le Saux sulla teologia, specialmente in relazione al superamento teologico del pluralismo religioso, siamo appena agli inizi. Così si dica degli stimoli alla speculazione teologica (soprattutto sulla Trinità e la cristologia) che possono venire dal «materiale esplosivo» della sua esperienza. Ma la teologia dovrà in qualche modo prendere atto della sua duplice esperienza, se vuole iniziare davvero a prendere sul serio l’esperienza spirituale delle altre religioni.
- Lettera del 18.1947, citata in Les yeux de lumière. Écrits spirituels, a cura di A GOZIER -J. LEMARIÉ, Paris 1979, p. 10.
- J. MONCHANIN, Mystique de l’Inde, Mystère chrétien, Paris 1974, p. V.
- J Sannyiisi, asceta. monaco itinerante della tradizione indiana; Swaimi, Signore, è il titolo del monaco; Sannyãsa, è la condizione di vita monastica, che esige la rigorosa rinuncia ad ogni possesso.
- Ermotes du Succidãnanda, con J. Monchanin, Paris 1956.
- Imitation à la spiritualité des Upanishads, «Vers l’Autre Rive», Sisteron 1979, tr. Ted.: Der Weg zum Anderen Ufer. Die Spiritualität der Upanishaden. Düsseldorf 1980, p. 12 (a questa edizione faremo riferimento).
- Adavaita, mistica della non-dualità.
- Cf. Gñãnãnanda. Un maître spiritual du pays tamoul, Sisteron 1970.
- Saccidãnanda : A Christian Approach to Advaitic Experience, Delhi 1974, p. 64.
- Lettera del 4.2.72, citata in Intériorité et révélation. Essais théologiques, Sisteron 1982, p. 20.
- Diario, 30.4.73.
- Diario, 26.11.56.
- Lettera del 9.2.1967.
- Imitation à la spiritualité des Upanishads, pp. 129-130 (ed. ted.)
- Saggesse hindouse. Mystique chrétienne. Du Vedãnta à la Trinité, Paris 1956, ed. ted. Indische Weisheit – christliche Mystik, Luzern 1968, p. 100.
- Sal. 2.-7.
- Cf. Eveil à soi – Eveil à Dieu. Essai sur la prière, Paris, 1971.
- Ivi. p. 178.
- Mundaka Upanishad, 1.2.12.
- Sulla vicinanza a Meister Eckhart, cf. Davy, Henri Le Saux….
- Diario, 12.4.53, citato da Davy, Henri Le Saux…p. 120.
- Initiation à la spiritulité des Upanishads, pp. 30-31 (ed. red.).

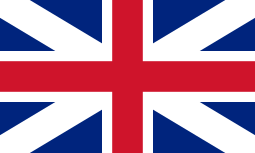 English
English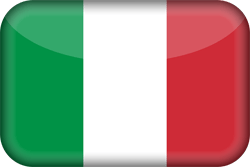 Italian
Italian