Frammenti di memorie indiane
 Nel corso di un ripulisti domestico e nel momento in cui stanno iniziando a prendere forma nuovi progetti editoriali, ho ritrovato alcune note, scritte in India alcuni anni fa, quando vi vivevo la maggiorparte del tempo.
Nel corso di un ripulisti domestico e nel momento in cui stanno iniziando a prendere forma nuovi progetti editoriali, ho ritrovato alcune note, scritte in India alcuni anni fa, quando vi vivevo la maggiorparte del tempo.
Notte amara di Natale (Varanasi, 2007)
Sobala (la mia compagna indiana, protagonista del racconto Ali di farfalla, pubblicato sul testo Barboni sì ma in casa propria) era nervosa la sera della vigilia di Natale.
Stavo allungando le mani a prendermi i miei spazi, nella casa del dharma (una casa nel centro storico di Varanasi in cui avevo iniziato a vivere ospite di una famiglia di “quasi bramini”). Ero anche molto propositivo, forse troppo, nella casa del karma (un appartamentino dove Sobala insegnava lo yoga e dove io avevo vissuto per alcuni mesi, poco distante dalla casa del dharma).
Pensavo a qualche ristrutturazione da fare, per avere un centro di yoga e di ricerca più professionale. Continuavo ad accarezzare il sogno di una bella biblioteca e di muri ben imbiancati e la cucina non proprio tra i piedi, con pentolame e piatti e bicchieri di metallo che contribuivano a creare un’atmosfera da semibaraccone.
In tutto questo, non tenevo conto dei suoi tempi, dei tempi di Varanasi e dell’India.
Sobala era dunque nervosa in quei giorni, in cui almeno non si sentiva il fiato della volgare mercificazione del Natale sul collo.
Il Natale viene in qualche modo celebrato in India ma non è certo una festa nazionale. La comunità cristiana, nel nord del paese, è piuttosto sparuta e non si fa sentire molto in occasione delle sue feste consacrate.
Il 24 Dicembre 2007, ricordo, è stato uno di quei giorni completamente out of control, in cui è andato tutto per proprio conto.
Tra le altre cose mi attardai per un’intervista ad una donna italiana che vive da molto tempo in India.
Di ritorno nella casa del karma, trovo Sobala chiudere la porta con le solite due mandate di grande chiave.
C’è anche sua figlia, la “bambina di nome Gesù” (il suo nome è la traduzione, in hindi, dell’ebraico Joshua e dell’arabo Issa).
Guardo Sobala con aria interrogativa. Lei mi dice che mi avevano aspettato sino a quel momento e che è sopraggiunta, in entrambe, una certa stanchezza.
Io trasecolo: “ma come, non ceniamo insieme per Natale?”.
Lei mi guarda con aria apatica: “cosa mangiamo?”.
“Entriamo in casa, ci rilassiamo un attimo e ci pensiamo!”.
Mi distendo sul letto, lei siede al tavolo, nel buio di un black-out.
La bambina di nome Gesù sfugge ai nostri sguardi.
Cala un silenzio pesante, un silenzio di nodi irrisolti, un silenzio di dolore.
Al contempo, sale in me una certa insofferenza: “vuoi andare via?”, le chiedo.
Lei non risponde, si alza, elude l’angolo del tavolo ed esce, recuperando lontano dai miei occhi la bambina di nome Gesù.
“Va bene, meglio così”, mi viene subito da pensare.
Decido di digiunare; sarebbe la prima notte di Natale della mia vita trascorsa a digiuno.
Ho in tasca un biglietto per un concerto di musica classica indiana, da raggiungere di lì a poco.
Altri pensieri mi si affastellano nella mente, oscillando tra una sostanziale accettazione, forse un po’ troppo fatalista, della situazione presente ed uno dei miei netti rifiuti di Sobala.
Lascio che il concerto crei un momento di sospensione su questo blando travaglio.
A concerto finito, ritorno sull’idea del digiuno, disattendendola deliberatamente.
Mi incammino dunque verso il quartiere musulmano per un Chicken Achary: un pollo molto speziato che servono espresso dopo averlo riscaldato su di un rudimentale barbecue.
In genere il pollo sarebbe da portare via (come nelle nostre rosticcerie) ma c’è modo di mangiarlo anche a casa del “rosticcere”, con la porta aperta dirimpetto alla bottega.
Nell’ingresso della casa è stato allestito un tavolo con due panche di rozza falegnameria.
Di fronte al tavolo c’è un frigorifero per i cold-drinks ed un televisore.
Capita che passi delle belle serate a fare zapping tra un piatto di pollo e l’altro, sorseggiando una seven-up.
Raggiungo dunque il mio rifugio da carnivoro ma il pollo, oggi, non c’è.
Non ci sarà per una setttimana, mi dicono, è una ricorrenza religiosa!
Sto masticando delle noccioline, alungo solo la mano su uno dei chapati esposti, impastati in questo caso con un po’ di lievito, ragion per cui sono leggermente più gonfi ed appetitosi e faccio marcia indietro.
Mi fermo dunque in un chat-point, uno spazio dove si servono polpettine di patate cotte su di una piastra assieme ad una salsa di ceci speziata.
Il chat-seller è affabile. Mi fa sedere su una panca, in una sorta di disimpegno-sgabuzzino che si sviluppa per lungo, in cui lui ha ricavato uno spazio di intrattenimento per i clienti.
Mi chiede se voglio anche da bere.
Dopo la mia risposta affermativa si trascina nel suo dhoti (panno che viene avvolto ai fianchi) logoro a prendermi una fanta.
Nel disimpegno ci sono un paio di uomini.
Mi chiedono da dove venga.
“Sono italiano”, rispondo.
“Merry Christmas!”, mi dicono.
“Grazie!”.
Il chat-seller si avvicina premurosamente con un paio di polpettine di patate.
Le accetto nel piatto, esprimendo gratitudine.
Lui torna appena dopo con una mestolata di salsa.
Mangio e penso a come l’India possa essere davvero una madre, a come ci si possa sentire a casa anche tra persone del tutto estranee, nell’aleggiare continuo di un palpabile senso di famiglia.
I due uomini continuano a parlare tra di loro ma se li guardo smettono e mi sorridono.
Il chat-seller torna di nuovo con il suo abbozzo di sorriso di pochi denti e colletti scoperti ed anneriti dal tartaro e dal betel.
Mi mette altre due polpette di patate nel piatto ed ancora una mestolata di salsa di ceci.
La fanta molto fredda adempie egregiamente alla sua funzione di stemperare il peperoncino prepotente.
Sto quasi bene ed un topo mi si para davanti e traffica con una bustina di plastica dove residuano briciole di pane dolce e la spinge, con il muso, lungo l’incavo tra la strada sporca ed il marciapiede con le zampe a bagnomaria in un piccolo rivolo di fogna.
Mi passa quel che resta del mio appetito, finisce la mia cena di Natale.
Voglio iniziare a muovere verso la casa del dharma, avendo perso di vista il topo, finito probabilmente poco distante dai piedi del chat-seller, sotto il tavolo apparecchiato, in strada, con tutto il necessario per preparare, espresso, il chat.
Al momento di pagare, lui mi chiede 70 rupie, il doppio di quello che gli avrei dovuto.
Gli domando una spiegazione.
Mi risponde bruscamente: “hai mangiato 3 piatti di chat. Sono 20 rupie a piatto e la fanta sono 10 rupie!”.
So bene che il chat costa 10 rupie a piatto e che io ho preso un piatto con due integrazioni più che tre piatti.
Vorrei reagire in qualche modo, potrei anche lasciare lì 40 rupie ed andare via ma l’avvilimento per la costante tendenza che hanno molti, troppi indiani alla piccola truffa mi demotiva e mi limito a pagare, dicendo al chat-seller: “facevi tutto il gentile per fregarmi, eh?!”.
Lui non reagisce, è solo ottenebrato dai soldi che è riuscito ad estrocermi.
Io continuo ad inveire blandamente contro di lui ed i due uomini nel disimpegno guardano la scena un po’ trasecolati. Qualcosa vorrebbe farli intervenire ma qualcosa di più forte li trattiene sulle vecchie panche logore, nel lungo sgabuzzino.
Il chat-seller mi risponde semplicemente e noncurantemente: “uhm, uhm!”.
Mi allontano promettendogli che non mi rivedrà più.
Lui ha ripreso a mescolare la sbobba sulla piastra arroventata, nel pieno del suo cinismo di strada indiano, i piedi nel ristagno del rivolo di fogna, il topo, probabilmente, vicino ai piedi.
Cammino verso la casa del dharma lacerato.
Penso a Sobala, al torto che mi ha fatto a lasciarmi solo la notte di Natale, a sgranocchiare noccioline camminando e poi sbocconcellare del chapati in piedi e trangugiare del chat nello squallore della main road.
Penso alle colpe di una donna che non sa creare un minimo di calore, pur in una casa ricavata per forza, la notte di Natale.
Ripenso che potrei presto portare i miei passi in un paese meno pesante, la Thailandia; un miraggio che si fa strada di tanto in tanto, nelle mie sofferenze indiane.
Telefono a Sobala e lei mi risponde ancora svogliata. Le dico che sono triste ed arrabbiato e che per una settimana non ho nessuna voglia di vederla.
Naturalmente vado a dormire poco sereno ma l’indomani sono in buona forma per trascorrere un Natale un po’ speciale.
Parto relativamente presto, la mattina, dopo aver bevuto un chai nel mio posto di fiducia.
E’ gestito da un bengalese imberrettato di lana, avido ma gentile, con cui siamo riusciti a capirci presto.
Il suo chai-shop è appena dopo un arco di pietra che, dalla strada, conduce in una corte interna, con mucche parcheggiate sotto una tettoia di paglia, i muri prospicenti ricoperti, in buona parte, di cialde di sterco appiccicate ad asciugare, alcune con il segno inconfondibile, apotropaico, della mano.
In un angolo della corte c’è un pozzo funzionante e le donne, nei loro sari colorati, spesso con un bambino in braccio ed un secchio, di fianco, da riempire, ci chiacchierano attorno.
Io in genere siedo su un choki, un “letto di legno”, un tavolaccio da asceti, lo stesso utilizzato in molte case ed in molte economiche guest-houses.
Bahia (“fratello”, un epiteto usato spesso tra conoscenti ed io, dunque, lo utilizzo con il venditore di chai) giunge sollecito con il bicchiere vertiginosamente conico, pieno di chai.
Bevo il chai e mangio dei biscotti e mi godo il sole sul tavolaccio vissuto, preso d’assalto dalle mosche.
Musica gracchiante esce dalla radiolina di Bahia, altri indiani bevono il chai e donne giovani ed anziane siedono vicino al pozzo.
Ogni tanto si sente l’inconfondibile cigolio della carrucola.
E’ Natale ed io, bevuto il chai e mangiati i biscotti, parto per uno dei miei pellegrinaggi sui ghat (camminatoi a margine del Gange).
In genere parto da Assi Ghat, dove vivo, per arrivare a Raj Ghat, l’ultimo verso nord, dopo il quale c’è un grande ponte che sostiene quotidianamente treni, convogli e molte macchine urlanti.
Appena dopo il ponte, sulle pendici di un’altura che muore nel Gange, Varanasi si congeda con uno slum ed inizia l’India profonda, l’India dei villaggi dove è quasi inutile sapere l’inglese, dove si sprofonda in una quiete ancestrale.
Percorrere tutti i ghat è un’esperienza di grande intensità, formativa per gli incontri che si fanno, le tante, diverse emozioni che prendono forma ai propri occhi.
E’ notorio che sui ghat sul Gange si incontra la morte, le pire funebri, l’odore di carne abbrustolita che può far affiorare alla memoria quello di campeggi mediterranei, dove frigolano felicemente i barbecue.
Il contrasto non è dei più banali!
Sui ghat si incontra, sì, la morte, anche quella più tragica e forse più tenera dei bambini, su più piccole lettighe di bambù.
Si incontra la morte accanto ad infinite espressioni della vita.
Si incontra la sensualità di uomini e donne a bagno nelle acque.
Si incontrano la bruttura, la miseria e l’arte e la bellezza. Il sacro, il laido, le truffe, la disperazione, la semplice gioia di vivere, l’innocenza e poi….fiori, tanti fiori, da offrire alla Madre Ganga, rituali ancestrali, animali, barbieri, massaggiatori.
Si torna a casa incredibilmente ricchi e più puliti, dopo una forte catarsi emotiva, associata alla fatica fisica di chilometri di percorso.
Arrivo dunque a Raj Ghat, supero il ponte e lo slum e bambini e uomini chini a defecare sulla riva.
Lascio Varanasi ed entro nell’India dei villaggi. Sarai Mohana è il primo che si incontra e, forse per un gioco di correnti, sulla riva un po’ pantanosa affiorano, ogni tanto, teschi umani, retaggio di vecchie cremazioni. Sono seminterrati nel fango ma si possono distinguere chiaramente…a volte la sola calotta cranica, a volte anche le occhiaie vuote o il foro dove termina la colonna vertebrale.
A volte sono quasi del tutto visibili e si possono contare i denti rimasti.
I cani, lì, possono essere particolarmente aggressivi, soprattutto quando si contendono, come mi è capitato di vedere quel giorno di Natale, brandelli di carne su di una carcassa, fradicia, di mucca, tra le acque della riva.
Proseguo verso il villaggio, mi soffermo nella capanna di un Baba.
C’è un dhuni (fuoco rituale), la solita dotazione essenziale: qualche stuoia, un pentolino e poco più. Non mancano due teschi umani in bella mostra; probabilmente è la capanna di un Aghori Baba, uno di quelli che si cospargono il corpo con cenere di campi crematori.
Proseguo ancora, alle pendici di Sarai Mohana. Mi piacerebbe raggiungere a piedi il villaggio successivo, ancora più remoto, dove le case sono solo di fango, con i tetti di paglia. Dove non esistono negozi, neanche di betel e nemmeno un chai-shop.
Ci sono stato, una volta, in quel villaggio ed in una casa mi hanno offerto quel che rimaneva del loro pranzo: riso, legumi, chapati ed una buona salsa di pomodoro con erbette “pizzicose”.
Ho ringraziato regalando loro una buona saponetta profumata, comprata la mattina in un pretenzioso negozio di Assi Ghat.
Alle pendici di Sarai Mohana mi vengono incontro barcaioli chiedendomi se ho intenzione di avvalermi del loro servizio per tornare in città o per andare sulla riva opposta del fiume.
Inizio ad essere un po’ stanco, ho camminato per tanti chilometri e potrei raggiungere il villaggio remoto – Rajpur – in barca.
Quando si raggiungono le pendici del villaggio, con i suoi orti un po’ stentati, il Gange si divide in piccole o grandi piscine, separate da lingue di sabbia.
L’acqua arriva alle ginocchia o all’inguine ed è sorprendentemente pulita.
Voglio farmi il bagno, oggi e lo voglio fare lì!
Ricorro al mio hindi stentatissimo per comunicare le mie intenzioni ad un barcaiolo.
Si avvicina un ragazzo e mi si rivolge in inglese […]
…e qui il diario si interrompe. Quella mattina di Natale mi sarei fatto il bagno “rituale” per poi ritornare in qualche modo alla casa del dharma e ripartirne il giorno dopo per andare ad Ayodhya, un viaggio di cui ho cristallizzate memorie, proposte nel paragrafo che segue.
Ayodhya 2007, quasi 2008
Era proprio un periodaccio! In ottobre ero andato dal gastroenterologo per un disagio quasi costante dell’intestino. Pensava avessi, banalmente, una Irritable Bowel Syndrom, una sindrome degli intestini irritabili. Mi fece fare un’analisi delle feci. Risultò che avevo l’ameba e c’era del sangue occulto. Mi diede degli antibiotici per uccidere l’ameba e mi prescrisse di rifare l’analisi delle feci dopo una settimana, avvertendomi che se ci fosse stato ancora il sangue occulto era necessario fare una colonscopia. Uccisi l’ameba e rifeci l’analisi delle feci. Il sangue occulto era ancora presente. Il dottore era un po’ preoccupato. Poteva essere anche un tumore! Feci la colonscopia, una mattina, dopo un’attesa di circa un’ora in una sala d’aspetto ingombra di indiani sostanzialmente silenziosi, con sguardi quasi solidali che solo di rado lasciavano spazio a qualche episodio di consueta maleducazione. Fu un po’ doloroso ma niente di drammatico. Avevo piccole ulcere nell’intestino. Vennero dati ad analizzare campione di materiale intestinale, prelevato dalle aree ulcerate. Trascorso il tempo necessario per l’esame istologico, la diagnosi fu allarmante: Morbo di Crohn. Il dottore, mi ricordo, non si scompose. In realtà la diagnosi era alquanto laica: le ulcere avevano una morfologia che poteva essere riconducibile al morbo in questione. Il dottore non si scompose ma fu categorico e non poteva affatto permettersi di esserlo. Come ebbi a verificare poi, infatti, il Morbo di Crohn non può essere diagnosticato avendo solo, tra le mani, i risultati di un esame istologico. In assenza di sintomi e di parametri anormali di altri esami non si può, semplicemente, diagnosticare. Lui mi tranquillizzò, mi disse che non era grave, che mi sarei dovuto curare per circa 5 anni, che poi sarei guarito e che, fin tanto che ero in India, mi poteva seguire lui e, naturalmente, le medicine le potevo comprare nel suo medical store, di fianco alla sua clinica. Feci delle verifiche su internet; quel medico era un incompetente o, peggio, un criminale! La malattia è piuttosto seria ed è, sostanzialmente, incurabile. Ha sintomi inequivocabili e, per essere diagnosticata, richiede, ripeto, diversi esami. Tuttavia, leggere su internet tutte le complicazioni che poteva avere il Morbo di Crohn mi gettò in uno stato di allarme profondo. Era da qualche mese che mi si era alterata la fisiologia del sonno, che mi svegliavo molto presto la mattina perché nel corso della precedente estate ero stato svegliato diverse volte, durante la notte, dai powercut, dalla cessata erogazione della corrente elettrica che aveva come conseguenza diretta l’arrestarsi del fan (ventilatore) ed una sudorazione copiosa che non poteva non svegliare. In poche parole, iniziai a soffrire d’insonnia. Dove vivevo allora, nella cosiddetta casa del karma, i powercut avevano anche un’altra aggravante. Essendo il posto di fronte ad un ospedale, come veniva a mancare la corrente, partiva un generatore rumorosissimo che, sicuramente, non aiutava a riprendere sonno. Dopo alcuni giorni la situazione era diventata quasi insostenibile. Dormivo 3-4 ore a notte. Mi svegliavo alle 2, alle 3 del mattino e non c’era verso di riprendere sonno. Leggevo, meditavo, mi praticavo il reiki. Non c’era nulla da fare. Ero sull’orlo della disperazione quando conobbi Arun, massaggiatore. Un fisico scattante da folletto. Era molto bravo a massaggiare. Mi faceva massaggio ayurvedico e shiatzu e, piano piano, mi aiutò a riconquistare un equilibrio con il sonno. Di dove sei? Gli chiesi una volta. Di Ayodhya, la famosa città di Rama, il sovrano virtuoso protagonista del Ramayana nonché avatar, incarnazione, di Vishnu.
Diventammo amici, lui per me iniziò ad essere “il folletto di Ayodhya”. Era troppo contento di avere un amico europeo anche se non aveva, con me, un rapporto paritario. Mi chiamava Sir. Mi invitava spesso in una casa-rudere dove viveva in una discussa promiscuità con un bramino, responsabile della gestione di un importante tempio. La casa dava su un kund, una piscina rituale, sacra a Lakshmi, moglie di Vishnu. Inutile dire che farsi il bagno in quella grande vasca quadrata non era del tutto consigliabile. La superficie dell’acqua era completamente ricoperta del verde di alghe infestanti e sotto poteva esserci, davvero, qualunque cosa. Arun, dal muro della sua casa, confinante con la Lakshmi Kund, ci sputava i fiotti rossi di saliva sovrastimolata dal betel. Il bramino che lo ospitava, di tanto in tanto, andava a Bombay e lui allora mi invitava, pressantemente, a cena. Cucinava bene, molto speziato, al solito ma ci metteva l’anima. La casa si sviluppava, fondamentalmente, in un lungo corridoio, spezzato da una sorta di maldestro separé, sul finire del quale un letto matrimoniale con coperte lise era prossimo al frigorifero, al lavandino ed al ripiano della cucina. Procedendo ancora si arrivava in veranda. Era in realtà un’altra grande stanza della vecchia casa. Era diventata una “veranda” a seguito del crollo rovinoso del tetto, mai più ricostruito. Mangiavamo in veranda e la situazione, alquanto grottesca, mi faceva pensare al noto koan zen: il tetto è bruciato, ora posso vedere la luna. In effetti la luna era ben visibile ed anche le stelle. Si riflettevano tra le rare increspature libere dal verde delle alghe infestanti dell’acqua della Lakshmi Kund. Di più: uno splendido albero di mango aveva allungato i suo rami quasi a voler ricoprire e proteggere chi si trovava in veranda, la sera, su sedie scricchiolanti e ballerine e ad incorniciare spezzoni di cielo.
Era diverso tempo che volevo andare ad Ayodhya. Lo dico un pomeriggio ad Arun, nel corso di un massaggio. “Benissimo Sir”, mi risponde, “andiamo a casa mia”. Arun aveva il cordone dei bramini, di traverso sul petto e sulla pancia. Quando faceva la pipì, come tutti i bramini, lo agganciava all’orecchio. Pensavo una famiglia di bramini potesse avere una casa “possibile”, almeno per i parametri indiani. In qualche modo, tuttavia, mi sbagliavo. Partimmo un giorno che avevo quasi risolto i miei problemi di insonnia. Partimmo con il pullmann pubblico, da Varanasi, arrivando dopo quasi una giornata di viaggio-calvario. Scendeva la notte sull’ultimo tratto di viaggio, in prossimità della città di Rama. “Sir”, mi sento dire da Arun, “il bagno…non è proprio il massimo nella casa dove stiamo andando. Ci sono problemi?”.
“Non so”, rispondo, “dipende, che problema ha il bagno?”.
“Nulla, nulla”, risponde Arun, “non è eccellente, tutto qua!”.
Arriviamo e veniamo accolti come fossimo stati due figliol prodighi che avevano finalmente ritrovato la strada di casa. Lo stesso calore. Vive in un altro rudere, Arun, ad Ayodhya. In una sorta di complesso templare con diversi annessi. Edifici vecchi di 300 anni, mai manutenuti, mai riscaldati seriamente, fradici di umidità. Non si vede nulla. E’ buio e c’è powercut. Ombre si avvicinano, mi stringono la mano calorosamente, mi salutano con gesti rituali, mi fanno sedere su una sedia ancora scricchiolante e ballerina, davanti ad un calderone di braci. E’ la fine dell’anno, ad inverno avviato. Loro non parlano inglese, a parte un ragazzo. Io parlo poco hindi ma lo uso senza risparmio. La conversazione, del resto, è elementare. Chiedo ad Arun di poter fare pipì. “Falla lì, Sir” e mi indica un angolo, poco distante da un vecchio arco da cui si accede ad una cortissima galleria “sul mistero”. Un rivolo fognario si perde, in un alveo artificiale, nella breve galleria. Arun mi fa capire che se centro il rigagnolo fognario è meglio. Dormo in camera sua quella notte. I muri hanno grandi chiazze di umido, sono madidi di acqua. L’indomani realizzo che siamo almeno trenta persone nel complesso templare con gli annessi. Sono tutti più o meno imparentati, con una piccola legione di teneri bambini. C’è un antro con i muri completamente ricoperti di muschio, un orinatoio senza nemmeno un’idea di acqua, con la base ricolma di calcinacci e rifiuti. Addentrandosi ancora nell’antro, con la giusta dose di coraggio, si aprono due vani laidi, sulla sinistra. Due turche dove è quasi impossibile distinguere il buco tanto si confonde e mimetizza in un luridume pressoché uniforme ed indistinto. La mattina, i membri del clan fanno la fila ad una certa distanza dall’antro. Ognuno ha in mano un secchiello pieno d’acqua. Alcuni secchielli hanno perso il manico, al cui posto hanno una protesi di filo elettrico inturcinato. Alcuni secchielli non sarebbero adatti a fungere da sommari bidet, sono vecchi secchi di vernice, con il bordo troppo largo per cui è difficile versarsi l’acqua sulla mano senza disperderne una buona parte. Fungono, ripeto, da sommario bidet e da contenitori dell’acqua di scarico. Alla fine, tuttavia, l’acqua è sempre troppo poca perché ci si preoccupi di lavare via le feci dal buco mimetizzato nel luridume uniforme, per cui nessuno può lasciare il “bagno” pulito per quello che verrà. Rimango ad Ayodhya 4 o 5 giorni. Vengo adottato sin dal primo giorno. Il fratello superiore di Arun ha una bella moglie e 6 figli: un maschio e 5 femmine. La più grande studia a Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh, poco distante da Ayodhya. Vivono in otto con 12000 rupie al mese (al cambio attuale, nemmeno 200 euro), guadagnate dal capofamiglia con una vecchia jeep utilizzata come taxi. La vita materiale di otto persone è appesa ad uno scassone che, la mattina, non ne vuol sapere di partire ma le braccia, per spingere, non mancano. C’è un clan a disposizione in quel che resta del vecchio complesso templare e la jeep, regolarmente, finisce, tra rantoli e singulti, per partire. I membri della famiglia del fratello maggiore di Arun dormono insieme in due stanze/accampamento dove l’unica a non essere ammessa è Madame Solitudine. Mangiano in una cucina stretta e lunga (non lunghissima) con piccoli topi che escono da sotto il frigo. Le figlie di casa cucinano, l’unico maschio, Bahia, “fratello maggiore” ed il capo-famiglia, arrivano quando, si direbbe da noi, “è pronto in tavola”. In questo caso si può, semplicemente, dire “è pronto” perché la tavola, semplicemente, non c’è. Non ci sono tavola né sedie. Tutt’al più microsgabelli che loro lasciavano, uno sull’altro, per l’ospite d’onore: per me! Mangiavamo seduti in terra, io appollaiato sui due sgabellini sovrapposti. Le donne mangiavano dopo di noi. Non c’era abbastanza spazio per mangiare tutti insieme. Si mangiava in piatti multiscomparto. In genere: una zuppa terribilmente speziata, riso, chapati, verdure ugualmente, spietatamente speziate e qualche legume. Si mangiava con le mani, si ruttava a fine pasto, comodi, i maschi di casa, nei soffici dothi. La mattina, a far la fila con il secchiello pieno d’acqua in mano, si dava segni di una certa inquietudine intestinale. Ricordo il capofamiglia, al momento di poter fruire dell’antro, mi diede amichevolmente, la precedenza. Lui mi raggiunse poco dopo, nel vano di fianco al mio. Sentivo i suoi sospiri ed i rumori bassi, triviali, delle feci uscire molli, flaccide, con un po’ d’aria, dal suo retto. Questo, ricordo, rinforzò il nostro rapporto fatto di poche sillabe in hindi. Non ci capivamo, eravamo reciprocamente dei marziani, ma eravamo l’uno a fianco all’altro, pur separati da una parete fradicia che finiva ad altezza d’uomo, in un momento laido e tuttavia essenziale alla vita di tutti. Ripenso oggi con il sorriso all’amicizia virtuale su facebook e ripenso a come quel momento abbia suggellato qualcosa tra noi due, qualcosa che era così grottescamente poco virtuale. In un paio di giorni ebbi accesso ad un grande letto matrimoniale di una delle loro due stanze, con le bambine addosso a vedere, assieme, i loro video di Bollywood. Ormai, anche io ero diventato bahia, come Pawan, come il fratello di sangue. Al momento della cena mi servivano con la stessa naturalezza con cui servivano il padre ed il fratello. Mi avevano integralmente acquisito nella famiglia. Io ricambiavo mettendo mano al portafoglio, comprando prodotti per loro difficilmente accessibili, come il paneer (semplice formaggio di mucca). Andavamo a prenderlo in una simil pasticceria, sulla strada principale di Ayodhya, dove fumigavano pentoloni di latte e sbobbe speziate ed i rigagnoli fognarii, ancora in alvei rozzamente artificiali, segnavano desolatamente le strade. Una delle volte che tornavamo dal nostro shopping in pasticceria, Pawan irradiava felicità, con la sua bustina di paneer in mano e mi diceva come le sorelle lo avrebbero cucinato. Non fa a tempo a compiacersi del suo sogno che il paneer gli viene bruscamente strappato di mano. Una scimmia! Sono migliaia ad Ayodhya. Sono sacre. Hanumann, il dio scimmia, servo fidato di Rama e del fratello Lakshmana nel celebre poema epico del Ramayana, è il protettore della città. Non faccio a tempo a fissarmi sulla faccia incredula e sgomenta di Pawan che, dai cornicioni, dai rami di molti alberi, dai tanti anfratti, da buchi nel sottosuolo escono decine di altre scimmie a contendersi il paneer appena trafugato. Ne arriva una, arrancando, malata e tuttavia vitale, quantomeno con un insopprimibile istinto di sopravvivenza che la guida. E’ completamente glabra, dalla testa ai piedi; sembrerebbe la caricatura della scimmia nuda di Desmond Morris. Torniamo, con Pawan, dall’amico pasticciere per un’altra busta di paneer, da tenere stretta sotto la maglietta questa volta.
Usare l’acqua, la mattina, era un’impresa quasi disperata. C’erano vari rubinetti patetici, nel complesso templare, con l’acqua che fuoriusciva (quando fuoriusciva) in due o tre fiotti diversi, dalle diverse spanature. Tuttavia erano spesso secchi. Dispensavano l’acqua poche ore al giorno, poi bisognava arrangiarsi diversamente. Io finivo sempre per mendicare un po’ di acqua da Ramakrishna, cugino di Pawan, in un annesso poco distante. I due rubinettini della casa amorfa in cui viveva con la sua famiglia avevano quasi sempre l’acqua. Di più: i famigliari di Ramakrishna avevano costruito una sorta di cabinato di mattoni ed era il vano-doccia di tutto il clan. Naturalmente non c’era l’ombra di una vera doccia, si entrava, semplicemente, con un secchio pieno di acqua ed un secchiello vuoto. Il mattonato, tuttavia, era talmente sconnesso che camminandoci sopra si barcollava e parte dell’acqua del secchio che si portava in mano, inevitabilmente, cadeva. La doccia si faceva, ad Ayodhya, come si fa spesso in India, prendendo una porzione di acqua, con il secchiello, dal secchio per versarsela addosso. L’acqua era, naturalmente, fredda. Io, tuttavia, non mi rassegnavo a battere i denti e chiedevo a Pawan o a Ramakrishna di farmi riscaldare la mia acqua in una pentola. Loro mi dicevano che facevo male ad usare l’acqua calda, che l’acqua fredda mi avrebbe rinforzato di più e che tutti i maestri, finanche i Veda, consigliano di lavarsi con l’acqua fredda. Erano tutte manfrine per risparmiare il gas, io allora tentavo di fare almeno intiepidire l’acqua al sole. Loro, tuttavia, erano sempre pulitissimi, con le loro docce fredde alle 4 del mattino, sempre perfettamente sbarbati. Di qui si riconosceva il loro essere bramini. Una mattina ero alle prese con uno dei rubinetti, vicino la camera di Arun, dove mi ero malamente accampato. Stava dando gli ultimi fiotti di acqua. Una signora anziana, del clan del complesso templare, mi guarda quasi incredula: perché non usi il sapone? Il sapone? Rispondo, quale sapone? Quello, mi indica lei. Faccio fatica a riconoscerlo, era una pallina minuscola di sapone che si perdeva tra le sfumature di umido di un ripiano di pietra.
Difficilmente ho visto convivere una così profonda precarietà con un’altrettanto profonda umanità, che trapelava chiaramente dal senso di unione fraterna che si provava al momento dei pasti o facendo la fila per accedere al bagno o guardando, tutti assieme, nel grande letto, i video di Bollywood.
Lasciai Ayodhya per Lucknow, per un albergo un minimo decente ed una doccia calda. Trascorsi il capodanno a Lucknow con Pawan, Ramakrishna, Arun che mi telefonavano di continuo, non mi lasciavano mai solo. Tornai ad Ayodhya per prendermi una giardia (parassita intestinale). Rimasi ancora un paio di giorni, poi combinammo per un biglietto del treno ed un ritorno a Varanasi. Il treno tardò un numero imprecisato di ore. Pawan e Ramakrishna hanno aspettato con me in una delle stazioni più squallide dell’India, dove mi hanno protetto da un branco di scimmie fameliche nel momento in cui mi stavo concedendo un piccolo spuntino con un pacco di patatine. Quando arriva il treno sono praticamente stremato. Mi accompagnano sin nello scompartimento. Sono commossi. Il treno inizia a muoversi lentamente. Loro scendono di filato, il treno inizia a muoversi più velocemente. Ramakrishna corre dietro al treno. Mi urla alcune cose: “ritorna, mi raccomando, quando ritorni?”.
“Torno, tornerò, te lo prometto!”.
Ancora oggi, quando sono in India, con cadenza grossomodo mensile o bimestrale il mio cellulare suona e compare un numero sconosciuto, che non ho mai salvato ma è sempre lo stesso. Rispondo aspettandomi, ogni volta, che sia qualcuno che ha sbagliato numero o la pubblicità.
“Hello”?
“Hello!”; spera ogni volta che lo riconosca ed io, in genere, lo deludo.
“Hello?”
“ Hello!”
“Chi è?”
“Vecchia mutanda…”, era un epiteto con cui mi rivolgevo loro.
Rido, a quel punto lo riconosco. E’ Ramakrishna (che nel frattempo si è sposato). Si informa dove io sia, ha sempre in progetto di venirmi a trovare o andare da qualche parte insieme poi, alla mia domanda “dove sei”, la risposta è sempre la stessa: “ad Ayodhya!”.
Difficilmente, nel corso, oramai, di molti viaggi e di periodi più o meno lunghi vissuti in paesi anche molto diversi tra loro, ho visto convivere tanta, irrimediabile precarietà con un’altrettanto profonda umanità!
Purtroppo, non sono ancora riuscito a mantenere la mia promessa e di questo, nei rari momenti in cui il mio pensiero torna ad Ayodhya, non posso non rammaricarmi.
Manuel Olivares

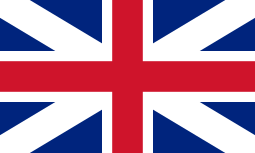 English
English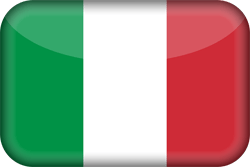 Italian
Italian