Ali di farfalla, seconda parte
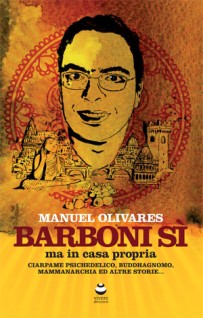
Un racconto, presentato su questo blog in tre puntate, inserito nella raccolta Barboni sì ma in casa propria. Per leggere la prima parte, cliccare qui! Per leggere la terza, cliccare qui!
Buona lettura!L’incontro con Sobala
Entrai una mattina nel vano dove insegnava. Si sentiva la sua voce squillante e poderosa da fuori la porta. Stava intonando i mantra del surya namaskar, un complesso di esercizi yogici più comunemente conosciuto come “il saluto al sole”. Busso ed entro, cercando di non essere eccessivamente invadente. Sobala continua ad intonare i mantra e due allieve, davanti a lei su due logori materassini, eseguono la sequenza di asana del surya namaskar. La nuova presenza, nella stanza, non la induce a smorzare un po’ i toni. Mi dà immediatamente l’idea di essere una persona un po’ sopra le righe e questo non mi dispiace.
Dopo aver finito di guidare il surya namaskar, Sobala si gira verso di me guardandomi con occhi placidi, impercettibilmente interrogativi. Rompo il ghiaccio come si può fare facilmente a Varanasi, congiungendo le mani davanti al mio petto, facendo un leggero inchino e pronunciando il saluto convenzionale: namasté.
Namasté mi risponde Sobala. Ugualmente saluto le allieve.
“So che qui è possibile seguire delle classi di yoga”, le dico, “ che c’è una buona maestra, immagino che sia tu” e sorrido sornione.
“Sì, sono io”.
“Posso aggregarmi nei prossimi giorni? Ti avverto che sono abbastanza digiuno di yoga ma ho praticato diversi tipi di meditazione”.
“Va bene, se vuoi puoi venire domani alle nove di mattina e cominciamo. Chiedo 150 rupie a lezione”.
“D’accordo. Come ti chiami?”
“Sobala, significa donna forte.”
Mi presento a mia volta.
Mentre le parlo, Sobala tiene gli occhi chiusi e la testa reclinata leggermente indietro con il mento proteso un po’ in avanti. Sembra particolarmente ispirata e, a giudicare dal canto con cui mi ha accolto, anche un po’ invasata. Mi incuriosisce subito e l’indomani, puntuale, mi presento per la mia prima classe di yoga.
Sono particolarmente impedito nelle asana i primi giorni ma lei non perde occasione per incoraggiarmi. Alla fine di una delle prime lezioni mi accenna ad una particolare tecnica di pranayama. Mi dice che devo piegarmi a novanta gradi, inspirare, espirare mandando in dentro lo stomaco e poi iniziare a contrarre e rilasciare ripetutamente il ventre cercando di tenere l’orifizio anale ben aperto. “Prova!”, mi dice e si mette dietro di me che nel frattempo ho assunto la postura indicata. Mi spinge lo stomaco in dentro quando lo contraggo e si raccomanda: “apri bene l’ano!” e appena dopo: “ei, non aprirlo troppo, però!”, alludendo al fatto che, essendo immediatamente dietro di me, ogni conseguenza inintenzionale di un’eccessiva apertura potrebbe investirla in pieno.
Non posso non ridacchiare, apprezzando il suo senso dell’humour, la sua scioltezza francamente insolita per una donna indiana. Sono anche un po’ sorpreso da questa immediata confidenza. Tuttavia, come ho già accennato, mi capita non di rado in Oriente di scoprire una profonda famigliarità con persone che conosco da pochissimo tempo.
Sobala iniziò presto ad essere la pietra angolare su cui poggiò la mia prima esperienza varanasina.
Ad ogni lezione sembrava che il nostro feeling crescesse e questo metteva quasi in imbarazzo l’altra sua allieva, una londinese con dread rastafariani-shivaiti. Aveva uno sguardo particolare, colore del deserto. Sembrava permeata da una costante, dimessa beatitudine ed io avrei cominciato a chiamarla, semplicemente, Beata.
Ora che un bel po’ di acqua è passata, anche rumorosamente, sotto i ponti, esco a fatica dal tempietto di Sarangkot. Mi appresto a raggiungere la cima, lasciando Sobala seduta vicino alle sue scarpe bianche. La visione di Pokhara dall’alto e della World Peace Pagoda su una delle sue alture merita il sudore della salita ma non mi soffermo molto a contemplare il paesaggio; non mi fido a lasciare Sobala troppo sola. È molto bella ed è spesso oggetto di attenzioni poco signorili. Arrivo presto nei pressi del tempietto ma non la trovo né dentro né fuori. Appena dopo mi sento chiamare, con il modo ridente e radioso peculiare del suo buon umore. Siede sul muretto di fango di una capanna poco distante. Ha fatto amicizia con una contadina-montanara del posto. Le ha chiesto di bollire per noi un paio di uova appena prese dal pollaio. La raggiungo. Siede comoda su di un sottile materassino di paglia.
La capanna ha due vani. Uno, “la cucina” è poco più grande di uno stanzino di città ma ha, naturalmente, tutto un altro fascino. È di una semplicità disarmante. L’interno è in terra battuta. Ugualmente in terra battuta è il piccolo piano rialzato, a ridosso del muro. È ad altezza d’uomo accucciato e, nel mezzo, ha un incavo dove la contadina-montanara sta bruciando della legna e dove poggia un piccolo tripode di ferro che sostiene una teiera metallica annerita dal fumo.
L’altro vano non è meno fascinoso e disarmante. Si sviluppa attorno ad una trave centrale, di fianco alla quale stanno, ad angolo retto contro i due lati del muro, due letti in legno di rozza falegnameria. Su ciascuno poggia un materassino di paglia, uguale a quello dove siede comodamente Sobala ed un cuscino. Su uno dei due c’è anche una vecchia trapunta arruffata.
Sono di rozza falegnameria anche gli scaffali che ospitano un inventario scarno di suppellettili: piatti e bicchieri di ferro, qualche pentola e non molto di più.
C’è un ordine minimale, una pulita dignità nei pochi metri quadri di quest’interno nepalese e la stessa ruvida armonia traspira dal corpo e dai vestiti della contadina-montanara.
Qualcosa si rompe a Lumbini
Il pullmann che da Pokhara porta a Lumbini -poco distante dal confine con l’India- dove vide la luce e mosse subito i suoi primi passi Gautama Siddharta, è scomodo quasi oltre ogni tollerabilità.
Sono di corporatura tendenzialmente minuta i nepalesi ed è dunque stato difficile, per me, comprare qualche vestito a Kathmandu ed ora, in viaggio per Lumbini, stare sufficientemente a mio agio sui sedili angusti.
Il Nepal è un paese disastrato, semiparalizzato da scioperi continui, sostanzialmente inconcludenti. Arrivati nei pressi di Bhairava difatti, a circa 20 chilometri da Lumbini, il Pullman si ferma in un distributore di benzina.
L’autista scende e, dal finestrino, parla con Sobala in hindi. Le dice di avvertire i passeggeri che il viaggio deve, giocoforza, finire lì, che non si può procedere, che la strada è bloccata dalle auto degli scioperanti. Sobala traduce in inglese per il resto dell’equipaggio, una quindicina di persone tra europei, cinesi e coreani.
Nell’area del distributore sono già pronti diversi rikshaw-wallah. Io e Sobala riusciamo ad issare i nostri tanti bagagli su un rikshaw e partire, a pedali, alla volta di una stazione di autobus di linea.
Il rikshaw-wallah si disimpegna in una rete di strade e stradine più o meno desolate, più o meno asfaltate, sporche ed infangate. Arriviamo in una grande area-mercato con bancarelle in terra su sacchi di tela. Ci sono angoli, nella polvere e nel fango, con pullman sgangherati attorno ai quali si affastellano persone ma ogni corsa è a rischio per la solita ragione: lo sciopero.
Non c’è verso di capire se possiamo prendere un autobus per Lumbini oppure no, se c’è da aspettare mezzora, un’ora o fino al giorno dopo, quando lo sciopero sarà rientrato. Nel momento in cui chiediamo informazioni si affastellano 3 o 4 persone attorno al nostro rikshaw, dandoci versioni diverse, raramente disinteressate. Tendono difatti a scoraggiarci e ad indicarci il più vicino taxi per un loro piccolo tornaconto. È tutto un traffico di piccolo cabotaggio in quest’area del mondo. Il rikshaw-wallah, un uomo anziano e dimesso, si offre timidamente di portarci fino a Lumbini a pedali. Mi sembra un’idea un po’ peregrina, sono circa 22 chilometri. Qualcuno dei ruffiani che stanno facendo capannello attorno a noi ride rumorosamente. Dico a Sobala di chiedere al temerario se se la sente davvero, se ha valutato adeguatamente la distanza e lo sforzo, siamo pieni di valigie. Sobala parla al rikshaw-wallah in hindi, una lingua che, in genere, i nepalesi comprendono e parlano pur con una certa approssimazione.
Lui è convinto e chiede 400 rupie, una cifra ragionevole. “Va bene”, rispondo io, “leviamoci di torno questi ruffiani!”. Partiamo. Il rikshaw-wallah pedala con naturale tenacia. La strada è diritta e piana e questo senz’altro agevola il nostro viaggio. Siamo nel profondo sud del Nepal ma sembra già di essere in India. Il paesaggio è identico a quello dell’Uttar Pradesh, dove ci aspetta la nostra Varanasi. Allontanandoci da Bhairava, i bordi della strada si movimentano di piccoli agglomerati di case di fango, spesso distribuite attorno ad un grande albero di mango. Uomini a torso nudo, in canottiera o maglietta, con il fianco cinto da dhoti logori, siedono comodi in terra o si aggirano con rozzi attrezzi agricoli in mano. Le donne, avvolte nei loro sari, spidocchiano i bambini, impastano lo sterco di vacca, usato come combustibile o semplicemente siedono a proprio agio.
I bambini, spesso nudi, animano sommessamente questi microcosmi che sembrano sprofondati in una quiete ancestrale.
È questa una delle dimensioni più affascinanti che si possono trovare in quest’area del mondo. Una campagna povera e brulla dove si percepisce chiaramente la suggestione dell’atemporalità, un elemento peculiare, a parere di molti indologi, della cultura indiana tradizionale che ha spinto sino a qui le sue radici.
Nella campagna profonda indiana, il tempo è generalmente il grande assente. Verrebbe quasi di fermare qualcuno di questi uomini sospesi in un lontano ma tangibile passatopresente e chiedergli: hai visto il tempo?
L’atemporalità, dettata da una concezione filosofica e religiosa circolare e dilatata, è uno dei cardini attorno a cui gravita l’India di tutti i giorni. È la causa, tra le altre cose, di una scarsa propensione degli indiani alla progettualità. Questa li rende impulsivi ed un po’ selvaggi ed ha penalizzato molto seriamente testi come “Il contratto sociale” di Rousseau che hanno invece dato un buon impulso al vivere collettivo europeo.
Gli effetti di tutto questo è possibile ritrovarli nei comportamenti anche minuti del popolo indiano che non riesce, ad esempio, a rispettare le file nelle stazioni, negli uffici o nei negozi privilegiando, impulsivamente, un “buttarsi prepotentemente all’arrembaggio”.
Procediamo lentamente verso Lumbini. Il caldo rovente della giornata si sta lentamente stemperando con l’avvicinarsi del crepuscolo. Il silenzio avvolgente di questo angolo indiano-nepalese è spesso rotto dai clacson boriosi delle motociclette o di qualche, sparuta, automobile.
La scarsa attenzione a “Il contratto sociale” di Rousseau si esprime anche in un modo di vivere le strade come fossero solo proprie, in barba ad un elementare rispetto del codice.
Tuttavia, prendono corpo dei momenti in cui i centauri o i pochi automobilisti non impestano la strada diritta su cui pedala tenacemente il nostro eroico rikshaw-wallah. Allora è possibile ritrovare qui i ritmi rarefatti di sempre.
In questi momenti si può gioire di un silenzio animato da camminatori vestiti poveramente, da carri le cui ruote rilasciano appena qualche discretissimo scricchiolio e persino i bambini seminudi, compresi in questa quiete quasi irreale, evitano di sciamare o piangere senza ragione e l’abolizione del tempo dei testi di indologia diventa, finalmente, cosa viva. Succede quasi di sprofondare in un breve incanto dove il muro dei millenni improvvisamente sfuma come fosse una semplice, impalpabile cortina di nebbia e siamo nuovamente, pur nel terzo millennio, in un passato che ci appartiene, di cui rechiamo, nel profondo, una chiara memoria.
Il rikswah-wallah continua a pedalare anche lui rispettoso della quiete della strada.
Sobala mangia dei litchis e vive questi sprazzi di quiete senza un particolare stupore, con la naturalezza di chi ha famigliarità con le dimensioni sconfinate dei silenzi meditativi.
Io invece sono profondamente coinvolto. Vivo un incanto che ha qualcosa di sobriamente estatico. Penso che vorrei che la nostra casa fosse in un posto del genere, dandoci l’opportunità di vivere a fondo questa sorta di sospensione di ansie e desideri. Nel frattempo il rikshaw si avvicina ad un punto più affollato della strada. Ai bordi sono ancora agglomerati continui di casupole e piazzali di terra all’ombra di imponenti alberi di mango. Mucche e bufale mangiano placide da greppie di pietra. Diversi uomini confabulano piano ed altri entrano o escono da una strada laterale che porta, ho modo di vedere fugacemente, ad un mercato splendidamente naïf, con bancarelle in terra su stracci di tela e piccole montagne di frutta ed ortaggi.
Vorrei quasi fermarmi ma stiamo gioendo troppo, con Sobala, a lasciarci trasportare.
L’incanto purtroppo non dura molto, nel momento in cui nuovi motociclisti ci sfrecciano vicino suonando all’impazzata e violentando la quiete e l’armonia.
Il viaggio sembra quasi interminabile ed inizia a pesarci la postura rigida e contratta sul rikshaw. Accade spesso in quest’area del mondo di passare velocemente da uno stato d’animo di quasi beatitudine ad uno di insofferenza e frustrazione. Il rikshaw-wallah continua a pedalare tenacemente e tuttavia nulla lascia sperare che si arrivi in tempi ragionevoli per le nostre gambe e la nostra schiena.
Si inizia a intravedere, a media distanza, una grande statua del Buddha. Stiamo dunque per entrare nel villaggio di Lumbini. Questo ci si rivela presto un posto patetico, soprattutto in considerazione del fatto che dovrebbe essere una delle più importanti mete di pellegrinaggio nel mondo.
Ci sistemiamo in un albergo sulla strada centrale, asfaltata solo nel primo tratto e che prosegue, poi, sterrata e polverosa, fiancheggiata da capanne di fango.
Il proprietario ce la mette tutta per mettere a proprio agio i clienti. Ha un sorriso solare su tratti somatici peculiarmente nepalesi. Congiunge spesso le mani; sembra come compreso in un costante stato di grazia. Malgrado la sua presenza beatifica lo standard dell’hotel è abbastanza in sintonia con la depressione complessiva del luogo.
Trascorriamo giorni moderatamente meditativi a Lumbini ed è forse l’eccesso di introspezione ad allontanarci, inspiegabilmente, con Sobala.
Inspiegabilmente ripeto, cosa che mi indurrebbe a pensare la causa sia altrove, in quello che si sta smuovendo al nostro interno, su cui non abbiamo evidentemente potesta’.
Dilatando un po’ l’obiettivo di questa narrazione, ho concluso abbastanza presto che il nostro rapporto, come ogni rapporto che si rispetti, ha un aspetto “esoterico”.
Sin dall’inizio ha avuto un decorso autonomo che prescindeva, in buona parte, dalle nostre volontà.
Ricordo la primissima fase ebbe inizio con un richiamo lungo ed efficace da parte della domestica della mia guest-house, il primo anno a Varanasi. Avevo visite e non riuscivo ad immaginare chi potesse essere. Esco dalla mia camera sul ballatoio da cui posso vedere la sala d’ingresso. Con grande piacere trovo gli occhi di Sobala puntati nella mia direzione, sotto un semplice scialle nero. La invito in camera sotto lo sguardo vigile ed un po’ scandalizzato della domestica. Sobala non giustifica la visita inaspettata ed io sono quasi in imbarazzo. Le mostro il libro che sto leggendo: “Benares, city of light”, un classico! Le propongo di bere un tè; lo posso preparare nella cucina al piano di sopra. Lei accetta. Usciamo dunque dalla stanza, con la domestica che ancora si aggira inquieta non lontano da noi, per osservarci e carpire qualcosa. In India c’è una tendenza decisamente irritante a vivere le vite degli altri. Sentimenti come la curiosità morbosa, l’invidia, la gelosia hanno cittadinanza onoraria. Questo probabilmente anche in ragione del sostanziale immobilismo della società indiana. La cultura castale, ancora alla base del sistema sociale in India, condanna la gente ad un destino preciso, senza grandi possibilità di uscire dal tracciato. Dopo un periodo prolungato di vita in questo paese ho identificato questa condanna (non trovo davvero che il termine sia eccessivo) con quella che considero essere “la grande tragedia del popolo indiano”; la “tragedia dell’ineluttabilita’”.
Ci sono persone che, in casi non ancora disperati, passano la propria vita in una vecchia canottiera sudata, sedute in terra a vendere riso in miseri misurini senza prospettive concrete di riscatto. Cos’altro possono fare se non rivolgere morbosamente la propria attenzione ai successi ed agli insuccessi degli altri?
Con Sobala beviamo il tè in un’atmosfera sobriamente avvolgente, di luce soffusa da un lampadario di lampadine economiche e, in qualche caso, fulminate.
Qualcosa ci lega nel profondo ma il frutto è ancora lungi dall’essere maturo.
Troviamo facilmente il bandolo di una conversazione interessante e non, banalmente, di circostanza. Lei ha con sé un paio di banane striminzite. Me ne offre una nella maniera un po’ brusca, tipicamente indiana. Inizio a sentire una sensazione di pulizia interiore a starle vicino, una sensazione di cui avrei via via assaporato sfumature diverse. La visita inaspettata di quel giorno avrebbe dato la stura a qualche altro timido invito. Uno, appena un giorno prima del mio rientro in Italia. Il frutto stava iniziando ad acquistare un accenno di colore affascinante. Il pensiero di ipotetici sviluppi era ancora azzardato eppure, sottotraccia, qualcosa stava decisamente nascendo. Erano passati più di tre mesi dal primo tè insieme nella luce soffusa del lampadario micragnoso. Io ero stato buona parte del tempo via da Varanasi portando con me l’immagine di Sobala affacciata al parapetto del centro di yoga, i capelli corvini sciolti sulle spalle, seguire con gli occhi la mia figura che si allontanava. Non era la prima volta che lasciavo Varanasi marinando le sue lezioni di yoga. Era successo un paio di volte che avevo fatto brevi puntate a Calcutta ed a Bodhgaya stando via una manciata di giorni. In una di quelle due circostanze lei mi aveva salutato coinvolta e quasi addolorata, dicendomi nell’apertura improvvisa di un sorriso solare: torna presto, mi mancherai!
Era stato dunque quasi straziante separarmi da lei con la prospettiva di non rivederla per circa due mesi e particolarmente emozionante sarebbe stato il rientro. Questo era stato anticipato da una bella telefonata.
In quella circostanza le chiesi se, di ritorno a Varanasi, avessi avuto modo di incontrarla. Aveva difatti in progetto di andare un certo periodo in Francia, per un intensivo di yoga. Io allora ancora non sapevo quanto astratti potessero essere i progetti degli indiani e dunque temevo sul serio di ritornare a Varanasi e non trovarla in città. Lei, tuttavia, mi tranquillizzò prontamente: non mi muovo di qui, non ti preoccupare, vieni, ti aspetto!
Io in realtà tardai diversi giorni. Non è facile muoversi in India. Bisogna prenotare i posti sui treni con molti giorni d’anticipo altrimenti si finisce in poco chiare waiting lists. Finii dunque per rivoluzionare i miei programmi e posticipare il mio arrivo a Varanasi. Ricordo arrivai a notte fonda da Lucknow. Il treno aveva un ritardo di oltre cinque ore, per buona parte delle quali il mio pensiero finiva, di tanto in tanto, per impigliarsi nel viso di Sobala. Non riuscivo ad arginare gli effetti di una strana eccitazione ed un’esplicita brama all’idea di rivederla. Il raziocinio mi aveva detto diverse volte di non fare alcun affidamento sull’idea di una relazione con questa donna. I motivi erano diversi. Il più importante era senz’altro che Sobala era sposata. Il suo matrimonio si era presto rivelato un fallimento. Con il marito vivevano in una condizione che noi definiremmo, in Occidente, di “separati in casa” ma l’India, sappiamo, non è l’Occidente ed il fatto che lei fosse, di fatto, separata, non implicava che questa separazione potesse giovare a me. Il raziocinio mi diceva anche che lei probabilmente non avrebbe mai acconsentito ad una relazione adulterina, pur essendo coinvolta affettivamente con me, che avrei dunque fatto meglio a trovarmi una donna di una cultura più affine, evitando aspettative che non potevano non naufragare in una dolorosa disillusione.
La cosa che mi sorprendeva, a fronte di tutto questo, era la tenacia con cui una mia parte appena più celata continuava ad intuire la possibilità di uno sviluppo affettivo con questa donna. Non sapevo come poteva avere luogo e nemmeno in che modo, sapevo solo che stava accadendo e, in qualche angolo della sua mente, lo sapeva anche Sobala.
Il giorno dopo il mio arrivo, notturno, a Varanasi mi precipito ad aspettarla fuori del centro di yoga. Come spesso accade Sobala è in ritardo. In compenso arrivano un paio di suoi allievi e mi invitano ad aspettarla al chiuso, sui duri materassini. Li seguo. Iniziamo a chiacchierare, racconto loro delle mie esperienze a Rishikesh ed in un ashram himalayano e loro della permanenza a Varanasi, nell’incedere della stagione calda che rende arduo qualunque movimento.
Arriva Sobala, saluta i due allievi e mi guarda un po’ confusa. Ho tagliato i capelli a zero a Rishikesh e lei non ha gli occhiali ma mi riconosce appena dopo una fugace esitazione. Il viso le si illumina e si precipita ad abbracciarmi. Riesce a comunicarmi una gioia lasciata libera di fluire senza alcuna inibizione. Mi stringe poderosamente a sé: sei tornato, ti aspettavo! E mi stringe di nuovo. Mi sento quasi travolto dal suo trasporto. Vorrei mostrarle il mio ma non riesco a viverlo con la stessa libertà. Dopo la classe di yoga ci tratteniamo a chiacchierare. Mi guarda con occhi languidi, assume un’espressione imbronciata da bambina: mi avevi detti che saresti tornato prima. Ero preoccupata! Le spiego le ragioni del mio ritardo ma lei insiste a farmi sentire, in qualche modo, in colpa. Nei giorni seguenti inizio seriamente a pensare di sedurla. Non so bene come fare, so solo che non posso comportarmi come mi comporterei con una donna occidentale. La vado a prendere una sera, nel centro, portando con me due banane striminzite. Restiamo un po’ a chiacchierare nel buio di uno dei tanti black-out varanasini poi finiamo a passeggiare sui ghats sul Gange. Mi porta a vedere qualche tempio a livello dell’acqua, che viene regolarmente sommerso con l’arrivo dei monsoni. Ci sediamo ad assistere all’arati, la celebrazione notturna di offerte alla Madre Ganga. Parliamo un po’ di tutto, di come si vive in Italia ed in India, le nostre conversazioni continuano a non essere banali e a coinvolgerci in maniera appassionata. Continuo a sentire una sensazione di profonda pulizia interiore a starle vicino. Si avvicina il giorno della mia partenza. Un pomeriggio, appena prima di cominciare la mia classe di yoga, le dico che voglio portare qualcosa di suo con me, lasciandole qualcosa di mio. La invito dunque per il giorno dopo, l’ultimo della mia permanenza a Varanasi, a trascorrere un paio d’ore nella mia guest-house.
Lei giunge, come è quasi sua abitudine, con più di mezzora di ritardo. La guest-house è immersa in una penombra struggente. Le mostro, sul mio laptop, le tante foto dei miei itinerari indiani, mantenendo la porta della stanza aperta per non mettere in imbarazzo Sobala e la domestica della guest-house che continua a tenerci sotto tiro. Mi avrebbe detto qualche tempo dopo una persona che vive da tanti anni in India: qui se una donna si intrattiene con un uomo una o due volte può essere considerata una coincidenza poi viene identificata automaticamente come la sua amante!
Ascoltiamo della musica indiana, in particolare alcuni bhajans. Io ho preparato il mio regalo: una croce celtica, comprata nella comunità acquariana di Findhorn Foundation, in Scozia, che ho portato sino a quel momento appesa al collo.
Gliela porgo nella scatola che avevo, fortunatamente, conservato.
“E’ un gran bel regalo questo!” mi dice Sobala senza distogliere lo sguardo dalla croce. “Voglio che tu abbia qualcosa di prezioso di me, qualcosa cui io do valore”, le rispondo. È un momento intenso, il frutto sta accelerando la sua maturazione. Si sono fatte le nove ed è ora, per lei, di andare. Ci vediamo il giorno dopo per l’ultima classe di yoga. Sono nel suo centro con altri due allievi e lei arriva, ancora una volta, in ritardo. Tira fuori dalla sua borsetta un pacchetto semplice, un oggetto avvolto in un fazzoletto colorato. Me lo porge: se non fossi la tua insegnante di yoga ti sposerei, mi dice in maniera quasi sbrigativa. Io mi sento preso un po’ alla sprovvista -ci sono altre due persone-, lei lascia questa frase come sospesa ed inizia a guidare la lezione. Alla fine la invito ancora una volta alla mia guest-house. La scusa è abbastanza buona: ho parlato di lei alla padrona che vorrebbe conoscerla per commissionarle alcune lezioni di yoga per la figlia.
Ci incamminiamo verso la guest-house con uno stato d’animo leggero. Siamo contenti di stare ancora insieme anche se, in fondo, è già forte il dolore per l’imminente separazione. Arrivati alla guest-house qualcosa cambia sul viso di Sobala. Inizia a rabbuiarsi, si muove quasi a fatica, sembrerebbe ammalata. Le presento la padrona. Questa ci invita a sedere e parla in hindi, con Sobala, delle lezioni da dare alla figlia. Sembra stiano trovando un buon accordo. Io, per non essere d’impiccio, recupero una copia del Times of India e mi do’ brevemente alla lettura.
Il loro dialogo non si protrae a lungo e dunque arriva, un po’ in anticipo, il momento del congedo. Con Sobala ci guardiamo smarriti ed un po’ spaventati. Ti accompagno all’uscita, le dico. Scendiamo le scale ed io ho un certo batticuore. Raggiungiamo l’ingresso. Il volto di Sobala è segnato da un dolore profondo che non riesce e forse non vuole celare. Io cerco invece di attaccarmi a qualche astratta prospettiva di reincontro. La abbraccio disinvolto e la bacio tra la guancia ed il collo, su quello che, oggi, è uno dei miei posti preferiti del suo corpo. La guardo negli occhi: spero di vederti a Londra (io avevo in progetto di andarci e a lei sarebbe piaciuto andare a trovare Beata che ci vive da anni). Lei non mi risponde. Si limita a rimettermi le braccia al collo ed a stringermi a sé. È straziata dal distacco pur con il contegno e la grazia che sanno avere le donne indiane. La padrona è poco distante da noi, ci osserva intrusiva. Io mi trovo quasi costretto, anche per l’imbarazzo di essere osservato, ad allontanarla gentilmente. Le dico: ci vediamo presto ma a quel punto la voce mi si strozza ed i suoi occhi sono spalancati in un’espressione quasi di terrore e velati di lacrime. Le do una carezza e mi giro bruscamente, sparendo nella rampa di scale. Salgo con il batticuore, sono confuso, quasi sconvolto. Tornato in Italia continuo a praticare lo yoga e seguo qualche classe con una maestra discretamente brava. Sobala è sempre nei miei pensieri ma in maniera defilata. Cerco di evitare di attaccarmi troppo al suo ricordo e ricamare su irragionevoli possibilità di una relazione per quanto, nel profondo, la desideri ardentemente. Il pacchetto che mi diede quel giorno nel centro di yoga conteneva uno shiva lingam, simbolo per eccellenza della sacralità varanasina. Diventa il centro di un piccolo altare nella mia casa italiana. Un giorno, mentre sto spedendo diverse e-mail, decido di scrivere anche a Sobala. Quasi a volermi togliere un sasso da una scarpa le scrivo provocatoriamente: sto continuando a praticare lo yoga. Ora ho una nuova maestra dunque, se vuoi, ci possiamo sposare!
L’e-mail non riceve risposta per oltre un mese ed io non mi meraviglio. Mi preparo per incontrare la mia ex compagna a Christiania. Ho aspettato a lungo questo momento, vivendo il viaggio in India come un’esperienza di maturazione per tentare, nuovamente, di riassestare il rapporto. Lei, nel frattempo, ha vissuto alcuni mesi in Scandinavia, ha avuto una relazione con un uomo del nord, naufragata miseramente dandole, a sua volta, un’opportunità di maturare. Ci sarebbero dunque buone speranze ma, a Christiania, il nostro rapporto subisce il colpo di grazia, venendo chiaramente a galla la nostra definitiva incompatibilità. Un cristianita mi lascia a disposizione la sua casa per alcuni giorni ed è lì che mi ritrovo con la testa tra le mani a vivere il profondo dolore, la profonda frustrazione della disillusione. Questo nuovo incontro ha avuto una lunga gestazione e speravo davvero avesse un esito diverso. Mi trovo a dover affrontare la dura realtà di una fine irreversibile. Mi attacco tenacemente allo yoga: un’ora di sequenza di asana, la mattina ed un’ora di pratica alla Scandinavian School of Yoga and Meditation di Copenaghen il pomeriggio. Lo yoga mi aiuta a tenere testa alla frustrazione e dà un ritmo alle mie giornate. Mi tiene anche in contatto mentale con Sobala ed il suo pensiero mi rievoca quella sensazione di pulizia interiore che provavo quando eravamo vicini. Giunge il momento che mi balena luminoso il pensiero: perché non chiamarla? Cerco nel portafoglio il suo numero di telefono. L’ho perso. “Va bene, come non detto”, penso tra me. Per scrupolo le scrivo un’e-mail. Le dico che sono a Copenaghen, che mi piacerebbe telefonarle ma ho perso il suo numero di cellulare e che dunque vorrei riaverlo. Dispero di avere una qualunque risposta ma mi sto sbagliando. Il giorno dopo trovo il suo nome tra le e-mail in arrivo. La cosa mi provoca uno strano sussulto, associato alla sensazione sottile del suo odore. Leggo l’e-mail. È scritta in un inglese slangato, sgarrupato, senza rispetto per la punteggiatura. È un campo di battaglia! Mi dice, ripetendosi, che ha controllato le e-mail quello stesso giorno, che avrebbe dovuto rispondermi prima (alludendo evidentemente alla e-mail provocatoria, vecchia di oltre un mese oramai) ma che io dovevo immaginarmi che lei odia il computer e che dunque ha trascurato per molto tempo di vedere chi le aveva scritto. A quel punto il tono dell’e-mail cambia repentinamente. Mi scrive all’improvviso: ti piaccio davvero? Davvero mi accetterai? Stavi scherzando o parlavi sul serio? Mi manchi molto. Il mio numero di cellulare è …
Io sono come interdetto. Sto provando una profonda gioia e, al contempo, sono del tutto confuso.
Le rispondo con una lunga e-mail e, il giorno dopo, provo a telefonarle. La comunicazione è disturbata e lei non riesce a smettere di ridere. Cade la linea. Provo a spedirle un messaggio che riceve una pronta risposta. La mattina dopo, presto, alle 5 o alle 6 arriva il suo primo messaggio intercontinentale: good morning, Manuel!
Il mio stato d’animo, nel frattempo, è cambiato. Si dilegua il dolore per la fine irreversibile del rapporto con la mia precedente compagna. Sento che sta accadendo ciò che era chiaro dovesse accadere: Sobala sta entrando nella mia vita. Non mi preoccupo del suo matrimonio, di come riuscirò ad evitare conseguenze spiacevoli quando sarò nuovamente a Varanasi. Con il passare dei giorni, delle settimane e di qualche mese sono contento di vedere crescere, a passi piccoli ed un po’ incerti, questa nuova creatura -la nostra relazione, in una fase ancora “virtuale”- e di sentire come, nel frattempo, mi sto gradualmente trasformando. Mi sento protagonista di una lenta ma evidente metamorfosi, sull’onda di quella sensazione di pulizia interiore che provavo al suo fianco. È come se da bruco stessi lentamente diventando una farfalla. So che la trasformazione si sostanzierà di molti stadi in cui non sarò né l’uno né l’altro, dunque di molte ibridazioni ma sento subito che una mano invisibile guida gentilmente i miei passi, in barba ad ogni possibile razionalizzazione.
Da Christiania mi sposto presto a Londra dove mi ritrovo a fantasticare sullo sviluppo del nostro rapporto tirando aromatiche boccate di pipa su un ponte sul Tamigi. Da Londra torno in Italia. Inizio a telefonare a Sobala con una certa regolarità ma riusciamo a comunicare più liberamente con i messaggi sul cellulare. Si avvicina l’autunno, dunque il momento in cui avevo previsto di ritornare a Varanasi. Poco prima di partire le mando un messaggio: non ti dico il giorno esatto in cui arrivo, voglio farti una sorpresa. Vengo a prenderti con ali di farfalla, aspettami fiduciosa!

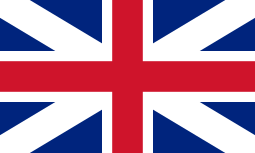 English
English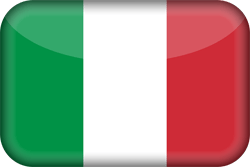 Italian
Italian