Un assaggio di Buddhismo Theravada; intervista a Louis Gabaude

Louis Gabaude è uno dei più accreditati studiosi di Buddhismo Theravada. È stato docente all’università di Chiang Mai ed ha fatto molta ricerca sul campo lavorando per l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO), in Tailandia.
In pensione dal 2007, vive tuttora a Chiang Mai, nel nord della Tailandia.
Potete leggere la sua intervista anche in inglese ed in francese.
Caro Louis, possiamo cortesemente iniziare con una sua rapida presentazione?
Sono nato al sud della Francia centrale. I miei nonni avevano una piccola fattorie sulle colline. Mio padre, nato nel 1900, iniziò a lavorare come scalpellino nel 1914. A 20 anni venne mandato in Germania come membro delle “forze di occupazione” dopo la Prima Guerra Mondiale. Al suo rientro in patria, ha avviato la propria piccola impresa che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, impiegava circa 20 lavoratori. Malgrado avesse avuto solo una scolarizzazione di tipo primario, divenne il sindaco del nostro comune, ha creato un’associazione per la protezione della regione ed ha avuto un riconoscimento accademico. I miei genitori hanno avuto 5 figli.
Nato nel 1942, ero il più giovane e, coccolato da tutti, ho avuto una buona infanzia, nella cornice di un bel contesto naturale. Sono cresciuto dopo la guerra e mi sono potuto permettere una formazione più completa di quella consentita, dalle circostanze economico-sociali, a mio padre.
Del resto, devo riconoscere che non fossi del tutto preparato per l’età adulta perché la mia infanzia è stata, si può dire, troppo facile.
La vita, tuttavia, non si piega alle mollezze dei bambini viziati. Oggi posso dire che la mia vita sia stata fortemente determinata da una frase che mio padre amava ripetere: “A 20 anni è bene che un uomo lasci il suo paese natio”. I miei 3 fratelli maggiori erano tutti andati all’estero, a 20 anni…per il loro servizio militare, come del resto aveva fatto mio padre. Ho compiuto 20 anni nel 1962, alla fine della Guerra d’Algeria. Sono stato volontario nella versione francese dei Peace Corps, appena creata dal Generale de Gaulle, su ispirazione di Kennedy. Sono stato mandato in Laos all’età di 22 anni, nel 1964. A quel tempo ero reduce dagli studi di filosofia e religione. Sono stato in Laos fino al ’66, a Pakxan per la precisione, una piccola città sul fiume Mekong, 150 chilometri ad est di Vientiane. Insegnavo francese in una scuola secondaria, per quanto credo sia maggiormente ricordato dai miei vecchi studenti come un insegnante di chitarra! Nel corso del mio soggiorno in Laos, gli Stati Uniti iniziarono a bombardare il paese assieme al Vietnam del nord con i risultati che conosciamo. Potevamo sentire il rombo degli aerei verso il nord, potevamo “annusare la guerra”; era molto vicina. I combattimenti non mi coinvolgevano direttamente ma, una volta, una battaglia si svolse ad appena 25 chilometri di distanza. Ci furono delle vittime, tanto fra le forze governative quanto fra i membri della guerriglia, comunista, laotiana. Due giornalisti francesi, de Le Figaro, un giornale di centro-destra, scrissero un articolo sulla battaglia. Riportarono la morte di dieci soldati governativi, dieci guerriglieri, comunisti laotiani e cinque soldati vietnamiti. A Parigi, tuttavia, si scrisse solo dei soldati governativi e dei miliziani. Non era, difatti, politically correct menzionare i soldati vietnamiti che combattevano al fianco dei comunisti laotiani e dunque non poteva venire menzionato nemmeno in un giornale sbilanciato a destra. Questo episodio mi insegnò la relatività della “verità pubblica”.
Un’altra volta stavamo facendo del trekking verso un villaggio Hmong di montagna. Il villaggio era stato bombardato dalle forze governative poche settimane prima. C’era un piccolo gruppo di guerriglieri comunisti insediato poco distante ed i militari conclusero che anche gli abitanti del villaggio fossero comunisti, dunque bombardarono senza farsi troppi scrupoli. Quando il Governo realizzò che avevano commesso un errore, decise — o forse questa decisione venne presa dagli Stati Uniti dietro lo stesso governo — di finanziare la ricostruzione delle case. Ho potuto realizzare, in questo secondo caso, quanto la guerra possa rivelarsi crudele per le persone semplici, regolarmente vittime di qualcosa che è del tutto al di fuori della loro portata.
Com’è nato il suo interesse per il Buddhismo Theravada?
A Pakxan ho iniziato a sviluppare una certa curiosità in merito al Buddhismo. La ragione era semplice: a quel tempo stavo imparando la lingua Lao. Nei weekends prendevo la mia macchina fotografica e andavo a zonzo per la città. Notai presto che le persone che erano maggiormente disponibili a parlare con me, in Lao, erano i monaci buddhisti perché erano liberi ed a proprio agio con gli stranieri. Infatti, anche ai nostri giorni, se si va in aree non turistiche e si tenta di parlare con la gente, le persone comuni non fanno alcuno sforzo per farsi capire, pensando di non essere in grado di avere una conversazione soddisfacente. I monaci, invece, non erano così timidi ed erano, anzi, desiderosi di migliorare le proprie competenze e di condividere le loro conoscenze. Parlando con loro ho iniziato ad interessarmi anche al Buddhismo. Ho letto al riguardo e, quando sono ritornato in Francia, ho seguito dei corsi specifici ed altri di storia e cultura del sud-est asiatico. Ho studiato a Parigi, alla École Pratique des Hautes Études che forma gli studenti in vista della ricerca sul campo.
Sono arrivato in Tailandia nel 1970, ho studiato la lingua Thai per poi ritornare in Laos ed insegnare in una missione cattolica. Mi sono sposato nel 1973 e mi sono sistemato a Bangkok. Ho iniziato ad insegnare presso l’Alliance Française e, nel 1974, presso l’Università di Chiang Mai. Nel 1975 mi sono diplomato presso l’École Pratique des Hautes Études con uno studio sui rituali buddhisti con gli stupa di sabbia. Forse lei saprà che nel corso del capodanno che si celebra, in Aprile, nel sud-est asiatico (conosciuto in Tailandia come Songkran) vengono costruiti ed offerti stupa di sabbia. Ho selezionato, tradotto e pubblicato testi scritti in Lao, Lanna, Thai e Khmer in cui venivano spiegate le ragioni materiali e spirituali per cui questi stupa di sabbia venivano costruiti. Nel 1979 ho terminato la mia tesi su Bikkhu Buddhadasa (1906-1993) e, nel 1980, ho acquisito una posizione di ricerca presso l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO). Detta istituzione è stata creata nel 1900 per creare le condizioni affinché i ricercatori potessero vivere, a fondo, le loro “esperienze sul campo”. A quel tempo la maggior parte dei ricercatori dell’EFEO vivevano in Asia mentre ora vi risiede solo la metà di loro. Io sono rimasto a Chiang Mai tutto il tempo.
 Gli stupa di sabbia possono essere, pur lontanamente, ricondotti ai mandala di sabbia che vengono realizzati in Tibet?
Gli stupa di sabbia possono essere, pur lontanamente, ricondotti ai mandala di sabbia che vengono realizzati in Tibet?
Non proprio. Vicino al confine con la Cambogia o nella stessa Cambogia, vengono realizzati degli stupa di sabbia che riproducono gli schemi di Angkor, luogo non di rado interpretato come una sorta di “mandala”.
Tuttavia va specificato che il mandala tibetano è stato imposto, dagli occidentali, come cliché nel sud-est asiatico ed è stato spesso utilizzato senza tenere nel dovuto conto quello che le persone pensano o conoscono.
Si legano al concetto di impermanenza?
Sì. La sabbia scorre fra le dita come i sentimenti tra le pieghe del tempo. I testi che ho tradotto e scritto, al riguardo, si chiamano anisong, da un termine Pāli/Sanscrito che significa: merito. La maggior parte di questi testi ha due strati. Il primo cita antichi detti ripresi dal cosiddetto Canone Buddhista (il Tripitaka) o da antichi commentari, il secondo spiega le ragioni spirituali e pratiche legate all’offerta degli stupa. Il primo strato spiega come, in una vita precedente, il Buddha fosse un pover’uomo, incapace di offrire un solido stupa al Buddha del suo tempo, potendo solo costruire uno stupa di sabbia. Lo offrì al Buddha e, per tale ragione, nacque, nella vita successiva, in una famiglia molto facoltosa per poi diventare, rinunciando a tutti i suoi privilegi, il Buddha ultimo. L’obiettivo di questi testi è incoraggiare le persone ad offrire questo genere di stupa per ottenere quel che nel Cattolicesimo chiamiamo “indulgenze” e, nel caso in oggetto, “meriti”.
Ha fatto ricerca sulle culture pre-buddhiste del sud-est asiatico?
Non posso dire di avere alcuna expertise al riguardo ma ho letto molto sull’argomento. Non si può studiare il Buddhismo contemporaneo ignorando quanto accade nell’ambito del rapporto che le popolazioni del sud-est asiatico hanno con gli spiriti o le reminiscenze brahmaniche o come le si voglia chiamare. Noi, occidentali, dobbiamo essere cauti quando ci occupiamo di certi argomenti. La nostra psicologia resta cristiana e pensiamo che la religione sia qualcosa di nettamente definito: se sei cristiano non sei hindu o musulmano, se sei cattolico, non sei protestante, eccetera. Noi abbiamo a riferimento categorie molto schematiche, congelate direi.
La domanda che viene frequentemente da occidentali in visita in Tailandia, di fronte a divinità induiste in templi buddhisti è: Questa gente è induista o buddhista? Tuttavia il problema non è lì. Buddha ed i primi buddhisti vivevano in un contesto culturale indiano. Avevano una visione molto “inclusiva” della vita e del mondo, in una prospettiva per cui oggi sei nato come uomo e domani potresti rinascere come un verme, come un cane o una divinità. I cicli delle vite e le retribuzioni karmiche comprendono tutte le modalità di essere. Dunque se ci sono divinità induiste in un tempio buddhista, questo non significa che i devoti di quel tempio si percepiscano come hindu. Piuttosto che tali divinità hindu rappresentino una possibilità di essere per coloro che se lo siano meritato.
Come sono considerate tali divinità? Come spiriti particolarmente evoluti o cosa?
Consideri la radice della parola thai “thewa”, derivata dal sanscrito “deva” e dall’indoeuropeo dev e legata al concetto di “luce”, lo stesso che troviamo nel greco θεός, nel latino deus ed in tutte le lingue neolatine, in svariate forme. Tuttavia c’è una grande differenza tra il “deva” buddhista che emerge dalla giungla tropicale ed il “Deus” creato in un deserto arido sotto un cielo stellato. Nel Buddhismo, i deva non sono “transcendenti” rispetto a questo mondo ma sono parte della ruota, condizionata, dell’esistenza, il samsara, senza corrispondenza con il concetto di Deus/Dio (con la D maiuscola) o con Allah. Nel Buddhismo possiamo parlare di “deva” con la d minuscola, partecipanti alla realtà condizionata. Sono dunque, in termini cristiani, “contingenti”, sottoposti alla legge di causa-effetto mentre Dio o Allah sono, per definizione, considerati come entità trascendenti ed inconoscibili oltre che onnipotenti.
I deva possono dunque essere maggiormente ascritti ad una dimensione metafisica più che teologica?
Se vogliamo metterla in questi termini sì, per quanto sarebbe utile una discussione in merito a quanto si intenda con i concetti di “metafisico” e di “teologico”. Ancora, è importante sottolineare che stiamo parlando di deva con la “d” minuscola ragion per cui, per esempio, quando i primi missionari vennero qui [l’intervista ha avuto luogo a Chiang Mai, in Tailandia] e parlarono di Dio e del paradiso, i monaci buddhisti non riuscivano a cogliere queste nozioni nel loro senso “trascendente”. Ad orecchie buddhiste, il discorso cristiano non ineriva qualcosa di definitivo, oltre l’universo condizionato ma, semplicemente, una divinità ed un paradiso pienamente sottoposti alla legge di causa ed effetto.
Il suo interesse per il Buddhismo Theravada è solo di natura intellettuale o ne segue anche le dottrine e le pratiche?
Non voglio dire: “sono cristiano” oppure “sono buddhista”. Cristiano o buddhista in che senso? Fondamentalmente sono probabilmente cristiano ed anche cattolico se nessuno mi chiede di sottoscrivere ogni articolo, cattolico, di fede. Penso che strutturalmente, come tutti gli europei, io sia cristiano e sono piuttosto sicuro che tutto quanto ci sia di meglio, in me, venga dalla cristianità. Non sto parlando di dogmi o di riti, piuttosto di quanto è, per me, essenziale della cristianità: “colui che non ama il fratello che gli sta davanti, non può amare Dio che non può vedere!”. Di conseguenza, non ho avuto il rifiuto della cristianità vissuto da molte persone, in Europa, perché ritengo che queste ignorino la propria storia culturale e chi esse siano, da dove provengano o cosa sarebbero se la cristianità non avesse plasmato l’Europa. Tuttavia, ritengo certamente di essere influenzato dal Buddhismo e sono diventato una sorta di “ibrido culturale”! Questo, del resto, non mi sorprende.
Mio padre era cattolico ma era anche interessato alla filosofia pagana, specialmente alla sua componente stoica che prosperò da Benares a Roma. Aveva letto Marco Aurelio, Epitteto ed aveva dimestichezza con il concetto — o, piuttosto, con l’osservazione — che ci sono due categorie di cose ed eventi in questo mondo: quelle che puoi cambiare e quelle che non puoi cambiare e che, considerando la seconda categoria, è vano soffrire per tutto quello che ricade sotto la sua giurisdizione. Tutti sanno che un giorno moriremo, dunque perché soffrire in anticipo per questo? Perché aggiungere sofferenza mentale alla sofferenza fisica? Non è stupido? Non è forse meglio accettare l’ineluttabilità della morte e godersi il presente? Mio padre non trovava contraddizioni tra una prospettiva religiosa cristiana ed una pagana. Si muovono solo ad un diverso livello. Allo stesso modo, il Buddhismo mi ha insegnato che ci sono molte cose, nella vita, che vanno semplicemente accettate e che bisogna iniziare a pensare all’essenza della vita per quella che è. Quello che i monaci insegnano alla gente è molto più semplice di quello che un prete di parrocchia insegna ai bambini: nascete, diventate anziani, soffrite e poi morite. Punto e basta. Questa è la prima e, per certi versi, ultima lezione del catechismo buddhista.
Tutti gli altri discorsi emergono naturalmente dalla mera considerazione di cui sopra. Di converso, la prima lezione che ho ricevuto nel corso del catechismo cristiano è stata: “Dio è puro spirito e ci ha creato a sua immagina per servirlo ed onorarlo”. Questa è una filosofia dogmatica, imposta, artificiale, metafisica e completamente estranea alla vita umana quotidiana, per non dire alla vita quotidiana di un bambino. Dunque, in questo senso, è vero che sono stato sedotto dalla base pratica del Buddhismo che è. essenzialmente, “esistenzialista”.
Naturalmente non ho intrapreso o ostentato alcuna “conversione sociale”. Le persone si definiscono “buddhiste”, “cristiane” o “musulmane” perché hanno bisogno di una “identità sociale”. Poi pretendono di parlare, francamente in una maniera che trovo un po’ ridicola, della loro “identità spirituale”. Se si accetta che le “religioni” sono vie per raggiungere la “perfezione” e se si pensa che la perfezione è qualcosa che non può essere mai raggiunto ma solo un obiettivo da perseguire costantemente, allora il fatto che ci si definisca buddhisti, cristiani o musulmani implica il sentirsi soddisfatti di aver acquisito il rispettivo modo di essere, il che è pura illusione! Funziona perché è una semplice autogratificazione, nella misura in cui si crede a pochi dogmi e si osservano poche regole. Del resto, basta guardare cosa è stato fatto, storicamente, nel nome di Buddha, di Dio o di Allah.
Guardiamo quanto spesso si cada nel tentativo di percorrere il sentiero dei propri ideali. Dunque, definirsi come buddhisti, cristiani o musulmani è un modo di cadere nella trappola, nell’illusione, nell’aberrazione di un’acquisita “perfezione”. Salvo che, naturalmente, si sia consapevoli — come nel caso dei veri monaci buddhisti — che osservare le regole sia un “allenamento” [per qualcosa non ancora raggiunto] o — come nel caso degli “autentici” monaci cristiani — che la conversione avvenga giorno dopo giorno [nella direzione di una perfezione perennemente incompiuta].
Non va del resto trascurato il caso delle istituzioni. È nella natura degli ideali religiosi istituzionalizzarsi e, di conseguenza, fossilizzarsi perché, prima o poi, le persone tendono a lavorare più per il bene delle istituzioni che per i loro ideali. Questo, del resto, è comune a tutti i progetti umani e non possiamo farci nulla: le istituzioni sono necessarie per la sopravvivenza di una religione e, allo stesso tempo, determinano sclerosi e decadenza.
Che genere di differenze ha notato tra il Buddhismo Theravada seguito in Laos e quello seguito in Tailandia?
La religione nel Laos comunista è una questione complicata. Per dirla in maniera grossolana, in principio, quando i comunisti presero il potere nel 1975, l’élite del partito aveva, naturalmente, una forte fede nella loro teoria marxista/leninista. Per loro la religione era l’oppio dei popoli e, di conseguenza, qualcosa da sopprimere. Tuttavia, erano abbastanza scaltri e realisti da promuovere pensatori che teorizzassero che, fino a quel momento, i “capitalisti” avevano sfruttato il Buddhismo ma che questo potesse essere interpretato in un modo che fosse favorevole alle classi oppresse. Allo stesso tempo erano del tutto scettici circa le potenzialità del Buddhismo di sanare, alle radici, problemi sociali, diversamente dal comunismo dei loro sogni che, naturalmente, avrebbe risolto ogni cosa. Nei 10 anni seguenti il loro insediamento alla guida del paese, si resero conto che il loro esperimento comunista si stava rivelando un fallimento, ragion per cui si sono trovati nella condizione di dover aprire il loro sistema economico mantenendo relativamente blindato quello politico ed oggi il Laos è una sorta di “economia capitalista di stato”, al pari di Cina e Vietnam.
Un’altra cosa che scoprirono fu che, con la fine della monarchia, non c’era nulla che fungesse da collante per il paese, nella misura in cui il comunismo era troppo nuovo e superficiale per costituire uno strumento di “ridefinizione delle coscienze”. Dunque, ironicamente, realizzarono che il Buddhismo poteva essere un buon mezzo per amalgamare e motivare le persone. Forse una sorta di oppio da utilizzare come antidoto per un altro oppio?
L’identificazione delle persone con la monarchia, in Laos, era altrettanto forte che in Tailandia?
No, in Tailandia, sino ad oggi, la monarchia è stata molto più forte perché l’unificazione del paese è stata più lunga e piuttosto efficente. Una delle più importanti differenze tra Laos e Tailandia è che, dal diciannovesimo secolo, Laos, Cambogia e Vietnam sono stati, in modi diversi, amministrati dai francesi. Questi non erano interessati alla dottrina o alla disciplina buddhiste. L’unica cosa che li riguardava direttamente era che i monaci non fossero coinvolti in nessuna forma di irredentismo politico.
In Siam, di converso, i re sono sempre stati coinvolti, in prima persona, con il Buddhismo. Il caso più clamoroso è stato quello del Re Rama IV o Mongkut che è stato un monaco — ed un riformista — per circa 30 anni prima di diventare Re. Non poteva dunque comportarsi come un distante amministratore francese. In Tailandia, tanto il Re quanto il Governo debbono controllare in che maniera il Buddhismo è studiato, praticato e gestito. In Laos, prima dei comunisti e dopo il periodo francese, il governo non interveniva se i monaci buddhisti non erano contro di esso. Tuttavia, tanto i comunisti laotiani quanto i governatori thai hanno sempre cercato (anche se in modi diversi e con intenti diversi, naturalmente) un maggior coinvolgimento con il sangha, ovvero le comunità monastiche dei loro, rispettivi, paesi.
La regola di trascorrere un periodo in monastero, in Tailandia, non è obbligatoria per tutti i Re?
Sì, è tradizione che tutti i maschi vivere un’esperienza monastica per un breve periodo di tempo, per essere poi maturi per consumare il matrimonio o, nel caso di un principe, per regnare. Rama IV, con il suo periodo monacale insolitamente lungo, ha rappresentato un’eccezione. In virtù del fatto che il Re è buddhista — secondo l’attuale Costituzione il Re deve essere buddhista — e in quanto protettore della religione (prima di tutto protettore del Buddhismo), se ritiene che i monaci non si comportino correttamente è tenuto ad intervenire. Come dicevo, in Indocina i francesi non erano interessati agli aspetti interni del Buddhismo ma, nei paesi di tradizione Theravada, i Re hanno sempre controllato il comportamento dei monaci. A partire da Ashoka in India, hanno sconsacrato decine, centinaia di monaci perché (o con il pretesto che) non rispettavano gli insegnamenti e le regole del Buddha. In poche parole nei paesi di cui si diceva sembra che la religione sia una cosa troppo seria per essere lasciata esclusivamente nelle mani dei monaci!
 È risaputo che la Tailandia, prima di essere un paese buddhista, è stato a lungo influenzato dall’Induismo. Ci può cortesemente spiegare come il Buddhismo è penetrato nel paese?
È risaputo che la Tailandia, prima di essere un paese buddhista, è stato a lungo influenzato dall’Induismo. Ci può cortesemente spiegare come il Buddhismo è penetrato nel paese?
Sino ad oggi temo non sia stato possibile stabilire, con certezza, il periodo di penetrazione del Buddhismo nel territorio dell’attuale Tailandia.
In particolare bisognerebbe innanzitutto chiarirsi in merito al genere di Buddhismo cui ci si sta riferendo. I buddhisti thai contemporanei, che citano le loro antiche cronache, sono convinti che il Buddhismo giunse nel paese durante il regno dell’imperatore indiano Ashoka che morì 232 anni prima dell’era cristiana. Missionari inviati dall’imperatore nei territori dell’attuale regno thai –conosciuto anticamente come Suvarnabhumi – avrebbero introdotto il Buddhismo soprattutto a partire dall’area di Nakhon Pathom, poco distante da Bangkok, dove è ancora possibile visitare il Phra Prathon Chedi: lo stupa più antico della Tailandia. Allo stesso tempo, se cerchiamo prove concrete, confermate dagli archeologi, della presenza del Buddhismo Theravada nella valle del Chao Phraya, dobbiamo aspettare fino ad un periodo compreso tra il sesto e l’ottavo secolo per trovare iscrizioni in lingua Pali che provino, oltre ogni ragionevole dubbio, che la tradizione Theravada era attiva a quel tempo. Tuttavia, non possiamo conoscere una precisa data ed un preciso luogo di origine – che sia l’India o lo Sri Lanka – di questa tradizione «iniziale». Solo il Buddhismo Theravada per come lo conosciamo, oggi, qui in Tailandia, può essere ricondotto ad un’origine singalese risalente al tredicesimo secolo.
In epoca pre-buddhista, i governanti esercitavano il loro potere nell’ambito di una visione hindu del mondo, almeno nei centri principali. Anche oggi, accanto al Re buddhista, trovano posto alcuno bramini. Senza di loro non è possibile consacrare un Re thai a Bangkok. I bramini esercitano alcune funzioni rituali per il mantenimento della monarchia. A chi mi dovesse chiedere se un contadino, in un villaggio remoto, vive sotto l’influenza dell’Induismo o del Bramanismo, risponderei di no. Nei villaggi la gente crede negli spiriti locali. Quando la “religione” diventa sofisticata e sviluppa un apparato “intellettuale”, devono essere stabilite alcune sistematiche gerarchie di potere. Gli spiriti (phi) vengono “promossi” a deva, yakkhas, eccetera ed acquisiscono un posto nell’immaginario buddhista e bramanico e nella dimensione delle retribuzioni karmiche.
Possiamo dunque dire che le influenze bramaniche siano ad un livello maggiormente elitario?
Quando sono sistematizzate, sì. Bisogna appartenere all’élite alfabetizzata per conoscere i testi, i rituali, i nomi, le storie delle divinità, eccetera. Se si porta un uomo o una donna thai in una cattedrale, in Occidente, possono offrire una candela senza alcun problema perché per loro è un modo di esprimere un’attitudine devozionale a fronte di qualcosa di misterioso che può essere percepito e chiamato diversamente, a seconda dei luoghi. Dunque non connoteranno un atto del genere come specificamente “cattolico” ed alieno dal loro universo “buddhista”.
Parlando della Tailandia alcune persone usano il termine sincretismo, coinvolgendo, implicitamente, un mix di divinità hindu, di culto degli spiriti e di credenze buddhiste. Se intendiamo descrivere pratiche comuni, non penso sia corretto usare il termine sincretismo perché suppone che ci siano sistemi vicini che si contaminino a vicenda. Il gioco non è vissuto a questo modo qui. Si ricordi quel che dicevamo a proposito di spiriti e di deva.
Tutti gli esseri viventi sono riciclati nello stesso sistema, nello stesso cerchio della vita, con tutte le contingenze di un mondo condizionato, radicalmente alieno dall’incondizionato: il Nirvana. Penso che lo stesso termine “sincretismo” sia il risultato di una prospettiva cristiana, il prodotto di una mente occidentale, condizionata dalla concezione esclusivista cristiana della “religione” o della fede.
Nei primi secoli, la cristianità si è definita come un sistema di credenze esclusive imperniate su dogmi non riconoscendo i quali non si può essere considerati cristiani.
Nel caso dell’Asia, possiamo accademicamente tollerare il termine “sincretismo” dal punto di vista dell’osservatore che conosce i diversi sistemi e li considera intrinsecamente differenti ma dal punto di vista delle persone che credono e vivono in questi sistemi lo stesso termine è, a mio parere, non corretto.
È corretto, a suo parere, coinvolgere in questo genere di analisi anche l’aspetto psicologico? In altre parole, è corretto pensare che la gente, in Asia, oltre ad avere una diversa cultura ha anche una diversa psicologia?
Gli uomini hanno una naturale tendenza ad identificare la realtà con l’idea che hanno di essa. Nel sud-est asiatico, la maggior parte delle persone non vanno molto oltre la teoria del karma, secondo cui nulla accade a caso ma per cause, talora del tutto personali che si concatenano ad effetti disparati nel corso di innumerevoli vite.
Il popolo lascia spesso le spiegazioni sofisticate ai monaci, facendo del proprio meglio per vivere una vita decente senza essere troppo gravati dai problemi essenziali dell’esistenza. Dunque, lungi dal teorizzare, razionalizzare e sistematizzare, reagiscono, giorno per giorno, alle diverse circostanze ed interpretano gli eventi come frutti del proprio karma. Questa teoria “totalizzante” può essere ciò che differenzia le persone “indianizzate” dagli occidentali, a livello psicologico: noi [occidentali] cerchiamo cause esterne ai nostri problemi mentre loro sanno che le loro azioni sono alla base di quello che è accaduto ed accade loro. La ragione dei loro fallimenti o dei loro successi può essere definita “interna”, nella misura in cui si correla alle loro azioni passate o recenti. In Occidente, come si diceva, tendiamo sempre ad individuare cause esterne, come se non fossimo mai responsabili di nulla: ieri era il diavolo, più di recente il capitalismo o il comunismo, un gruppo etnico o una nazione, domani sarà qualche nuovo demone, sempre al di fuori di noi o del nostro gruppo sociale. Per noi la teoria del karma è datata e cerchiamo altre spiegazioni ugualmente totalizzanti. Anche attraverso i nostri lavori accademici sistematizziamo tutto e cerchiamo gli stessi fattori operativi dappertutto: la “struttura”, la “lotta di classe”, il “potere”, il “sesso”, il “capitale” o qualunque altra cosa così che, alla fine, la realtà deve ben inserirsi nella cornice che abbiamo precedentemente predisposto per lei. L’incidenza di queste spiegazioni totalizzanti — che siano “interne” o “esterne”— sulla psicologia delle persone apre, naturalmente, la strada ad ulteriori discussioni. Non possiamo del resto trascurare di dire che non si possa parlare di Asia come una sorta di monolite. L’India e la Cina sono molto diverse tra di loro ed il sud-est asiatico ha preso da entrambe. Questo non può non portare alla coesistenza di diverse psicologie nello stesso paese.
 Possiamo spendere qualche parola su grandi monaci thai come Buddhadasa Bhikkhu ed Achan Cha? Sono quelli maggiormente conosciuti in Occidente. Oltre a loro possiamo forse menzionarne altri, meno conosciuti ma ugualmente validi?
Possiamo spendere qualche parola su grandi monaci thai come Buddhadasa Bhikkhu ed Achan Cha? Sono quelli maggiormente conosciuti in Occidente. Oltre a loro possiamo forse menzionarne altri, meno conosciuti ma ugualmente validi?
Iniziamo con Buddhadasa Bhikkhu (nella foto).
Molte persone hanno parlato di lui, io stesso l’ho fatto. Ho iniziato ad essere interessato alla sua figura perché ha sfidato lo stereotipo del monaco thai. Era un monaco “creativo” che ha tentato di rendere il Buddhismo appetibile per la classe media del suo tempo. Il concetto di rinascita, ad esempio, poteva apparire infantile e poco credibile, così lui lo spiegò come fosse una rinascita psicologica, presentandolo alla stregua di una metafora. Venne dunque accusato di negare la teoria della rinascita fisica e del karma ma lui si difese spiegando che non la rifiutava in sé e per sé ma, semplicemente, la considerava inutile per la vita di tutti i giorni. La gente, sosteneva, aveva bisogno di un Buddhismo utile qui ed ora. Era dunque un uomo del mondo moderno che tentava di reinterpretare la sua tradizione in un modo che potesse essere accettato dai suoi contemporanei. Ha provato a fare questo tornando alle origini del Buddhismo, quando non era ancora troppo istituzionalizzato, quando la sola istituzione era il sangha appena formato.
 Achan Cha (1918-1992; nella foto), discepolo di Achan Man (1870-1948), ha avuto un approccio simile ed un’analoga attenzione alle origini del Buddhismo: Buddha lasciò il palazzo reale, iniziò a riflettere sulla condizione umana, mostrando cosa potesse essere fatto per essere felici nel mondo per quello che è. Sappiamo che ha identificato la soluzione alla tragedia della vita umana nel rigoroso contenimento dei desideri — veicoli di infelicità — e che il modo più radicale per conseguire quel genere di obiettivo fosse diventare monaco, consacrando il proprio tempo ad osservare cosa accade, nella mente, momento per momento.
Achan Cha (1918-1992; nella foto), discepolo di Achan Man (1870-1948), ha avuto un approccio simile ed un’analoga attenzione alle origini del Buddhismo: Buddha lasciò il palazzo reale, iniziò a riflettere sulla condizione umana, mostrando cosa potesse essere fatto per essere felici nel mondo per quello che è. Sappiamo che ha identificato la soluzione alla tragedia della vita umana nel rigoroso contenimento dei desideri — veicoli di infelicità — e che il modo più radicale per conseguire quel genere di obiettivo fosse diventare monaco, consacrando il proprio tempo ad osservare cosa accade, nella mente, momento per momento.
Tanto Buddhadasa quanto Cha caldeggiavano il bisogno di ritorno alle origini. La differenza è che Buddhadasa parlava ad una classe media colta ed agiata mentre Cha si limitò a creare una comunità di monaci che seguiva una stretta disciplina ed una costante pratica meditativa.
Quest’ultimo utilizzava un linguaggio più tradizionale mentre Buddhadasa cercava di comunicare in maniera più moderna, usando spesso termini inglesi.
Cosa mi può dire del Socialismo Dharmico di Buddhadasa?
Buddhadasa è stato accusato di essere comunista ma il suo comunismo non aveva nulla di reale. L’accusa nasceva soprattutto dal fatto che pensava e diceva che i governi anticomunisti fossero “immorali”.
“Come potete bombardare il Vietnam del nord in nome della moralità?”, chiedeva ai rappresentanti degli Stati Uniti. Una seconda e più sottile ragione era che la sua apparente negazione della rinascita fisica fosse una negazione, implicita, del modello gerarchico e “karmico” della società in cui viveva. Tuttavia, egli non aveva alcuna fede nel comunismo e nei regimi comunisti, considerandoli, a loro volta, “immorali” o “non-dharmici”. Buddhadasa spiegava perché le persone si rivolgessero al comunismo ma non pensava assolutamente che il comunismo potesse essere la vera risposta. Alla fine, diceva, il comunismo apparirà come un’increspatura minore sulla sabbia che le onde della storia cancelleranno presto. La storia ha iniziato a confermare la sua profezia prima ancora della sua morte.
Nel mondo Buddhista ed anche, ogni tanto, nelle parole di Buddhadasa, emerge una tendenza ad identificare il Vinaya, il sistema di regole per i monaci buddhisti, come il modello di una “società socialista”. Questo è, per me, totalmente anacronistico e strutturalmente assurdo. Non dobbiamo dimenticare che il Buddha ha lasciato il palazzo relae: quello è stato il primo atto che il principe Siddharta ha compiuto prima di diventare un Buddha. Lui era, innanzitutto, un rinunciante, un sadhu che, come prima cosa, uscì fuori da tutto ciò che potesse pur lontanamente ricondursi ad una dimensione “politica”. Considerare il sangha come un modello di una società socialista è del tutto incoerente. Certo, il sangha non è fuori dal mondo o fisicamente separato dalla società ma è, essenzialmente, fuori dalle regole normative dell’ordinario contesto sociale, ad esempio il lavoro, i ceti di appartenenza e la riproduzione sessuale. L’unico legame strutturale tra il sangha ed il mondo è la mendicità, il rapporto quotidiano tra i laici e la ciotola delle elemosine dei monaci. È un legame che esprime, paradossalmente, il carattere alieno del monaco mendicante libero da ogni obbligo sociale. Tutti i rinuncianti vivevano e vivono ancora oggi in una dimensione che non conosce caste. Tuttavia il Buddha non pretendeva di abolire le caste o le classi nel mondo ordinario. Non era affar suo. Un libro molto interessante da leggere è Sadhus, di Patrick Levy che ha vissuto da sadhu, in India, per uno o due anni. Leggendo quel libro si capisce cosa fosse il Buddhismo in origine, nella misura in cui lo stesso Buddha ed i suoi discepoli vivevano come vivono i Sadhus ancora oggi. Il problema con i monaci e le persone che sostengono che il sangha sia il modello di una società egalitaria è che a loro sfugge quello che è stato il primo passo che avrebbe successivamente portato alla nascita stessa del Buddhismo: da rinunciante o da sadhu il Buddha ha rifiutato le responsibilità mondane per il perpetuamento della società laica. Certamente, nel corso della storia, comunità monastiche — buddhiste o cristiane — hanno influenzato i loro rispettivi ambienti circostanti ma non come modello di organizzazione interna. Certamente comunità monastiche — buddhiste o cristiane — possono essere oggi gli unici posti dove il comunismo si è realizzato ma questo, esattamente, nella misura in cui non giocano alcun ruolo nel mondo laico. Di conseguenza, prenderle a modello per una società laica è del tutto illogico!
 Per venire alla sua successiva domanda, accanto a Buddhadasa Bhikkhu e ad Achan Cha esistono molti altri monaci famosi ed influenti che meriterebbero di essere qui menzionati ma mi vorrei soffermare su uno di loro in particola: Prayudh Payutto (nato nel 1938; nella foto). Per me rappresenta il modello del monaco di tradizione Theravada tailandese. Conosce perfettamente la dottrina (Dharma) e la disciplina (Vinaya). È la voce del Dharma-Vinaya e, in un certo senso, la voce del Buddha per come il Buddhismo Theravada lo ha compreso sino ad oggi.
Per venire alla sua successiva domanda, accanto a Buddhadasa Bhikkhu e ad Achan Cha esistono molti altri monaci famosi ed influenti che meriterebbero di essere qui menzionati ma mi vorrei soffermare su uno di loro in particola: Prayudh Payutto (nato nel 1938; nella foto). Per me rappresenta il modello del monaco di tradizione Theravada tailandese. Conosce perfettamente la dottrina (Dharma) e la disciplina (Vinaya). È la voce del Dharma-Vinaya e, in un certo senso, la voce del Buddha per come il Buddhismo Theravada lo ha compreso sino ad oggi.
Prayudh Payutto può essere considerato un equivalente di Henri de Lubac (1896-1991) nell’ambito della teologia cattolica o di Karl Barth (1896-1968) di quella protestante. Con una fondamentale differenza: nella cristianità, i teologi riformulano periodicamente il sistema teologico cristiano perché Gesù non lo ha mai fatto. Sono liberi di farlo ed anche incoraggiati in quella direzione. Nel Buddhismo Theravada, invece, il Buddha ha formulato, perfettamente ogni cosa una volta per tutte. Di conseguenza, i maestri buddhisti Theravada possono solo richiamare —mai riformulare— l’insegnamento originale. Prayudh Payutto è accusato di essere troppo conservatore ma come puoi davvero essere un monaco buddhista Theravada senza essere conservatore? È nell’essenza stessa del Buddhismo Theravada essere conservatore. Di conseguenza, accusare un maestro Theravada di essere conservatore è del tutto assurdo.
Accanto ad un’élite monastica e di maestri di meditazione divenuti celebri anche in Occidente, la maggior parte dei monaci del sangha thai mantengono, con discrezione, il sistema in funzionamento, nei diversi monasteri e nelle diverse province. Perpetuano il Buddhismo per come è non senza essere, per molti versi, sorprendenti: richiedono conforti materiali quando il Buddha vi aveva rinunciato, talismani quando il Buddha ha ripetuto chiaramente moltissime volte che ciascuno debba prendere rifugio in se stesso/stessa, “vita” quando il Buddha non si stancava di dire che la morte è inevitabile, il paradiso quando, potremmo metaforicamente dire, il Buddha lo ha rifiutato, la cancellazione del karma negativo quando la legge del karma è immutabile, eccetera. Così, parlare di Buddhadasa, Cha, Prayut o di maestri di meditazione non è sbagliato ma rischia di farci dimenticare la maggior parte dei monaci che tentano di fare il loro lavoro ordinario rispondendo ai bisogni ordinari del popolo. Malgrado alcuni scandali, amplificati dai media, per comportamento immorale nell’ambito della sessualità e di questioni finanziarie, rappresentano ancora una guida morale nel mondo rurale. Per quanto ancora? Una bella domanda!
Ci sono anche molte donne che guidano gruppi di meditazione. Questo è alquanto nuovo perché fino a 50 anni fa non c’erano così tante persone che trascorrevano due o tre giorni o due o tre settimane in ritiri di meditazione guidati da un maestro o una maestra. Non stiamo parlando abbastanza di questo fenomeno ma, bisogna riconoscere, è molto vitale!
Lei si considera un meditatore?
Praticare la meditazione buddhista è come, per un musicista, far pratica con le scale musicali…ma le scale non sono la musica.
Le sessioni di meditazione servono ad allenare la mente al silenzio e le persone a non cadere nelle varie trappole del desiderio. Sono utili e, probabilmente, necessarie ma personalmente non sento la necessità di seguire questo genere di sessioni ora. È, naturalmente, buona cosa che le persone lo facciano ma non di rado finiscono per rivelare una “discreta vanità”. Di sicuro la meditazione è o dovrebbe essere una pratica terapeutica, prima di tutto in Occidente dove nessuno ha un secondo per pensare al modo in cui pensa o alle ragioni per cui pensa ciò che pensa. Personalmente sono cresciuto come cristiano. Ho praticato la meditazione cristiana che, pur in maniera diversa, ha il fine di mantenere la mente nel giusto tracciato. Ho anche riflettuto su molte cose stupide che ho fatto e sulle radici delle mie sofferenze. In generale provo ad osservare le mie attitudini e le mie parole e quelle degli altri con una mente distaccata, ragion per cui non sento la necessità di sedere per un’ora osservando il mio respiro scendere e salire. Provo ad osservare la mia mente in ogni momento, in ogni situazione, tanto quando accade qualcosa di usuale quanto di inusuale. In ogni momento della propria vita bisognerebbe essere in grado di esercitare il giudizio discriminante che i buddhisti sostengono si possa acquisire attraverso la pratica meditativa. Non possiamo certo pensare che il Buddha intendesse formare le persone per trovare il proprio centro solo in “condizioni artificiali” o solo per il piacere, più o meno masochistico, di ripetere scale all’infinito. I buddhisti affermano spesso di “praticare” (patibat) quando si cimentano in sessioni di meditazione. Preferisco pensare che la vita reale sia la reale pratica. L’allenamento alla meditazione può essere giustificato se insegna a gestire gli eventi quotidiani, le emozioni quotidiane di modo che, al di là delle scale, si possa essere in grado di trasformare la nostra vita in musica vera.

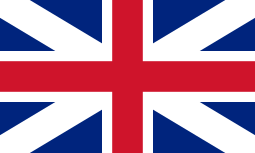 English
English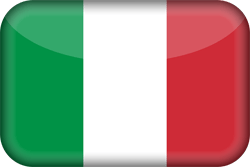 Italian
Italian